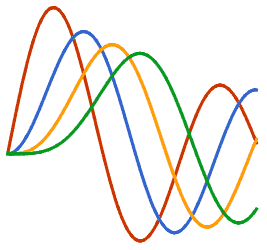Deboli, svantaggiati - Gemma Brandi - 23/11/2022
I bisogni veri delle persone
Qualche anno fa, in quel di Vallo della Lucania, in un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura fu ricoverato, contenuto e trattato crudelmente un uomo bisognoso di cure, non di noncuranza. Le telecamere fissarono le scene di quell'odioso comportamento sanitario, della indifferenza e dell'abbandono in luogo della premura e delle attenzioni. La condanna etica e professionale, prima che giudiziaria, da riservare al personale responsabile del maltrattamento che esitò nella morte dell'uomo, deve essere sottoscritta da tutti coloro che si occupano di Salute Mentale: una condanna senza appello. Se ne è al contrario parlato poco, a mio avviso. E' accaduto però che, all'interno di un convegno organizzato in Friuli da Paolo Cendon, Beppe Dell'Acqua, allora responsabile del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, proiettasse quelle scene per indicare la inappropriatezza dell'istituto TSO in sé. Lo fece platealmente. Mi opposi sul posto alla condanna di un istituto in virtù del suo cattivo uso, io che quel cattivo uso ho sempre preso ad esempio per indicare ai miei collaboratori quello che non si deve fare e quello che si deve fare di fronte a un portatore di sofferenza psichica non compliant le cui condotte reclamano, per chi sappia intendere, la luminosa virtù del limite. Luminosa e virtù, dunque il contrario della accidia istituzionale e della indifferenza opaca. L'accaduto in quella circostanza a Vallo della Lucania è diventato esemplarmente negativo e quindi utile a segnalare l'esemplarmente positivo che non può essere "la libertà è terapeutica" o "il TSO è una macelleria". Quando si tratta la sofferenza severa occorrono strumenti, inclusa la forza, da non confondere con la violenza.
Allo stesso modo non trovo compatibile con una indispensabile serietà operativa, il fatto che si liquidi come dannoso un istituto, quale la Amministrazione di sostegno sarebbe, se qualcuno non approfittasse della stessa per loschi traffici, per perpetrare soprusi, per annichilire l'altro fragile. Sappiamo che tutto questo può accadere e accade. Noi però che questo strumento di lavoro abbiamo sapientemente utilizzato, che potremmo dimostrare come almeno otto condizioni psicopatologiche maggiori non potrebbero essere affrontate senza il medesimo; noi che abbiamo tentato di lavorare su tavoli locali e nazionali alla limitazione dei rischi che l'Ads si porta dietro -giungendo a un passo dalla soluzione, passo che dovrebbe essere fatto da chi può deciderlo, essendo disponibili i materiali per concretizzare la riduzione del danno da cattiva gestione della Ads-, si porta dietro, dicevo, come effetto contaminante e malcostume della interdizione (tra questi l'uso inveterato di ricorrere quasi soltanto agli avvocati, in mancanza di familiari disponibili e idonei, per lo svolgimento della funzione, come accadeva per tutori e curatori); noi che abbiamo cercato ogni volta di orientarci e di salvaguardare la sovranità del fragile; ebbene noi troviamo intollerabile che si pensi di liquidare l'istituto dell'Ads al grido di slogan come "il diritto alla follia". Certe grida vanno argomentate scendendo dal pulpito delle ideologie o del clamore, per comprendere quali siano i bisogni veri delle persone, quale il percorso di salute da indicare. Tutto ciò diciamo mentre pretendiamo che non cali il silenzio sugli errori commessi, che anzi questi abbiano la massima esposizione, perché la sofferenza dell'altro non smette di toccarci, di commuoverci, di provocarci. Non la gogna, certo, ma il riconoscimento pubblico di una colpa insopportabile tanto quanto era, per l'Antico Testamento, il Giudice Ingiusto, additato dalle scritture come il peccato che precede in ordine di gravità la stessa idolatria