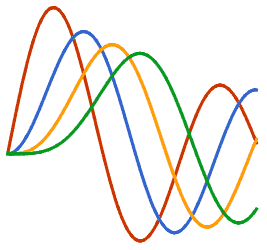Giustizia civile - Elvira Reale - 29/11/2021
L’ingiusto processo e l’ideologia pervasiva della PAS nel solco di un orientamento misogino delle scienze psico-giuridiche - Associazione Salute Donna
Nell’ambito dei procedimenti civili di separazione e affido, in rapporto ad allegazioni di violenze che non vengono valutate né dai giudici né dai consulenti, - ignorando l’ipotesi di colpevole ignoranza da parte di queste due categorie di soggetti circa la Convenzione di Istanbul, legge 77/13 dello Stato Italiano e dei suoi articoli 26, 31, 45, 46, 56 che riguardano la tutela congiunta e specifica di un minore oggetto di maltrattamento assistito - si dispiega un repertorio possente di discriminazioni e svalutazioni legate al sesso femminile, degno di una secolare museografia misogina.
Esamineremo, quindi, i modi e gli strumenti della vittimizzazione secondaria - secondo quanto indicato dalla CdI (art. 15;18); dalla Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo per la tutela delle vittime di reato (in particolare la premessa Parag. 17 e gli artt. 18 e 19, 22 e 23), dalla Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n.10959/ 2016 - in una prospettiva di disparità di trattamento, discriminazioni sessiste e misoginia.
Iniziamo dalla interpretazione, miope e/o falsata, del cosiddetto “principio della bigenitorialità”, introdotto a partire dalle Convenzioni Internazionali (New York 1989, Strasburgo 1996) e dalla legge 54/06 in Italia. Questa legge ha intercettato, oltre i diritti del minore stabiliti a livello internazionale, anche le istanze di pari opportunità, che dovevano in qualche modo assicurare la presenza del padre sulla scena della famiglia. Ma è stato ben presto chiaro che questo principio poteva essere utilizzato per limitare o scalzare la presenza materna e posizionare, in modo preferenziale, la presenza del padre il quale, nell’ambito delle cure e responsabilità nella vita quotidiana dei minori, era sempre stata una figura collaterale se non assente. Per fare questo era necessario un’operazione di restyling della norma: sul punto della trasformazione attuata attraverso una falsa interpretazione, si sono inserite le lobby dei padri separati che intanto di affacciavano numerose, messi in crisi nel tradizionale rapporto di dominio con le loro partner in virtù di prassi di tutela delle donne dalla violenza maschile. La falsa interpretazione della norma, riferita alla legge 54, è poi transitata nel decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 (L. 219/12). Ambedue le leggi vengono declinate e fatte valere infatti solo parzialmente: la legge 54/06 è interpretata dai più sempre e solo nell’articolo 155, mentre l’art. 155/bis subisce un’immotivata e dolosa tagliola; stesso destino subisce il decreto legislativo 154/13: l'art. 337 quater, che sostituisce l'art. 155 bis, cade nel dimenticatoio. Così, in un gioco di specchi, ciò che compare alla coscienza collettiva e viene veicolato nelle aule giudiziarie, nonostante sia frutto di una falsa interpretazione, è il diritto del minore a mantenere una relazione con entrambi i genitori, considerato erroneamente prioritario e incondizionato. Il pregiudizio misogino, racchiuso poi in questa falsa interpretazione della legge, si disvela nel corso dei tanti procedimenti quando, inopinatamente, una volta raggiunto l’obiettivo di inserire il genitore escluso (il padre) nella vita del minore (a prezzo di gravi traumi) la c.d. bigenitorialità viene platealmente abbandonata al suo destino processuale e il bambino - una volta ricondotto nell’alveo della genitorialità paterna - non avrà più necessità di mantenere la relazione con il genitore di sesso femminile, allontanato sine die o tenuto in situazione di vergognosa limitazione della libertà e gogna sociale, quale “madre inadeguata”, nonostante nulla abbia fatto di inadeguato.
La bigenitorialità diviene così un grande imbroglio e pregiudizio misogino contro le donne, perché, una volta deprivata dei paletti che la configurano come diritto relativo ad una buona prassi di cura da parte dei due genitori (e certo il genitore violento non può essere considerato un genitore adeguato) si trasforma subito nel diritto del minore alla monogenitorialità paterna, restaurando in toto la condizione di preminenza del diritto paterno e la posizione gerarchica dell’uomo, preesistente in Italia fino all’entrata in vigore della Legge n°151 del 19 maggio 1975 di riforma del diritto di famiglia.
In questo furto della genitorialità materna a vantaggio di quella paterna (costruito surrettiziamente nell’ambito di una legge neutra e vessillo di pari opportunità uomo-donna, come la legge 54 del 2006) hanno sicuramente una primaria responsabilità i giudici che scrivono sentenze poco approfondite e che sembrano ignari dei processi storici alla base dell’evoluzione delle stesse norme.
Ai giudici va attribuita la colpa maggiore di non utilizzare, nell’ambito dei procedimenti che riguardano la famiglia, gli strumenti che competono alla giustizia, ovvero la valutazione dei fatti, la raccolta delle prove, l’ascolto dei testimoni e soprattutto dei minori, nei casi di affido controverso. I giudici evadono quindi le loro responsabilità e i loro compiti di preparare adeguate istruttorie, quando si tratta di materia di famiglia, preferendo invece delegare ai tecnici e dando a costoro un potere d’azione, che si rivela il teatro principale su cui si celebra la penalizzazione delle donne e l’ inferiorizzazione/secondarizzazione del loro ruolo rispetto a quello paterno.
In carenza di un’istruttoria, o di atti equivalenti finalizzati a una piena cognizione dei fatti, che consentano di valutare, in autonomia, gli atti pendenti nel penale o comunque allegazioni e dichiarazioni assunte dalle testimonianze delle donne vittime di violenza, o da terzi come i centri anti-violenza, si sviluppa la prassi abituale di delegare ai consulenti la valutazione del migliore affido. Si ritiene così, medicalizzandolo impropriamente, che il problema sia di pertinenza della psicologia e vada affidato alla valutazione prioritaria dei consulenti, chiedendo loro di stilare profili di personalità, di valutare la presenza di patologie, surrogando anche qui impropriamente il SSN, e ottenendo interpretazioni soggettive di stampo clinico secondo le variegate teorie astratte di riferimento.
Ci spostiamo qui, da una colpevole mancanza di istruttoria in capo ai giudici, al terreno fertile delle consulenze per quanto riguarda il proliferare di pregiudizi contro le donne. La mancanza di una valida istruttoria è elemento fondamentale del travisamento dell’attività probatoria quando affidata al consulente; il suo effetto fondamentale è la sostituzione dei fatti e dei comportamenti con percezioni, vissuti, ed anche materiale inconscio, trasferito ‘di regola’ dalla valutazione dei consulenti alla parte motiva di provvedimenti e decreti, ponendo le basi di quella distorsione procedurale che è stata appena censurata da un’ultima Ordinanza di Cassazione, la numero 13217 del 22 gennaio 2021.
Le consulenze tecniche sono di frequente un museo degli orrori per quanto riguarda la raccolta degli indicatori di pregiudizio sulle donne e il loro ruolo genitoriale, che di fatto viene rappresentato come ancillare rispetto al ruolo paterno.
Brevemente cominciamo la nostra analisi dalla PAS che, al di là della sua acclarata ascientificità, è costrutto profondamente impregnato di misoginia quando apprendiamo, dalle parole dello stesso autore, Richard Gardner, che esso riguarda le madri che sono il 90% dei genitori alienanti (1). Ma come afferma Patrizia Romito, Gardner veicola in generale l’immagine di una donna isterica, sessualmente deprivata considerandola potenziale vittima masochista di stupro, che prova piacere nell'essere picchiata. Riguardo poi alle ragioni che indurrebbero una donna separata a montare una falsa accusa di abusi sessuali contro l'ex marito, sostiene che «l'inferno non conosce furia uguale a quella di una donna che è stata disprezzata» (hell hath no fury like a woman scorned)(2).
La PAS, infatti, incorpora e da rappresentazione a una serie di figure femminili e materne negative: la madre malevola, la madre simbiotica, la madre appropriatrice, ostacolante, la madre patologica ecc. Tutte queste valutazioni pseudo-diagnostiche riguardano il mondo femminile e hanno una chiara connotazione sessista, non essendo mai utilizzate per i padri in via speculare o per ‘pari opportunità’. La PAS, come altre valutazioni psicologiche che riguardano le donne, ha in prevalenza una connotazione fortemente misogina: esse sviluppano l’idea di una madre pericolosa e negativa, a cui fa da pendant un aspetto preciso della vittimizzazione secondaria da parte delle istituzioni, ovvero la mancata attribuzione a lei di un ruolo di vittima incolpevole nella violenza domestica. Nell’ideologia maschile e patriarcale, veicolata anche da donne, giudici e psicologhe, prevale l’idea di una donna prevaricatrice ed onnipotente lontana dall’immagine di vittima incolpevole nella relazione con un uomo.
Gardner, ad esempio, descrive la PAS come una sindrome in cui “le madri vendicative hanno impiegato le accuse di abusi sui minori come un potente arma per punire gli ex mariti e garantirne la custodia a se stessi” (Gardner, 1992a; 1992b). Gardner ha inoltre teorizzato che tali madri hanno arruolato i bambini nella loro "campagna di denigrazione" e "diffamazione" del padre, che spesso hanno "lavato il cervello" o "programmato" i bambini facendogli credere alle false affermazioni di abuso da parte del padre, e che i bambini poi hanno fabbricato con il contributo delle proprie storie (Gardner, 1992b). Ha anche affermato – basandosi esclusivamente sulla sua interpretazione della propria esperienza clinica – che la maggioranza di denunce di abusi sessuali su minori nel contenzioso in materia di custodia sono false (Gardner, 1991)(3).
La PAS è penetrata profondamente nella cultura di consulenti e giudici nelle aule dei nostri tribunali, in modo da orientare la valutazione del comportamento delle madri giungendo a questo pericoloso assioma “that a woman who is assertive or self-protective is an alienator” e ancora: “se una donna appare diffidente e/o protettiva nei confronti di se stessa o di suo figlio, un valutatore esperto nelle tecniche di Gardner tenderebbe a caratterizzarla come paranoica e non collaborativa, qualità che Gardner considera forti indicatori che la donna è un "induttore PAS”(4) .
L’ideologia della PAS, diventata specchio di una realtà distorta e misogina, si riscontra nei mille profili evidenziati dai consulenti, nel profilo della madre protettiva, della madre simbiotica, fagocitatrice, possessiva ed escludente, malevola nei confronti del terzo (il padre) vissuto come intruso
Il costrutto PAS apre il problema grave della vulnerabilità del nostro sistema giudiziario rispetto al verbo della psicologia che - attraverso molti dei suoi rappresentanti - millanta credito e si presenta come uno strumento chiave per raggiungere la verità all’interno del mondo delle relazioni intime, sostituendo i propri procedimenti interpretativi o ri-definitori a quelli accertativi della giustizia.
Ma il metodo clinico della psicologia e della psichiatria non può sostituire il metodo giudiziario; lo strumento clinico – terapeutico non può divenire un mezzo di prova.
La psicologia come la psichiatria, figlie della medicina, nascono in funzione della cura e della prevenzione delle malattie del corpo e della mente. Sono scienze cliniche che svolgono la loro attività al letto del paziente nella relazione stretta con il singolo individuo. In questa relazione con il paziente e la sua salute hanno la loro mission e possono bene operare. E su questo obiettivo sono stati codificati i loro strumenti diagnostico-valutativi. Si avvicinano al paziente per individuarne i disagi e i cattivi funzionamenti (che non sono necessariamente comportamenti-reato) così come percepiti e vissuti dal paziente stesso e non da altri, per condurlo attraverso un percorso individuale e intra-soggettivo, da uno stato di malessere a uno stato di benessere, il migliore possibile, stanti determinate condizioni di partenza. La medicina e le sue consorelle (psicologia e psichiatria) stabiliscono sempre un rapporto duale, dove il committente è sempre uno, un solo paziente alla volta senza interposizioni di terzi, (solo quando vi è un minore si fa riferimento all'adulto responsabile della cura), perché queste interposizioni risulterebbero fuorvianti sia a livello della comprensione e valutazione diagnostica del disagio individuale, sia a livello della definizione della cura. Immaginiamo possibile forse che un paziente con disturbo cardiovascolare possa essere intervistato sui suoi sintomi e difficoltà, non direttamente ma attraverso un terzo, che garantisca più oggettività nel riferire e rappresentare i segnali del suo disagio? Non sarebbe possibile. Soggettività e oggettività in medicina per molti versi coincidono, e anche i vari test diagnostici, se non sono riportati al quadro clinico generale, pur se soggettivamente percepito, risultano inefficaci alla comprensione dello stato individuale di una malattia/disagio (5).
In sintesi, la funzione di diagnosi e cura delle scienze umane ha valore in rapporto alla relazione diretta con il paziente; ogni deviazione da questo rapporto alterala funzione ma anche i costrutti scientifici di queste scienze, creando le premesse per distorsioni concettuali, errori valutativi, sotto o sopravalutazioni, ma soprattutto aprendo le porte a pregiudizi personali.
La psicologia forense, che oggi occupa la grande maggioranza dell’attività consulenziale presso i tribunali, invece non riconosce se non astrattamente la differenza tra metodo diagnostico-terapeutico - che può veicolare, in modo appropriato ma solo in ambito clinico, i criteri sia diagnostici sia interpretativi delle proprie teorie di provenienza - e il metodo osservativo-descrittivo-esplicativo di comportamenti, applicato in una prospettiva di analisi del contesto storico-dinamico (comprensivo anche delle differenze uomo-donna) in cui le relazioni familiari si inscrivono. Questo metodo, alternativo a quello interpretativo, più consono alle aule dei tribunali, è adatto a veicolare al giudice i riferiti delle persone senza interpolazioni soggettive, e ad inserire in modo separato dai riferiti anche una valutazione degli stessi in una cornice che si rifà alla storia personale, relazionale e di comunità dei soggetti, ovvero rappresentativa del modo come le relazioni si sono svolte fino al momento d’ingresso nei tribunali, sia in riferimento alla coppia (con le differenze di potere al suo interno) sia in riferimento alle cure (o non cure) dispiegate nei confronti dei minori, acquisendo informazioni sullo sviluppo del minore oltre che dal caregiver di riferimento anche dal contesto e dai testimoni privilegiati qualificati (insegnanti, pediatri, ecc.). La psicologia cd. forense invece offre (a prescindere dalla storia delle relazioni tra partner /genitori e dalla storia comunitaria che accompagna e disegna il contesto delle relazioni familiari) la sua chiave interpretativa che considera, in modo astratto e apodittico, non commisurato alla realtà dei singoli casi, le relazioni intime come circolari, chiuse all’ambito familiare, e dislocate su un piano paritario; questa chiave di lettura si chiama CONFLITTO, con due attori che lo alimentano pregiudizialmente alla pari, e dove non vi possono essere mai individuati vittime o carnefici. Unica vittima è il minore che risente del conflitto genitoriale; ed è quindi, nell’interesse del minore, che va in ogni modo dismesso il conflitto e la relazione genitoriale va sempre pacificata, pena la perdita della genitorialità. Ma se non vi sono vittime e carnefici in linea teorica, in pratica quando il conflitto nasce dalla violenza maschile, le donne assumono nelle valutazioni dei consulenti il ruolo di carnefici perché non depongono le armi, ma anzi le agitano come protezione verso se stesse ed i figli, reclamano poi i diritti dovuti di tutela anche da parte delle istituzioni; per converso, non potrà mai emergere la responsabilità dell’uomo nel conflitto, generato da violenza; anzi proprio nelle situazioni di violenza, se la donna diviene carnefice (responsabile cioè del conflitto), l’uomo viene eretto a vittima e i suoi diritti genitoriali difesi ad oltranza, intrecciandoli con la difesa dei diritti del minore a mantenere la relazione con il padre e con ciò stesso a perseguire l’obiettivo di un sano sviluppo.
Da qui nasce la vera e propria persecuzione contro le donne, a cui i consulenti attribuiscono ogni maleficio, inconscio e conscio, ogni “danno” che colpisce l’uomo e anche il minore, nel suo rapporto desiderato (inconsapevolmente, anche se visibilmente rifiutato) con il padre. Gli psicologi giocano nei tribunali con le luci e le ombre di ciò che è consapevole o di ciò che è inconscio riuscendo sempre a portare la valutazione in zona goal, nella zona cioè di attribuzione della migliore genitorialità al padre. L’interpretazione che porta in primo piano presunti vissuti inconsapevoli, non asseverati dai diretti interessati, non può essere ammessa nei tribunali perché confligge con i comportamenti reali e con i dati di fatto su cui si fondano i procedimenti giudiziari e perché distorce le testimonianze delle persone con cui si confronta. Così come non possono entrare nelle aule dei tribunali i pregiudizi sulla maternità e sulla paternità volti a preconizzare rischi evolutivi gravissimi, non avvalorati dalla comunità internazionale, per un minore che rifiuta il padre o da cui il padre viene allontanato, quando violento.
Molte delle teorie di riferimento dei consulenti infatti veicolano un modo dispari di vedere paternità e maternità, dando alla paternità un ruolo di prestigio e di maggiore peso nello sviluppo del minore successivo ai primi anni di vita (suprematismo paterno). Alle donne e alle madri si concede il rapporto duale e simbiotico, prolungamento della gestazione; si concede anche competenza nelle cure materiali e di accudimento primario del minore, ma le si considera per definizione inadeguate nel provvedere al loro ulteriore sviluppo nel rapporto con il mondo esterno ed il sociale, rapporto indicato fondamentale per qualificare lo sviluppo armonico e sano e nel minore. La mancanza/lontananza del terzo, il padre, configura ai loro occhi un grave rischio evolutivo che può traghettare il minore verso patologie e comportamenti criminali (ricerche in tale senso sugli esiti psico-patologici della mancanza della figura paterna sono scarse e non portano alle conclusioni paventate da questi consulenti) . Si parla allora di funzione diadica della madre e funzione triadica del padre, e le funzioni nonostante un’ostentata affermazione di una loro paritarietà ed interscambio, di fatto pongono le due figure su una scala di valori che dà al padre maggiori crediti per il sano sviluppo del bambino, ovviamente senza assolutamente prendere in considerazione la violenza domestica.
Queste teorie sulle diverse competenze tra madre e padre, non rapportate alla storia concreta della cura (né alle teorie sull’importanza del legame del figlio con la madre (6) ), ai reali esiti positivi delle cure dispiegate da parte di una madre per periodi di tempo che vanno al di là dei primi anni, riportano suggestioni e fantasie sul ruolo di una madre, limitato al rapporto simbiotico dei primi mesi, e suggeriscono che la maternità sia naturalmente orientata all’esclusione del terzo (il padre come intruso), autocentrata sulla relazione duale, di contro gli interessi di crescita e di sviluppo del bambino. Sullo sfondo di questa ideologia portatrice di un pregiudizio sessista possiamo iscrivere di nuovo la PAS
A questo proposito in via esemplificativa possiamo mostrare un prototipo di ragionamento di un consulente, che non si riferisce mai alla PAS, né la nomina come sindrome, ma che da essa è permeato, veicolando la rappresentazione di ruoli sessuali intrisi di pregiudizi.
Il consulente in questione, chiamato in causa come al solito per giudicare del miglior affido, comincia con la storia di coppia in cui critica la donna che di fronte al partner violento (per stessa ammissione del partner) opera per una sua modifica, ignorando il valore fallico del comportamento maschile: “L’atteggiamento della signora verso il marito è sempre stato improntato al bisogno di “cambiarlo”, fin dall’inizio della relazione trattandolo al pari di un bambino da educare, correggere e denigrare. Così, mortificato ed esautorato nel suo valore fallico, questi cerca di imporsi, soprattutto nella gestione educativa del piccolo, con scarsi risultati, e ciò provoca in lui reazioni di rabbia e impulsività (il signor ….ammette di aver avuto comportamenti impulsivi e agiti violenti)”.
Il consulente prosegue con una falsa rappresentazione e misinterpretazione delle parole del bambino che riguardano un abuso: a fronte di parole inequivoche del bambino di 5 anni (“ non voglio vedere il mio papà, perché mi ha fatto delle cose brutte.. mi ha messo le dita nel culetto…quindi non lo voglio vedere”), il consulente sembra parlare un’altra lingua che non tiene conto dei riferiti del minore: “In questo scenario, la fusionalità madre/figlio sembra “giustificata” da una concomitante accusa di abuso sessuale che dà corpo ad una condizione di per sé latente, fusiva e confusiva. E’ emersa la tendenza della signora a vedere l’altro come la personificazione e l’attualizzazione di aspetti di sé negati e scissi, rifiutati e combattuti; inoltre, mostra di non riconoscere le proprie responsabilità rispetto alla vicenda separativa”.
Negate le parole del bambino, liquidate sulla scorta di una archiviazione delle stesse nel procedimento penale per “insostenibilità dell’accusa in giudizio” sulla scorta di una CT che dichiarava che i sintomi di disagio non possono essere considerati di per sé indicatori specifici di abuso ( secondo l’ art. 8 della Carta di Noto), si apre lo spazio psicologico per considerare la vicenda separativa di tipo semplicemente conflittuale in cui regna il principio latente della PAS: dove la madre protettiva, che si dichiara e si presenta in modo manifesto come tale, non è altro che il genitore che vuole consapevolmente o inconsapevolmente alienare il figlio al padre.
Il consulente liberato quindi dalla violenza attraverso un’archiviazione che non nega e non conferma ma lascia tutto impregiudicato sul piano dell’accertamento nel civile dell’idoneità genitoriale, procede con l’interpretazione del rischio che il bambino corre, non per il presunto abuso, ma solo se allontanato dal padre, come la madre sta facendo: “Riguardo al processo identificativo, di individuazione e d’identità, emergono forti criticità dovute all’assenza della figura paterna come riferimento identificativo primario adulto e all’eccessivo invischiamento cognitivo con la figura materna marcatamente dominante. ….il bambino sembra essere incapsulato dalla necessità di aderire al patto di lealtà con la madre che necessariamente passa attraverso il rifiuto e la negazione della relazione con il padre….Ciò posto, la scrivente ritiene doveroso sottolineare che, allo stato, vi è una condizione di gravissimo pregiudizio per il minore, a causa dell’allontanamento del bambino dalla figura paterna, rispetto alla quale il bambino ha manifestato un bisogno inconscio di vicinanza e protezione”
Il bisogno inconscio è azionato dal consulente come prova contro i riferiti e le affermazioni nette del bambino e tanto basta per motivare la valutazione del miglior affido da dare al padre.
Il giudizio sul migliore affidamento passa poi anche attraverso le valutazioni sui profili di personalità dei genitori; anch’esse intrise di pregiudizi e disparità nei criteri di valutazione. I due profili ambedue, in questo caso, come nella stragrande maggioranza, sono definiti come non patologici (ricordiamo che la violenza non costituisce mai parte di un giudizio di patologia, riferendosi a comportamenti che riguardano gli aspetti culturali della relazione uomo-donna), ma poi divergono e nel profilo paterno non si dà conto di altro; mentre in quello materno pur non configurandosi allo stesso modo gli aspetti patologici, questi disvelano una presunta serie di disfunzionalità che, pur non essendo patologiche, sostengono il giudizio di inidoneità.
Nella valutazione dei profili quindi, a parte quanto altrove affermato sulla loro incostituzionalità(7), e per altro anche sulla loro non rilevanza ai fini della competenza genitoriale, troviamo un altro modus operandi ispirato a ulteriori gravi disparità di valutazioni donna-uomo/madre-padre. Le disparità si palesano quando, solo per gli uomini, alcuni elementi di un profilo di personalità - che vengono indicati come rivelatori di disagio o di presunte anomalie - sono giustificati come reazioni ai comportamenti dell’altra parte e non vanno a costituire alcuna valutazione negativa da correlare all’idoneità genitoriale. Diversamente succede per le madri, dove ogni elemento del giudizio psicologico va a colludere con una supposta inidoneità genitoriale. In questo gioco di scarica barile delle responsabilità, nelle valutazioni consulenziali di questo tipo, la bilancia pende sempre a sfavore delle madri, che non vedono mai mettere su quel piatto le responsabilità dell’uomo nella violenza. In più troviamo un’altra disparità ed asimmetria in queste consulenze che possiamo definire temporale o statistica ; se infatti non c’è traccia nei profili genitoriali del passato, ovvero della storia della cura, di come cioè i bambini sono stati allevati fino all’arrivo della vicenda in tribunale, ampio spazio viene dato alla dimensione del futuro, ovvero di uno spazio temporale vuoto in cui nulla ancora è stato scritto, ma su cui si discetta di un padre che ‘saprà imparare a fare il padre’ sulla base del desiderio che ha espresso di stare con il figlio e di occuparsene da quel momento in poi. Si parla a volte anche della probabilità che in futuro quel padre potrà essere un buon padre senza alcuna prova di ciò nella sua storia, anzi avendo raccolte prove contrarie. E qui nel ‘futuro’ o nel ‘probabile’ che si inscrive la valutazione della competenza genitoriale maschile affidata tutta ai buoni propositi ed al patto fiduciario che implicitamente il consulente, e attraverso di esso il giudice, stabilisce con l’uomo/padre. E così mai detto comune fu più appropriato a queste vicende processuali: se la strada dell’inferno è lastricata di buone intenzioni , la strada del tribunale non sembra essere da meno per le tante sentenze forgiate sui buoni propositi futuribili e (im)probabili dei padri violenti.
Di seguito il giudizio del consulente sul padre di questa vicenda: “Dall’esame psicodiagnostico non sono evidenziabili, a carico del soggetto, dimensioni critiche, riferibili a condizioni psicopatologiche in atto o, comunque, a problematiche significative, presenti nella struttura della sua personalità. E’, tuttavia, rilevabile una chiara condizione di disagio, fisiologicamente reattivo alla dolorosa vicenda relazionale sperimentata e all’assenza della relazione con il figlio”.
Ancora: “Premesso che non è stato possibile osservare la relazione padre/figlio, si rileva, nel signor…..dai soli elementi acquisiti, la presenza di una probabile adeguata capacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale, per ciò che riguarda sia l’accudimento materiale, sia quello affettivo, oltre che per la gestione degli aspetti normativi, fondamentali, anch’essi, per garantire che l’evoluzione del figlio possa avvenire in maniera integrata e sufficientemente sgombra da dimensioni di disagio e/o disturbo che raggiungano un rilievo clinico”.
Mentre nel padre la condizione di disagio emersa nel presente (ignorando quella riferita nel passato) non è diagnosticata ma giustificata e messa in relazione alla separazione ed alla lontananza dal figlio, per la madre non si usa lo stesso metro di valutare il suo disagio, in relazione ad un altro trauma, ben più impattante, quello riferito alle violenze subite direttamente e quello subìto indirettamente dall’ascolto del racconto del minore circa gli abusi paterni.
Continuando con la disamina del profilo paterno, si valuta come vi sia uno sguardo diverso, giustificatorio per ogni situazione di disagio emersa, tipica è la seguente per cui il padre avrebbe avuto problemi con una propria madre e ciò “lo avrebbe portato a chiudersi a livello relazionale per il timore di essere giudicato e di aprirsi solo se accolto senza remore”. Anche qui per questo disagio personale dell’uomo ecco che spunta la responsabilità della partner colpevole di non averlo saputo accogliere. Dall’analisi del consulente sembrerebbe emergere la presenza di un disagio speculare nei due membri della coppia per le loro vicende familiari pre-coppia. Ma alla donna solo viene attribuita la responsabilità del mancato incastro della relazione a supporto del marito, in linea con il pregiudizio che è la donna a dover essere accogliente e l’uomo (fallico) a dover essere accolto.
Se quindi l’uomo viene salvato dando la responsabilità di tutto anche degli agiti violenti alla non capacità di accoglimento della donna, alla donna non si fa nessuno sconto e viene dipinta come una persona inadeguata, incapace e al limite del patologico: “il soggetto ha mostrato un eccessivo autocontrollo, e pertanto si rileva una scarsa capacità di entrare in contatto significativamente profondo con i propri piani interni e di effettuare un’adeguata discriminazione delle emozioni elicitate dagli stimoli provenienti dalla realtà interna ed esterna; il soggetto tende a proiettare sull’altro ogni responsabilità, ha una visione egocentrica e manca una comprensione adeguata degli stati soggettivi, delle motivazioni e delle caratteristiche stabili delle persone, inoltre manifesta un senso di superiorità nei confronti degli altri. …. Non si rileva, nella signora la presenza di un’adeguata capacità di svolgere il proprio ruolo genitoriale per garantire che l’evoluzione del figlio possa avvenire in maniera integrata…Ancora più problematica risulta, peraltro, la possibilità di confrontarsi con l’altro genitore che, di fatto, la signora ha totalmente escluso dalla vita del bambino; Dall’analisi del profilo personologico della signora e dall’osservazione e valutazione psicodiagnostica del minore emergerebbe una condizione pre-edipica fusionale, in cui non sembra essere avvenuta la naturale evoluzione verso una condizione di triangolazione edipica; viene a mancare, cioè, la fondamentale funzione del paterno come elemento “terzo” in grado di sancire la separazione differenziante dalla fusione duale “.
Giudizi quindi, come si diceva, basati su una teoria astratta che nulla può dire sulle reali competenze genitoriali, se non l’appello al mancato passaggio al ‘terzo’.
Nessun fatto degno di nota è riportato nella valutazione della idoneità genitoriale materna e per converso paterna (anche quando vi sarebbe da valutare l’impatto dei comportamenti improntati alla violenza, ma questi essendo ‘reati’ a parere dei tecnici vanno espunti dai procedimenti del civile e relegati al solo procedimento penale!), ma solo costrutti e modelli astratti. E’ chiaro quindi come ciò possa divenire un elemento di distorsione del procedimento giudiziario sull’affidamento; quando infatti un giudice si trova di fronte ad una dissertazione motivazionale sulle idoneità genitoriali fatta in linguaggio psicologico criptico, senza un excursus logico, comprensibile e lineare, senza agganci diretti nella vita quotidiana, egli ha allora solo la possibilità, di accettarlo o rigettarlo in toto. E se, come succede il più delle volte, lo accoglie in toto (stante il rapporto fiduciario con quel consulente scelto in modo personalistico) riportandone ampi stralci per motivare il provvedimento, sostituisce al ragionamento giuridico quello astratto e denso di vizi logici dei consulenti. Il risultato di tutto ciò è che il decreto o il provvedimento apparirà da un lato come una copia di una cartella clinica, dall’altro lato come una incolpazione immotivata della donna alla stregua del processo inquisitorio senza prove.
Contro questi procedimenti privi di logicità e di stampo inquisitorio riesce difficile ad una donna, vittima di violenza, opporsi con la logica ed i fatti desunti da una storia di una buona genitorialità che può essere testimoniata dal contesto e dalla comunità di appartenenza. Se alla sbarra i giudici, attraverso gli psicologi, chiamano l’inconscio, allora tutto diventa possibile e tutto si capovolge in uno scenario in cui non valgono fatti obiettivi e provati ma solo percezioni, proiezioni, congetture ed interpretazioni soggettive rispondenti a teorie astratte fuori contesto, e anche fenomeni paranormali come il ‘trasloco di vissuti’, e soprattutto fantasie misogine che vedono l’universo popolato da madri malevole. In questo scenario da tempo delle streghe trovano ampio spazio i pregiudizi sulle donne veicolate da teorie che - se non visitate con spirito critico - riflettono i pregiudizi ancestrali sulla donna. Infatti le teorie psicologiche, a cui oggi si riferiscono i consulenti, si sono formate a cavallo tra la metà dell’800 e del 900, quando ancora era dominante una visione ancillare della donna e la maternità stessa era il campo prioritario/ esclusivo dell’attività femminile ma in una posizione sempre di dipendenza dall’uomo e dalla parola autoritaria del padre.
Se la psicologia non si fa critica di se stessa, come è successo alle scienze mediche, quando hanno cominciato a parlare di medicina di genere o della differenza sessuale, e non riparte dalla consapevolezza di essere veicolo di pregiudizi che negano per altro la violenza domestica, non può essere abilitata a entrare nelle aule di giustizia senza provocare danni a donne e minori, concorrendo a dare spazio ad un processo ingiusto.
Sempre seguendo il filo rosso di questi processi ingiusti (le donne parlano di questi processi di affido, terminati con l’allontanamento dei figli, come femminicidi in vita), e di come le consulenze incidono e vengono ripotate in sentenze e decreti, si ha la netta sensazione di esser stati catapultati nel Tribunale della Santa Inquisizione che nel 1487, ad opera di due monaci domenicani, Johann Sprenger ed Heinrich Kraemer, ideò un manuale investigativo, il Malleus Maleficarum (il martello delle streghe), che fu un vero "capolavoro" su come realizzare un ingiusto-processo e costruire prove da costrutti e tesi indimostrabili.
Se lo vogliamo applicare al nostro contesto possiamo vedere come la posizione delle madri, vittime di violenza, non abbia possibilità di scampo nei nostri tribunali. Se una madre denuncia, e si mostra quindi protettiva con il figlio, allontanando il padre, essa si macchia del peccato dell’alienazione foriero di presunti gravi rischi evolutivi per il bambino; se non denuncia e sta zitta sarà considerata complice, essa stessa maltrattante, in una parola sarà denunciata e ritenuta colpevole per aver fallito nel suo ruolo di tutela (failure to protect).
1. Gardner, R.A. (2001). Parental Alienation Syndrome (PAS):Sixteen Years Later. Academy Forum, 2001, 45(1):10-12
Gardner, R.A. (2002). Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: Which Diagnosis Should Evaluators Use in Child Custody Disputes? The American Journal of Family Therapy, 30(2), 93-115
2. Gardner, R.A. (1992b). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. pp. 218-19
3. Gardner, R.A. (1992a). The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.
Gardner, R.A. (1992b). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics
Gardner, R.A. (1991). Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.
4. Dallam, S. J. (1999). Parental Alienation Syndrome: Is it scientific? In E. St. Charles & L. Crook (Eds.)
5. Mazzeo A., Reale E., Pignotti M., “La manipolazione del processo attraverso le perizie– Trib. Cosenza, 29.7.2015 -”, in Questioni di Diritto di Famiglia, Maggioli Editore, 18.2.2016
6. A titolo di esempio, cfr. gli studi effettuati da Edward John Mostyn Bowlby a partire dal 1951; il legame prenatale con la madre descritto dalla ricercatrice Catherine Dolto; gli studi sull’importanza della continuità della figura materna come caregiver primario, condotti da Joan L. Luby, della Washington University e psichiatra infantile al St. Louis Children’s Hospital.
7. Reale, E. L’insussistenza del diritto alla bigenitorialità e l’incostituzionalità dei profili di personalità, Ora Legale News, 29 ottobre 2021
Allegati