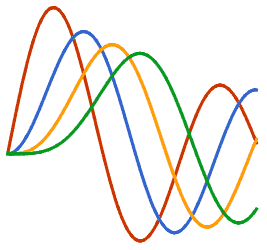- Sisto Patrizio - 23/07/2016
Corpi sofferenti e parole. Riflessioni attuali sulla medicina narrativa (prima parte) - Patrizio Sisto
Ultimamente può accadere sempre più, frequentando il mondo medico anglosassone o percorrendo le relative vie del web, di imbattersi nell"espressione "medicina narrativa".
"Medicina" e "narrazione", diciamolo subito, sono due termini che sembrano a tutta prima fare a pugni fra loro: è inevitabile sentire la distanza se non l"estraneità tradizionale dei loro rispettivi campi semantici.
Ci si può allora domandare come sia superabile questo attrito percettivo e cognitivo, ponendo lo sguardo sull"attuale statuto della medicina narrativa, che ha radici alla fine degli anni sessanta del secolo scorso negli Stati Uniti in ambienti medici a ispirazione religiosa, animati da preoccupazioni di umanizzazione della medicina, e che approda oggi a un crescente numero di università che ne prevedono l"inclusione in qualche forma. D"altra parte il General Medical Council in Gran Bretagna ha varato negli anni scorsi un documento programmatico per la formazione dei medici che sancisce l"importanza delle competenze comunicativo-relazionali ed etiche nella pratica medica.
La medicina, va ricordato, è un approccio alla terapia e cura delle malattie che riflette di volta in volta la cultura e visione del mondo dominante nelle diverse epoche storiche, e si regge a tutt"oggi prevalentemente sul cosiddetto modello biomedico, che secondo una definizione largamente condivisa considera le malattie come entità biologiche o psicofisiologiche universali, dovute a lesioni o a disfunzioni psicosomatiche, che determinano segni quantificabili attraverso procedure cliniche o di laboratorio, e che producono sintomi visibili in un insieme definito di disturbi.
Il modello biomedico ha generato sicuramente fondamentali passi avanti nel debellamento delle malattie gravi, nel miglioramento generale della qualità della vita della popolazione e nel suo allungamento, ma ha anche, al contempo, comportato un frequente oscuramento, se non una vera dimenticanza, di quelle componenti della malattia che si riferiscono alla persona intesa nella sua globalità, sul piano emozionale ed esistenziale. Quelle componenti cioè che ci rammentano che la medicina non ha a che fare solo con malattie da descrivere e categorizzare secondo modelli standardizzati e universali, ma che prima ancora si confronta con esseri umani, fatti sì di corpi appartenenti a una comune specie, ma anche di un costitutivo corredo emozionale, ideativo, esperienziale, espressivo, ogni volta unico e irripetibile per ciascuna persona.
In questo contesto si inserisce a buon diritto il ruolo di quello cha da pochi decenni è conosciuto nella teoria e nella ricerca psicologica come "pensiero narrativo", secondo cui "ognuno di noi è il risultato di una storia personale, in continuo divenire", e il "narrare" si configura come la modalità fondamentale con cui il pensiero dell"uomo interpreta la realtà delle proprie vicende di vita e delle relazioni umane, e quindi si presenta come strumento principe nelle svariate circostanze ordinarie e straordinarie dell"esistenza per conferire senso a se stessi e al mondo.
Se le storie raccontate si presentano come la modalità specificamente umana con cui si organizza la propria biografia e quella del sistema familiare e del contesto sociale in cui siamo collocati, presupponendo sempre qualcuno che racconta e qualcuno che ascolta, allora anche il paziente come ogni essere umano in quanto tale è, direbbe un pensatore psicanalitico come Jacques Lacan, un "parlessere", qualcuno che innanzitutto racconta al medico la sua storia biografica personale, nella quale si colloca la storia della sua malattia.
Ebbene, guardando al rapporto medico-paziente secondo questa luce, è possibile reperire, ci dice la medicina narrativa, almeno due distinte dimensioni ugualmente importanti e preziose per la cura.
Infatti oltre a individuare e spiegare il disturbo del paziente, quello descritto come desease, oggetto di lettura dei sintomi secondo una nosografia sistematica, emerge per la medicina narrativa il compito di comprendere anche la sua esperienza di sofferenza, cioè la illness, coincidente con il racconto che il paziente fa della propria malattia, della propria sofferenza, del problema che la malattia rappresenta per lui e del posto che occupa nella sua vita. Tutte premesse vitali per co-costruire una buona storia di malattia.
Solo questa narrazione più ampia permette infatti di collocare la raccolta anamnestica meramente oggettivante a cui siamo abituati - basata su dati fisiologici, farmacologici, patologici remoti, familiari, comportamentali - in un contesto più aderente all"esperienza effettiva della persona malata, che offra al medico una comprensione diversa della malattia e una connessione con il malato nuova, in cui si possa restituirgli un adeguato riconoscimento delle sue personali sensazioni e del vissuto suscitato dai sintomi che lo affliggono.
Ma perché questo possa accadere diviene conditio sine qua non che si allunghi almeno un po" quello spazio di appena 18 secondi concesso in media dal medico -generico o specialista che sia- al paziente prima di intervenire a interromperne il racconto avendo già deciso di aver compreso il problema di cui questi è portatore.
Infatti per una persona malata narrare una storia significa raccontare una serie di eventi e fatti messi in connessione fra loro attraverso una trama, che spesso è, soprattutto inizialmente, incompleta, frammentaria e discontinua, e che va quindi accolta, rielaborata e condivisa, perché si possa giungere non solo a una pur indispensabile cartella clinica, di per sé asettica e spesso limitante, ma piuttosto si crei una prospettiva di superamento o convivenza accettabile e dignitosa della condizione di malattia su un piano esistenziale, coinvolgente la persona nell"interezza delle sue aspettative, timori, desideri, progetti, dei modi di percepire e intendere il proprio corpo e i limiti che gli sono imposti dallo stato patologico stesso.