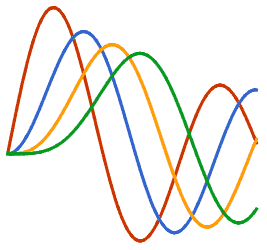- Redazione P&D - 09/01/2007
LE RAPPRESENTAZIONI DELLA VECCHIAIA: I PARTE - Teresa BONIFACIO
Introduzione
Prosegue il processo di invecchiamento della popolazione [italiana]: al 1° gennaio 2006 l’indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione ultrasessantacinquenne e quella con meno di 15 anni) registra un ulteriore incremento, raggiungendo il valore di 140,4 (nel 2005 era pari a 137,8), il più alto dell’Unione Europea. Ormai quasi un italiano su cinque è ultrasessantacinquenne e anche i “grandi vecchi” (dagli ottanta anni in su) sono in continuo aumento: essi rappresentano più del 5% del totale della popolazione.
Il succinto riepilogo qui riportato, relativo ai dati pubblicati dall’Istat nell’Annuario statistico italiano 2006, si presta ad evidenziare con sobria ma indubbia efficacia le dimensioni che sta assumendo il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione in Italia, uno dei paesi demograficamente più “vecchi” del mondo . Si tratta di un fenomeno rispetto alla cui portata non sembra sia stata sinora pianificata una risposta adeguatamente strutturata; le sia pur innumerevoli iniziative intraprese in campo culturale ed economico sono di fatto ancora lontane dal costituirsi come la globale revisione del sistema previdenziale ed ottimizzazione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari che si renderebbe prioritariamente necessaria.
Ma una così profonda ristrutturazione, ancorché avviata, per essere veramente efficace nel ridurre la minaccia di dissolvimento dei fondamenti stessi del nostro sistema di protezione sociale, non potrà prescindere dalla rivalutazione, o per meglio dire “riabilitazione” culturale, dell’immagine dell’anziano. Un’immagine stereotipata che è andata sempre più svilendosi fin quasi ad esaurire il suo patrimonio di prestigio e competenza professionale ed esistenziale: quella di anziano, infatti, è oggi una condizione alla quale appartenere non comporta in apparenza alcun vantaggio, e di cui risulta piuttosto amplificato ogni svantaggio. Spogliata della sua antica autorevolezza, deprivata d’ogni connotazione positiva, alla vecchiaia non rimane da rappresentare che la parte di carico improduttivo per la società, e soprattutto di terrificante spettro della nostra mortalità, tabù pressoché innominabile che l’attuale stile di vita e sistema di valori pare ormai del tutto incapace di accettare come facente parte naturale e imprescindibile dell’esistenza.
La prospettiva che, in un futuro lontano ma non indefinitamente remoto, un terzo della popolazione possa essere così abbandonato alla propria difficoltà di riconoscersi in altro che non sia l’indesiderabilità o la fragilità fisica e psicologica, non è né umanamente né socialmente accettabile. È mia opinione sia perciò auspicabile che, dopo aver a lungo accentrato i suoi interessi sul mondo infantile, la psicologia accentui ora ogni sforzo proprio in direzione dell’anziano, di modo che la senescenza psicologica possa proporsi come non altrettanto inevitabile e condizionante della senescenza fisiologica. Un intervento produttivo in tal senso dovrebbe innanzi tutto essere orientato a promuovere e diffondere, in una sorta di formazione permanente rivolta ad ogni fascia di età della popolazione, una concezione dell’invecchiamento come processo non necessariamente patologico, nel cui svolgersi sia concepibile e realizzabile per l’anziano il mantenimento, quanto più a lungo possibile, della propria autosufficienza e di una qualità di vita che non solo risulti accettabile ma che potenzialmente ancora consenta la più ampia varietà di esperienze appaganti ed arricchenti.
L’ipotesi di lavoro è che questa concezione operativamente vada delineata guardando anche a quelle componenti sociali che non hanno perso, o che hanno saputo recuperare, una visione della vecchiaia priva di pregiudizi, a quelle persone che scelgono spontaneamente di stare – senza alcuno scopo di lucro – accanto agli anziani, sostenendoli nella loro più o meno problematica quotidianità: i volontari. Obiettivo di questa tesi è indagare su quali siano le rappresentazioni e le motivazioni che spingono le persone ad avvicinarsi agli anziani senza timore di «riconoscerci nel vecchio che noi stessi saremo» , familiarizzando con i loro limiti, i loro bisogni, il loro stile di vita, e apportando con ciò un fattivo contributo alla conoscenza dei meccanismi intrapsichici e relazionali dell’individuo anziano. Una conoscenza, in sintesi, che concorra a rimuovere il principale ostacolo alla realizzazione di interventi mirati di sostegno, integrazione e partecipazione: la convinzione che investire sui vecchi sia inutile.
Alle volte uno si sente incompleto ed è soltanto giovane.
Italo Calvino
Capitolo 1
Le rappresentazioni della Vecchiaia: uno sguardo ai riferimenti teorici
1.1 Il concetto di identità
Il nostro senso di identità personale è il risultato di un complesso processo psicologico che coinvolge aspetti intrapersonali ed interpersonali, e attraverso il quale si perviene ad una esperienza cognitiva ed emotiva di sé . Ciò consente di elaborare coerentemente l’informazione interna ed esterna che ci riguarda, codificandola come memoria autobiografica, e di attuare i comportamenti più adeguati alla situazione e al nostro ruolo in essa. In psicologia il sé come costrutto è stato sviluppato attraverso numerose ipotesi teoriche, che hanno riguardato sia la distinzione concettuale tra “io” e “me” (da James, 1890, a Greenwald e Pratkanis, 1984), sia il dipanarsi delle sue diverse dimensioni; in estrema sintesi potremmo delineare il sé come un articolato intreccio di immagini, rappresentazioni, valutazioni: riflesse dagli altri (Cooley, 1902; Mead, 1934), ricavate tramite auto-osservazione (Bem, 1972) ed in base ai confronti sociali (Festinger, 1954).
L’immagine che si ha di sé è in larga parte determinata dall’importanza attribuita al gruppo o ai diversi gruppi cui si appartiene (Abrams e Hogg, 1990; Tajfel, 1982; Tajfel e Turner, 1979), dalla posizione e desiderabilità sociale ad essi riconosciuta e dai rapporti intercorrenti fra i gruppi in cui è strutturata qualsiasi cultura. Ecco allora che la costante rinegoziazione del prestigio di in-group ed out-group attuata tramite strategie stereotipiche, atteggiamenti pregiudiziali e discriminazioni acquista un ruolo cruciale nel mantenimento di un elevato livello di autostima personale , così come di uno stato cognitivamente coerente (Festinger, 1957), dimostratisi entrambi essenziali al benessere del nostro senso di identità.
1.2. Rappresentazioni, pregiudizi, stereotipi
Le rappresentazioni sono la forma di conoscenza che si realizza attraverso una produzione cognitiva – elaborata in base alle proprie esperienze, appartenenze culturali ed apporti emotivi – con cui si media tra sé e la realtà, e rispetto alla quale, quindi, vi è inevitabilmente uno scarto: non sarà mai possibile pervenire ad una “rappresentazione oggettiva”, perché si tratterà sempre di una costruzione in cui ad un’immagine si sovrappone un significato simbolico. Quando questa costruzione viene trasmessa e riconosciuta a livello collettivo è possibile definirla una rappresentazione sociale (Moscovici, 1961): conoscenza condivisa di un oggetto sociale, che non solo permette la comunicazione ma diventa anche guida al comportamento, dal momento che crea un legame tra l’immagine comune di un fenomeno ed i giudizi e valori ad essa associati. Come osserva con chiarezza Mazzara:
la dimensione sociale appare in qualche modo costitutiva del processo di conoscenza e di interpretazione della realtà. Nel nostro sforzo di comprendere per poter prevedere ed agire in maniera efficace, noi guardiamo con un occhio alla realtà e con un occhio al nostro simile che sta guardando e interpretando quella stessa realtà. L’altro svolge per noi l’insostituibile funzione di un partner di conoscenza, la cui presenza e la cui opinione è per noi indispensabile non solo come verifica della bontà delle nostre valutazioni, ma soprattutto come compagno di un gioco di scambio e di infiniti rimandi reciproci, nel quale la conoscenza assume di fatto le connotazioni di una conoscenza collettiva .
Nella produzione delle rappresentazioni entrano in gioco diversi meccanismi atti ad economizzare un lavoro cognitivo altrimenti insostenibile: «gli psicologi di ogni orientamento concordano nel ritenere che il pensiero e la percezione non sarebbero possibili al di fuori della capacità di semplificare e sistematizzare il mondo in categorie» . Ed è proprio all’interno di normali processi di elaborazione delle informazioni, come ad esempio attribuzioni (identificazione, corretta o meno, delle cause di un evento) e categorizzazioni (raggruppamento di oggetti ed eventi per similarità, che permette di ridurre il numero dei dati da gestire), che avvengono distorsioni come l’errore fondamentale di attribuzione (Ross, 1977), la differenziazione intercategoriale e l’assimilazione intracategoriale, e – ciò che più interessa in questa sede – ha luogo il ricorso ad euristiche e stereotipizzazioni. Si tratta di vere e proprie scorciatoie cognitive che ci consentono di risparmiare le nostre risorse mentali allorché ci muoviamo in un ambiente sociale complesso, ma che pur assolvendo ad una indispensabile funzione intellettiva comportano per contro lo svantaggio di condurre a fenomeni come stigmatizzazioni e pregiudizi.
Con il termine pregiudizio (dal latino praeiudicium; giudizio che precede l’esperienza, e perciò privo di validazione empirica) nelle scienze sociali si identifica un atteggiamento verso gli altri basato unicamente sulla loro appartenenza ad un determinato gruppo, e solitamente sfavorevole. La definizione di stereotipo (dal greco stereo, rigido, stabile, e tipo, modello, da cui il senso di “modello stabile”), usata per la prima volta da Lippmann nel 1922 per indicare le immagini mentali o rappresentazioni di cui difatti ognuno di noi si serve come mediazione con la realtà, indica invece la componente cognitiva che sta alla base del pregiudizio: un insieme per l’appunto rigido di credenze, condiviso tra i membri di una cultura, che viene associato ad una categoria o gruppo sociale determinando il pregiudizio stesso. La stretta connessione fra i due concetti fa sì che spesso vengano confusi, e di fatto alcuni teorici tendono a considerarli un fenomeno unico; altri invece ritengono impreciso parlare tout court di pregiudizio anziché di pregiudizi, ognuno in qualche modo a sé stante, data la diversità delle motivazioni storiche ed economiche, prima ancora che psicologiche, da cui hanno avuto origine. Pregiudizi e stereotipi possono infatti riguardare il genere, l’appartenenza etnico-razziale, l’orientamento sessuale, la religione, la nazionalità, la marginalità sociale, l’età, le disabilità; in alcuni casi costituiscono una struttura così radicata e pervasiva da assumere un nome specifico: sessismo, razzismo, antisemitismo. Per indicare invece «atteggiamenti o comportamenti negativi nei confronti di un individuo basati unicamente sulla sua età» esiste per ora il solo termine inglese, ageism, intraducibile in italiano se non a mezzo di perifrasi.
Secondo lo schema concettuale “a quadranti” utilizzato da Mazzara , le diverse possibili spiegazioni dell’esistenza di pregiudizi e stereotipi possono essere classificate incrociando idealmente due criteri: il primo concerne la loro ordinarietà vs. eccezionalità, dal momento che possono infatti essere intesi come processi sostanzialmente normali o viceversa per qualche aspetto patologici ; il secondo contrappone una focalizzazione a livello individuale ad una a livello sociale, distinguendo le interpretazioni basate su fattori biologici, di personalità e motivazione personale da quelle d’ispirazione sociopolitica. L’analisi conduce ad una definizione finale di stereotipi e pregiudizi come prodotto dell’azione congiunta di almeno tre fattori:
1. caratteristiche e limiti propri del nostro sistema cognitivo, che necessita di semplificazioni e contestualmente di nutrire aspettative;
2. bisogno di appartenenza, risultante da motivazioni biologiche, culturali e psicosociali, che ci avvicina ai nostri simili e ci fa respingere il diverso;
3. ragioni storiche e sociali che definiscono le posizioni dei vari gruppi nel panorama delle relazioni.
Altrettanto importante rispetto alla cognizione delle loro origini è conoscere le caratteristiche e i meccanismi attraverso i quali stereotipi e pregiudizi si riproducono. Nelle società attuali, ad esempio, è raro che un pregiudizio venga espresso apertamente: l’ampia condivisione dei valori democratici e la messa costituzionale al bando della discriminazione ha motivato le persone a conformarsi a nuovi sistemi normativi, improntati alla correttezza politica e alla tolleranza. Ciò non significa che razzismo o sessismo siano scomparsi, ma solo che hanno per lo più assunto una forma latente, implicita ed indiretta, in cui il pregiudizio si cela sotto le più rispettabili vesti della difesa dei valori tradizionali o dei principi di meritocrazia e giustizia. Il suo reale persistere viene tuttavia perfettamente percepito da chi ne è bersaglio, e quanto ciò possa essere condizionante è stato ben evidenziato dalle ricerche che hanno portato a definire i fenomeni noti come effetto Pigmalione e profezia che si autoavvera. Gli stereotipi non sono infatti credenze “inerti”, ma in quanto strategie partecipanti al processo di costruzione della realtà finiscono in un certo senso per conformare quest’ultima a se stessi, influenzando in modo anche sostanziale percezioni, atteggiamenti e comportamenti sia di chi li nutre sia di chi ne è oggetto.
Ridurre il pregiudizio e la discriminazione che spesso ne deriva è questione quanto mai ardua e spinosa; innanzitutto perché, come accennato, lo stereotipo risponde all’irrinunciabile esigenza umana di utilizzare schemi e aspettative, e tende perciò a rimanere invariato nel tempo e a resistere al cambiamento. Se esso è smentito dall’evidenza, pur di salvaguardarne la validità facilmente si conclude che si è di fronte ad un’eccezione («Se i fatti non coincidono con la teoria - tanto peggio per i fatti» ). Inoltre, come pure si è visto, si tratta di un fenomeno complesso e determinato da una pluralità di cause interagenti: anche le possibili strategie dovranno perciò essere complementari anziché alternative, integrando diverse prospettive. Soprattutto, l’autoriproduzione degli stereotipi potrà essere efficacemente ostacolata a patto di agevolare la formazione di alternative cognitive, favorendo ad esempio il rapporto e la familiarizzazione con il diverso, promovendo il pluralismo culturale e la cooperazione, fornendo un adeguato supporto istituzionale e culturale. Un cambiamento sociale – processo continuo ma spesso molto lento e talvolta contraddittorio, in cui le trasformazioni a livello del macrocosmo politico ed economico e del microcosmo individuale difficilmente viaggiano di pari passo – che sia a favore della riduzione del pregiudizio può senz’altro essere operato, ma per attuarlo servono programmi educativi su larga scala, che prevedano la partecipazione di tutti i soggetti e l’interazione di tutte le componenti coinvolte.
1.2. Stereotipi sugli anziani
1.2.1. Premessa
Una definizione esaustiva – se non semplicemente una definizione – della condizione anziana, oltre ad esulare gli scopi di questo lavoro, si pone come obiettivo oltremodo problematico e sfuggente in considerazione delle molteplici componenti che la rendono piuttosto un processo dinamico anziché uno statico paradigma comodamente osservabile.
Per quel che concerne l’intendimento della vecchiaia, tra noi e coloro che sono appartenuti alle generazioni antecedenti alla nostra, c’è una sorta di abisso ermeneutico : non è più possibile, in altre parole, definire cosa sia la vecchiaia analizzandola riduzionisticamente, a partire ad es. dalla perdita della capacità riproduttiva o del “rallentarsi” dell’attività intellettuale o dal deficit, anzi dal costante e irreversibile degrado, di qualunque altra funzione fisico-biologica.
L’inadeguatezza di un approccio deficit model a quelli che da molti vengono definiti i “nuovi” anziani della società attuale, appare particolarmente evidente in considerazione del continuo spostarsi dei parametri epidemiologici e del sempre più complesso articolarsi di quelli socioculturali che caratterizza questo inizio di terzo millennio. Se già «l’anziano nasce dall’incontro dialettico di un’invariante biologica e di una variante culturale, diacronica e sincronica» , oggi come non mai la sua identità è in costante mutamento, con cui la ricerca affannosamente cerca di stare al passo. L’interesse al fenomeno dell’invecchiamento demografico della società occidentale ha infatti determinato un autentico proliferare di studi i cui risultati mettono spesso in discussione molte delle pregresse acquisizioni . In questa sede sarà perciò conveniente limitarsi a tratteggiare a grandi linee quelle caratteristiche della vecchiaia che in qualche modo prestano il fianco a stereotipizzazioni e pregiudizi, sia pur senza dimenticare che
gli individui sono caratterizzati da ampia variabilità intraindividuale, cioè in ciascun individuo, nel corso del tempo, alcune abilità possono declinare, altre no, altre ancora sono suscettibili di miglioramento; gli individui differiscono fra di loro in modo sempre più evidente con l’avanzare dell’età.
1.2.2. L’ageism
Le prime ed immediate informazioni che acquisiamo quando ci troviamo di fronte a una persona nuova, e che costituiscono le tre principali dimensioni lungo le quali si categorizzano gli altri, sono la razza, il sesso e l’età. Ciò nonostante, il pregiudizio relativo a quest’ultima è fra quelli che finora hanno ricevuto minor attenzione dalla ricerca . Il fatto stesso che non sia ancora stato coniato un neologismo per esprimere in italiano il significato di ageism, del resto, può apparire sintomatico di quanta poca necessità di un termine specifico venga avvertita nel nostro Paese. Tale disinteresse può essere in parte ricondotto alla relativa modernità del fenomeno dell’invecchiamento: se è pur vero che già nell’antichità, in società o momenti storici contraddistinti da un largo benessere, è stato raggiunto il traguardo della sopravvivenza fino ad età più che ragguardevoli, è parimenti innegabile che le dimensioni di quello in corso nella civiltà occidentale costituiscano un’eccezionalità mai verificatasi prima. Permane però quanto meno il sospetto che la relativa indifferenza verso l’ageism abbia a che fare anche con la tendenza a sottovalutarne estensione ed effetti: «il pregiudizio in base all’età è una delle forme di pregiudizio socialmente più condonate ed istituzionalizzate nel mondo». In poche parole: la mancanza di riguardo quando non l’intolleranza verso le persone di una certa età è così capillarmente diffusa che non ci si accorge nemmeno di metterla in atto, aiutati in questo dalla mancanza di sanzioni anche solo informali che colpiscano chi la manifesta apertamente.
Una delle caratteristiche che vanno innanzitutto rilevate in questa forma di pregiudizio è che, rispetto agli altri gruppi di età, quello degli anziani ne costituisce uno “sottoprivilegiato”, in quanto immagini e attese di comportamento che li riguardano sono in ampia parte negativi. Ma la caratteristica senz’altro più saliente è un’altra, che non ritroviamo in nessun altro tipo di stereotipo: chi stigmatizza un anziano è destinato a diventarlo a sua volta, perché l’appartenenza all’in-group, rispetto all’out-group discriminato, è solo temporanea. Assumere un atteggiamento pregiudiziale verso la categoria di cui, nella migliore fra le due alternative a nostra disposizione, ci ritroveremo parte in futuro, appare insensato ancor prima che svantaggioso: quali sono le motivazioni che ci inducono a questo comportamento? E se i «fattori che definiscono lo status sociale del vecchio: la sua “fragilità fisica”, l’essere possessore di conoscenze ed esperienze, l’alterazione dei tratti fisici a cui è sottoposto con il trascorrere degli anni» sono gli stessi da sempre, perché la “popolarità” dell’anziano è allora oggi tanto in declino?
Mentre la Terror Management Theory, come si vedrà più avanti, offre una possibile risposta al primo interrogativo, la teoria della modernizzazione si prefigge di spiegare l’avvenuto declassamento dello status delle persone anziane in funzione di quattro mutamenti della struttura sociale, verificatisi durante la trasformazione delle società da tradizionali ed agricole a industriali e moderne:
1. l’istituzionalizzazione del pensionamento, con conseguente perdita del ruolo professionale e del potere finanziario;
2. il costante progredire tecnologico, che in ambito lavorativo fa sì che il valore dell’esperienza sia eclissato dall’abilità nell’innovazione;
3. l’urbanizzazione e il derivante collasso della famiglia estesa, con il rarefarsi della frequentazione fra nonni e nipoti;
4. la diffusione dell’alfabetizzazione, che ha privato l’anziano del suo ruolo di depositario e trasmettitore di sapere culturale e saggezza.
Anche Rita Levi Montalcini si esprime concordemente sulla necessità di contestualizzare la svalutazione in atto della vecchiaia nella peculiarità di un velocizzarsi senza precedenti del progresso.
Nell’epoca attuale la travolgente rapidità del vertiginoso sviluppo scientifico e tecnologico, che ha trasformato una società statica in una altamente dinamica, ha emarginato l’anziano in quanto non in possesso delle nuove conoscenze, né portatore di esperienze utili alle nuove generazioni .
Gli anziani di oggi si trovano, dunque, ad affrontare situazioni e scenari molto diversi e cognitivamente ben più impegnativi rispetto a quelli incontrati dalle generazioni precedenti; pensiamo solo allo sviluppo raggiunto dai media, che rende se non indispensabile quanto meno conveniente saper utilizzare telefoni cellulari e personal computer. Di conseguenza anche il “parco-stereotipi” riguardanti gli anziani deve essere costantemente ammodernato in modo da offrire copertura ad ambiti e livelli d’informazione ancora non raggiunti dalle generalizzazioni esistenti.
Deponte e Vetere (in stampa) riportano come la ricerca di Stangor ed altri (1992) abbia dimostrato che spesso la formazione di nuovi stereotipi non implica affatto la sostituzione di quelli precedenti, quanto piuttosto un loro affiancamento; di conseguenza si verifica un notevole accrescersi numerico degli stereotipi operanti, senza che ciò rappresenti un miglioramento per l’anziano: il suo identificarsi con un’immagine, anche laddove positiva, comunque generalizzata della vecchiaia può determinare infatti un senso di disadattamento (Levy, 1996 e 2003). Non va inoltre dimenticato che gli stereotipi legati all’età possono prendere a bersaglio persone già colpite da discriminazione in base al genere o all’appartenenza etnica, con ulteriore aggravarsi delle loro conseguenze.
I tratti con cui vengono generalmente contraddistinti i vecchi rivestono sia aspetti psicologici sia tendenze comportamentali; in entrambi i casi si tratta per lo più di caratteristiche che evidenziano la loro inadeguatezza non solo con riferimento al sistema produttivo ma anche ai processi di elaborazione e circolazione delle idee. Essi sono difatti considerati rigidi, orientati al passato, senza progetti, poco disponibili all’innovazione, ostinati, collerici, poco adattabili, lamentosi: in quanto «fisicamente e cognitivamente inetti ma socialmente sensibili», essi finiscono per essere «compatiti ma non rispettati» . La “resistenza al cambiamento”, del resto, compare come tratto fra quelli rilevati già nelle prime ricerche sugli stereotipi relativi alla vecchiaia, che risalgono agli anni 50 del Novecento.
Gli anziani venivano descritti più soli e dipendenti, poco attivi, non più “utili” socialmente e non interessati al successo o alla realizzazione. . Il fenomeno si presentava così diffuso e universale che nel 1969, il gerontologo americano Robert Butler coniò il termine ageism per identificare l’insieme degli stereotipi e dei pregiudizi legati all’età.
Cacciaguerra rileva che «se una persona psicologicamente vulnerabile riceve messaggi negativi dal suo ambiente li incorpora nella sua idea di sé e produce un circolo vizioso di feed-back negativi» : è ciò che accade ad un vecchio che, interiorizzando gli stereotipi, contribuisce a rafforzarli, con l’ulteriore decadimento che ne deriva. Quando invece un anziano non si riconosce negli stereotipi della vecchiaia cui egli stesso è esposto, non potendo cambiarli adotta la strategia di considerarsi un’eccezione, traendo un vantaggio relativo dalla mancata identificazione con la categoria.
Nei vecchi il paragone con i coetanei è continuo e fondamentale: uno stato d’animo positivo è il risultato non solo di una situazione obiettivamente favorevole, ma anche della comparazione con altri della stessa età che sono giudicati essere in condizioni peggiori (teoria della deprivazione relativa).
Festinger utilizza a proposito la teoria della dissonanza cognitiva, per spiegare questa negazione dell’età. Se uno si identifica con i vecchi della sua età e vede che questi sono rigettati dalla gente comune, entra in conflitto tra rifiutare gli stereotipi negativi o rifiutare di far parte della categoria: è più semplice scegliere questa seconda possibilità.
Sempre secondo Cacciaguerra in vecchiaia c’è minore comunicazione con gli altri, e minore possibilità di comparare le proprie osservazioni; inoltre si rafforza la disposizione al pensiero egocentrico. Ecco dunque che:
il giudizio sui vecchi e quindi sulla vecchiaia è comune nei vecchi e non è fondato sui fatti, neanche sulla osservazione della propria vecchiaia perché se ne tirano facilmente fuori. Quindi, per farlo, devono usare stereotipi o pregiudizi o si devono valere di “labels” come tutti e, in un certo senso, più di tutti.
In aggiunta agli effetti indiretti dovuti all’introiezione degli stereotipi che li riguardano, per gli anziani l’ageism può concretizzarsi anche in atti di discriminazione diretta. Il “Rapporto sulla discriminazione in Italia per causa di età” , in cui oltretutto si ricorda come quest’ultima non venga menzionata dall’art. 3 della Costituzione Italiana relativo alla discriminazione, ne riporta brevemente i casi più noti, che possono essere di due tipi:
- formali, come la penalizzazione rispetto a polizze assicurative o prestiti bancari, o l’esclusione dai concorsi per l’impiego negli Enti Pubblici;
- informali, come la marginalizzazione in ambito di lavoro e formazione, il mancato riconoscimento al diritto di cure sanitarie e assistenziali, le truffe, i soprusi.
Il quadro farebbe supporre che questo scoraggiante insieme di perdita di ruoli, prestigio e competenze, vulnerabilità di fronte alle discriminazioni e permeabilità agli stereotipi non possa che condurre a quella che Goffman definisce un’identità danneggiata (Goffman, 1963), in cui l’appartenenza di gruppo comporta svantaggi non superabili in alcun modo. Fortunatamente, la ricerca psicosociale e le moderne discipline come la gerontologia e la geragogia sono alacremente all’opera per combattere l’ageism e per costruire un nuovo profilo meno stereotipato dell’anziano. Un obiettivo rispetto al quale vale la pena di tener conto anche dell’interessante messaggio veicolato dal pensiero di Hillman: «forse i vecchi diventano disfunzionali perché non immaginiamo per loro nessuna funzione».
1.3. Terror Management Theory
La Terror Management Theory (TMT) è stata sviluppata a partire dagli anni 80 del Novecento presso lo Skidmore College di Saratoga Spring, New York, da Jeff Greenberg, Tom Pyszczynski e Sheldon Solomon. Quest’ultimo, come dichiara in un’intervista, da graduate student “inciampò” accidentalmente nel lavoro di Ernest Becker, secondo le cui teorie «la consapevolezza unicamente umana della morte, e la sua negazione, guida e indirizza una sostanziale proporzione del comportamento umano» . La teoria prende appunto le mosse dall’assunzione che la consapevolezza squisitamente umana – a differenza dell’istinto di conservazione, comune a tutte le specie – della propria mortalità , unita alla nostra capacità di autoriflessione, si configuri come una fonte continua di angoscia esistenziale, o per meglio dire di un terrore contenibile solo attraverso l’azione della cultura, apportatrice di significati, organizzazione e senso di continuità all’esistenza.
L’adesione ai valori culturali e la fiducia nella loro presunta validità consente di trovare conferme alle proprie convinzioni ed accrescere di conseguenza il proprio senso di sicurezza ed autostima, per la quale la TMT ipotizza una funzione “anxiety-buffer” che la correla inversamente all’ansia: le persone con un buon livello di autostima sarebbero meno portate ad assumere atteggiamenti difensivi in presenza di indicatori collegati alla morte. Le rappresentazioni stereotipiche legate all’età, rispetto alle funzioni genericamente assolte dalle categorizzazioni, svolgerebbero in tal senso uno specifico ruolo ego-protettivo, «sia perché permettono confronti sociali dall’alto in basso, che promuovono l’autostima, sia perché allontanano la minaccia rappresentata da un futuro Sé deteriorato, fragile e destinato alla fine» .
L’istinto di proteggere il nostro sistema culturale, la nostra visione del mondo da tutto ciò che potrebbe far sì che essa si svaluti, cessando di esercitare la sua benefica funzione sulla nostra autostima, è particolarmente forte soprattutto quando una persona viene indotta a focalizzarsi sulla propria mortalità: secondo il paradigma della mortality salience indurre le persone a pensare alla morte comporterebbe un aumento del favoritismo verso l’in-group e dell’ostilità verso l’out-group .
Gli anziani difficilmente possono costituire una minaccia sociale alla visione del mondo prevalente in una data cultura: piuttosto ne sono spesso fervidi difensori; ciò che vi è in essi di minaccioso è il loro intrinseco costituire un «costante richiamo alla fragilità dell’essenza umana, all’inevitabilità della morte. Di fronte a tale minaccia, la persona reagisce con strategie di difesa che vanno dall’evitamento alla disumanizzazione, all’accentuazione delle differenze intergruppi, ai già citati confronti dall’alto in basso» . I richiami alla morte in cui capita di imbattersi nella nostra vita quotidiana sono innumerevoli, ma il loro significato è sovente eludibile; non è così per i segni dell’età. Nessun’altra immagine può riflettere meglio di quella di un vecchio l’ineluttabilità di un comune destino, prossimo a realizzarsi anche per noi: «l’anziano può essere per le persone il più minaccioso richiamo alla loro inevitabile mortalità » .
Secondo i teorici della TMT nella potenzialità degli anziani di suscitare pensieri collegati alla morte potrebbero trovare facilmente spiegazione alcune manifestazioni di ageism, come la presa di distanza sia fisica che simbolica e la messa in atto di difese prossimali e distali: discriminazioni implicite ed esplicite che non possono che comportare una ricaduta profonda sulle capacità e sulla qualità della vita della popolazione anziana.
Il contributo di questo filone di studi per una riduzione dell’ageism consiste nell’indicazione di tre direzioni d’intervento:
1. la valorizzazione culturale dell’anziano e l’incremento della sua concreta presenza nella rete sociale;
2. il rafforzamento della capacità di gestire il terrore, attraverso il consolidamento del proprio senso di valore;
3. la promozione di una maggior conoscenza e consapevolezza rispetto all’ageism stesso e alla nostra paura della morte.
Se le persone gestiscono efficacemente il proprio terrore, dovrebbero sentirsi assai meno minacciate dall’esposizione agli anziani e dovrebbero essere maggiormente capaci di riconoscere la propria similarità con essi e la propria responsabilità verso di loro.