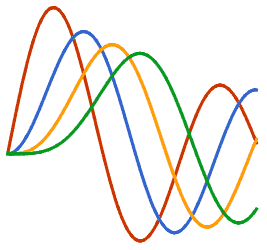Deboli, svantaggiati - Redazione P&D - 29/10/2024
Verso che tipo di studioso, “esperto in ristagni, in crepuscoli”, stiamo andando culturalmente? Qualche traccia orientativa non manca - P.C.
Il nostro debolologo sa che le cose accadono, abitualmente, in casa, sul posto di lavoro, nei dintorni; mette al primo posto perciò i fili della quotidianità, per quanto umili. Segue l’assistito, con gli occhi o con la mente, dal fisioterapista, al parco giochi coi figli, nei mercatini in piazza. Lo vede arrabattarsi con le diete, con gli orari del bus, con la piscina terapeutica; lo accompagna dal veterinario, in osteria, all’assemblea di condominio.
Rifiuta i modelli pan-medicalistici, non pensa che tutto si riduca al corpo. Ha sempre in tasca la treccia dello ”scoobidoo” (persona, beni, corporeità), quando affronta problemi che attengono a un certo spicchio. Quello del patrimonio mettiamo; dopo un attimo eccolo interrogarsi sui riflessi collaterali, all’intorno: l’impatto sulla salute, sulla serenità interiore.
Coglie al volo le insofferenze umane, quelle che la realtà, accanto ai virgulti forti, alimenta in noi ogni giorno. Dipendenze più o meno serie, nuovi presidi; deficit negli scambi, non soltanto sbalzi corporei, emotivi. Tontonerie anche, analfabetismi nascosti, sospettosità insensate; sensi di inadeguatezza, riluttanze estreme.
Non teme di procedere a casaccio, ama i sentieri selvaggi; pensa che un ramo alto, verso est, oppure a nord, resti sempre misterioso negli alberi. Non ignora di influenzare più che altrove, operando in ambiti come quelli della vulnerabilità, pensieri e movimenti di chi gli sta vicino. Mite nell’approccio, ammette di non conoscere qualsiasi rivolo, dell’esperienza umana, se occorre si abbandona alle congetture; sa come tutti al mondo abbiano paura di qualcosa. Ama i suoni e le provocazioni di altri linguaggi, quando ispirati, fecondi: parole come “inclinazioni”, ad esempio, “richieste”, “partecipazione”, “attività realizzatrici”, “animale d’affezione”, oppure “condizione emotiva”, “inesperienza”, “attenzione”, “legami di coppia”.
Ogni creatura gli sembra tesa a conquistare, per se stessa, gli astri della “fragilità quale insieme”: l’unità interna, l’armonia complessiva dello spirito. Viversi come “qualcuno”, in senso buono, sapere chi e che cosa si è, grossomodo, chi si vorrebbe diventare, un giorno; ricondurre i fili personali a un centro unico, rinascimentalmente, non decidere se non stando lì, nel proprio nido, sul ponte di comando.
Il verbo “sentire” spesso in bocca: “Senti questo, mi sento in un certo modo, sentiamoci; non sento più, provo questi sentimenti per voi”. Meglio ancora il verbo “fare”, le sue voci, trasporre all’esterno le più adatte: “Cos’hai fatto ieri; non farlo più, è meglio; fallo pure se credi; facciamolo insieme se vuoi; lo farai con lei magari’ ”.