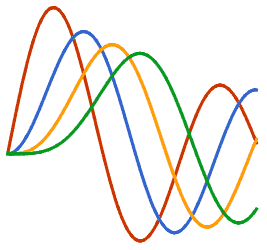Deboli, svantaggiati - Elvira Reale - 27/09/2023
Un’estate horribilis nel segno della violenza contro le donne
Elvira Reale, Gabriella Ferrari Bravo, Centro Studi e ricerche ‘Protocollo Napoli’
L’estate 2023 è stata connotata da un’impennata di violenze contro le donne, in particolare stupri di gruppo e femminicidi, che hanno avuto una maggiore evidenza sui giornali. Di quest’ estate macchiata da violenze nel mezzogiorno c’è traccia in una serie di articoli, interventi e editoriali sul Corriere del mezzogiorno, collegati da un filo rosso, da un’ottica di genere che dà risalto alla specificità del rapporto di potere uomo-donna nella relazione di coppia e nel sociale, ma soprattutto all’assenza di interventi appropriati da parte dello Stato.
- Storie di femminicidi. Perché Anna non è stata protetta
Corriere del mezzogiorno, 22 agosto 2023, L’editoriale di Elvira Reale
Il femminicidio di Anna Scala fa saltare il banco, e rien ne va plus nel gioco dello scarica barile delle responsabilità praticato spesso dalle istituzioni, e che ha avuto come effetto la demolizione della credibilità delle donne che denunciano la violenza subita e la loro vittimizzazione secondaria, documentata dalla Commissione d’inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura. Il caso di Anna manda in soffitta la triade che imperversa nelle interviste a magistrati e esperti di varie professioni: Donne! Uno, andate a denunciare al primo schiaffo; due, non accettate gli ‘ultimi’ appuntamenti e, tre, guardate il vostro partner geloso come una persona da curare, affetto da gelosia patologica. Anna Scala smentisce questi argomenti stereotipati che pretendono di rendere il femminicidio meno ingiustificabile. Anna, aveva fatto ben due denunce cercando una risposta alle sue richieste di protezione. Denunce inevase. Anna non era andata ad un “ultimo appuntamento”. Con prudente consapevolezza e in attesa della invocata protezione, ha lasciato la sua casa e si è rifugiata dalla madre. Anna è stata uccisa dall’ex-compagno, denunciato per lo stalking post-separativo, che non accettava la sua decisione, la sua autonomia e questo è il fattore centrale del rischio di letalità riconosciuto internazionalmente. Anna ha fatto tutto ciò che si richiede idealmente a una donna vittima di violenza. La responsabilità della morte di Anna è, dunque, oltre che del suo assassino, delle istituzioni che non l’hanno ascoltata né protetta, sottovalutando le sue denunce e le sue paure senza fare una corretta analisi del rischio. Non è quindi accettabile l’autodifesa della magistratura dietro il tema dell’imprevedibilità dell’evento. Le istituzioni sono dunque indifendibili, il re è nudo. Inoltre sappiamo tutti che, come sostiene l’associazione Protocollo Napoli che segue i percorsi istituzionali mettendo in evidenza gli aspetti di re-vittimizzazione, la violenza è un processo e non un fenomeno puntiforme, per cui anche le buone pratiche di contrasto si sono costruite e si costruiscono nel tempo. Le norme ci sono, ma non sono applicate. Lo dicono anche alcuni magistrati, consapevoli degli stereotipi e pregiudizi che pesano su operatori e operatrici della giustizia; lo ha detto Valeria Valente, ex presidente della Commissione femminicidio, con i dati dell’inchiesta svolta. Ma dobbiamo constatare che i pregiudizi sono forti, nei tribunali e ovunque. E non basta per questo la formazione ‘teorica’, occorre un salto di qualità nella lotta al pregiudizio, un intervento più consapevole almeno in ambito giudiziario, a partire dal CSM. Gabriella Ferrari Bravo ha scritto, ieri, di un’altra “Anna”, nel cui percorso ’dimenticato’ dall’ A.G. si stagliava il suggerimento di un altro rappresentante dello Stato, il poliziotto che le diceva: “attenta alla denuncia, potrebbero toglierti tuo figlio”. E infatti, ciò che ha permesso a Anna Scala di reagire e denunciare è stato il non avere figli con l’ex partner. La presidente del tribunale di Napoli, in un’intervista, si è riferita agli accordi con l’ex-presidente della commissione femminicidio per costituire nuovi spazi di riconoscimento da parte delle istituzioni della vittimizzazione secondaria. Questa è l’occasione buona per andare avanti, con le associazioni di donne, i centri anti-violenza e le esperte di violenza, per superare stereotipi e pregiudizi di cui la strada dei femminicidi è lastricata.
- Memoria corta degli stupri di gruppo (impuniti),
27 agosto 2023, Corriere del mezzogiorno, Commento di Elvira Reale
Oggi le letture “sociali” sul caso Caivano, assunto a emblema del degrado, deviano l’attenzione dalla dimensione cruciale, culturale e misogina, dello stupro di gruppo, spostandola su un piano sul quale è facile ignorare la trasversalità della cultura maschile del possesso delle donne (da Izzo e Ghira, fino al caso Grillo). Confondendo tra l’altro l’abuso familiare -caso della piccola Fortuna, con lo stupro di gruppo. Nessuno invece si chiede: quanto costi, alle vittime, la libertà degli stupratori, se minorenni. Cioè quanto costi la giustizia alle vittime, quando c’è finalmente denuncia e evidenza di reati? Spiace dirlo ma abbiamo tutti la memoria corta. Oggi, dopo Palermo, esplode il caso Caivano, cioè lo stupro di gruppo da parte di bande di minorenni con qualche adulto diciannovenne. Ma nell’state del 2017 esplosero due casi analoghi in contesti diversi: uno a Pimonte, l’altro sullo “scoglione” di Marechiaro. Due ragazze quindicenni, la prima condotta dal fidanzatino in un’imboscata e data in pasto al branco di12 amici. Uno scempio. Immagino che quella ragazza dovrà faticare molto per riprendersi dal trauma, ma altro non si sa perché i genitori la portarono via, in Germania. Infatti, il paese di Pimonte con il suo sindaco si schierarono con i ragazzi e chiamarono lo stupro ‘una bambinata’. I ragazzi furono presto liberi di scorrazzare in paese, forse orgogliosi della loro impresa, e la ragazzina fu costretta ad andar via. Nessuna giustizia per lei.
Scoglio di Marechiaro: la ragazza scopre per caso dal web chi erano gli autori dello stupro di gruppo e li denuncia. Anche qui un branco, e i due minori che guardavano la scena mai perseguiti per la loro partecipazione passiva. Inizia sul web un tiro al piccione, la ragazza é messa sotto accusa con commenti velenosi tipici della cultura dello stupro, ‘se l’è andata a cercare, le è piaciuto, ma non sapeva che….’ A Caivano, si profila lo stesso scenario: due tredicenni assaltate da un branco di adolescenti, solo il maggiorenne arrestato. Ma sono state penalizzato anche le vittime: separate dopo la denuncia dai loro affetti, dal loro contesto, e portate, senza ascoltarle, in casa famiglia. Si aggiunge così trauma a trauma. I loro avvocati hanno protestato senza esito. Anche qui le ragazzine devono fare i conti, da subito, con le denunce che “non convengono” e possono fare ancor più male della violenza subita. E gli autori? Gli autori, se minorenni, hanno tutt’altro trattamento. I giornali, all’epoca dello stupro sullo scoglio di Marechiaro titolarono “reato cancellato per i minori del branco”. Grazie alla loro età, hanno diritto alla messa in prova (art. 28 del DPR n. 488 del 1988). Cioè possono essere seguiti e monitorati dai servizi sociali, comportarsi bene per un certo periodo di tempo e, all’esito positivo, si può procedere alla cancellazione del reato. Il fatto non è mai accaduto. Le vittime che hanno denunciato e affrontato un processo? Si presume che gioiscano anche loro per la cancellazione del reato. Mi chiedo se ciò sia educativo, per degli adolescenti. E soprattutto, cosa proverà la vittima che porterà il peso di un trauma difficile da cancellare? E dove è finito il suo diritto alla tutela e alla giustizia? Credo di non essere la sola a pensare che la messa alla prova con possibile estinzione del reato di fronte a fatti così gravi sia una risposta diseducativa e ingiusta e che vada modificata. Gli adolescenti devono imparare ad assumersi la responsabilità di ciò che fanno, elaborarne le conseguenze, sopportare una pena, quale che sia, ma non è possibile che escano da vicende così tragiche senza aver risarcito in nessun modo le vittime, mentre queste devono chiudersi in casa e vergognarsi per quanto accaduto, come se la responsabilità fosse loro, oppure essere spinte ad andar via dai loro contesti. Le due cuginette di Caivano cosa penseranno del fatto di essere state messe in casa famiglia? Certo di essere state punite, perchéé si sappia bene che uno stupro è sempre colpa di una donna, anche quando è ancora bambina, per quel che fa, per quel che dice, per quello che indossa. O, semplicemente, in quanto donna.
- Gli occhi chiusi sulla violenza fatta in famiglia
31agosto 2023, Corriere del mezzogiorno, Intervento di Elvira Reale
L’arrivo della presidente Meloni a Caivano non aiuta a leggere il fenomeno degli stupri sulle vittime-bambine in modo corretto. Anzi, confermando con la sua presenza eccezionale che Caivano sia una terra di nessuno, senza stato, dove tutto può accadere e possiamo confinare l’orrore, “salva” tutto il resto del territorio da rischi di contaminazione. È urgente invece un approccio diverso, per assumerci la responsabilità di guardare lucidamente al fenomeno dell’abuso delle bambine da parte non solo di adolescenti, ma soprattutto di adulti, e inquadrandolo nell’ambito della violenza sulle donne, che spesso sconfina anche nella pedofilia. Quando si parla di pedofilia, invece, si guarda più ai dati del turismo sessuale da parte di maschi adulti, molto elevati. Ma quello di cui si parla meno e si tende a negare è l’abuso più frequente: quello intrafamiliare. La falsa coscienza, lo sguardo della collettività si distoglie con disgusto da questo tema ma, soprattutto, lo sottovaluta sia nelle aree educative e di welfare, sia nelle aule dei tribunali: qui il tema è spesso platealmente negato, anche in presenza di evidenze e accuse esplicite dei bambini. Malgrado questa tendenza alla rimozione, la stampa ha riportato da aprile a oggi dodici casi con esito giudiziario. Di questi, sette hanno riguardato padri, età sui 40/50, con abusi perpetrati da quando le figlie molto piccole, e continuati per circa dieci anni, prima di arrivare nei tribunali con percorsi vari. Il modo più tipico è la denuncia della vittima, divenuta maggiorenne; gli altri sono la flagranza e l’intercettazione ambientale, dopo denunce di terzi. In tre situazioni i padri hanno coinvolto negli abusi anche altri (persino un nonno) e girato dei video. Le madri, in questi casi, non avevano raccolto confidenze dalle figlie, se non tardivamente. E dove sono accaduti gli abusi? Ovunque. Da Crotone a Milano passando da Roma, Bologna, Ravenna: non solo Caivano quindi. Allora che dire? L’orrore non si ferma a Caivano. Questi casi approdati al sistema giudiziario, con meno scalpore ma diffusi su tutto il territorio nazionale, sono solo la punta dell’iceberg.
La Commissione d’inchiesta sul femminicidio della scorsa legislatura ha mostrato come il sistema giudiziario sia, se non reticente, in gran parte impreparato ad affrontare questa problematica, caratterizzata dal fatto che le donne vittime di violenza domestica si trovano spesso a fare i conti anche con le violenze sessuali dei padri sui figli. Che succede, allora? Denunciano, ma in tante non vengono credute, perché spesso i figli si trovano nelle fasi iniziali di quelle violenze e hanno età mediamente inferiori ai sei anni; per questo è facile che parlino in primis alla madre, ma spesso non sono considerati capaci di testimoniare. Molte violenze, poi, vengono alla luce nel corso della separazione, quando i figli frequentano i padri in autonomia: per questo motivo, le denunce delle mamme sono definite spesso come “strumentali”. Il tragico epilogo di queste situazioni è che le indagini sono incerte, quasi mai si arriva all’intercettazione ambientale, strumento chiave d’indagini di questo genere e le madri che riferiscono o registrano le confidenze dei figli vengono definite manipolatrici, esaltate, patologiche. Al contrario, può anche succedere che una madre che denuncia un abuso sul figlio venga penalizzata perché “non ha denunciato prima”, ecc. Non tranquillizza un sistema giudiziario che, a causa di stereotipi e pregiudizi sulle madri, fa “strage” di innocenti. E pensare che la strategia uscire per da questi orrori è stata chiaramente individuata, da tempo, dalla ricerca internazionale che segnala come la violenza domestica contro le donne è il primo fattore e indicatore di rischio per l’abuso sessuale infantile e che, tutelando le madri vittime, proteggeremo anche i bambini.
- Per fermare l’escalation. Femminicidi, maggiori tutele
22 settembre 2023, Corriere del mezzogiorno, Editoriale di Elvira Reale
Dopo Anna Scala, i femminicidi non si fermano. Rossella Nappini, infermiera del San filippo Neri, un ex partner che non si arrende al rifiuto. In questo caso nessuna denuncia. E poi ancora Marisa Leo, qui più denunce, un processo, ma nessuna misura cautelare, e poi la ritrattazione della donna, per salvaguardare il rapporto padre-figlia. Anche qui, un ex partner che non si arrende alla volontà d’interrompere la relazione. E ancora Maria Rosaria Troisi a Battipaglia uccisa con un coltello che le ha tranciato la gola, che lascia due bambini e un partner che nessuno riconosceva come violento. Ancora una volta tre donne sono morte per mano di un uomo.
Femminicidi, allora: uccise in quanto donne, una ogni 32 minuti nel mondo, uccise perché considerate possesso di un uomo, che può disporre di loro fino sl diritto di vita e di morte, nel segno di un rapporto di potere che affonda le radici nella storia di una società patriarcale. E allora che fare, lasciamo correre? C’è, per i femminicidi, una sorta di assuefazione: certo, si contano le morti, certo ci si mobilita come donne e come comunità di riferimento che si stringono intorno alle famiglie. Con una certa stanchezza, però. Un rito che si ripete. Non fanno troppo rumore i femminicidi, né sulla stampa nell'opinione pubblica, e se confrontiamo con quello che è successo per gli stupri di Caivano non c’è partita. Si è mosso il governo, è venuta la presidente del Consiglio a promettere a Don Patriciello, emblema della lotta alla criminalità e non della lotta contro la violenza alle donne, una bonifica del territorio. Ma anche tutto ciò, non in nome delle due bambine stuprate ma in nome del contrasto alla camorra e alla criminalità organizzata. Meloni non ha infatti neanche voluto incontrare le famiglie delle due bambine. Parva materia. Tutto lo scenario è stato preso dalla camorra e dal leitmotiv “Caivano terra senza Dio e senza Stato”.
Giorgia Meloni non si è mai mossa finora per un femminicidio. Parva materia. Certo c’è in campo un decreto per l’inasprimento del codice rosso per contrastare i reati di violenza. Ma intanto proliferano sentenze nel civile e nel penale che ignorano la Convenzione di Istanbul - l’abc della lotta alla violenza maschile contro le donne - che ignorano nel civile la vittimizzazione secondaria delle donne che denunciano e che le penalizzano, con l’affido condiviso, consegnandole mani e piedi legati ai loro aguzzini (ex partner).
E questo è il caso di Marisa, la figlia comune l’ha condotta nel luogo dove l’ex, padre della bambina, aveva architettato la trappola mortale. Non un ultimo appuntamento, quindi. Le donne vengono ammazzate e stuprate comunque, inutile dare consigli per l’autotutela. E allora parliamo di ciò che si dovrebbe mettere in campo, se si volesse affrontare il problema seriamente. Il femminicidio è l’ultimo atto di una spirale di comportamenti violenti, sia fisici, sia psicologici, sia di stalking. Perché è proprio questo il tema. Bisogna fermare l’emergenza, che è la violenza contro le donne tout court, e questa si ferma per la singola donna - qui e ora - solo sul piano giudiziario. Poi, parallelamente, si procede nel processo di cambiamento culturale, auspicato da tutti, nelle scuole e nelle varie agenzie educative. Ma il cambiamento culturale ha bisogno di tempi lunghi. Qui e ora, invece, ci vogliono condanne senza giustificazionismi di sorta; ci vuole la tutela delle donne che denunciano e infine sentenze giuste. Occorre una formazione obbligatoria per tutti gli operatori, e anche qualcosa in più. Abbiamo bisogno di un tribunale e una procura specializzati, dedicati ai reati di genere contro le donne, come c’è per i reati di mafia ma, soprattutto, che guardi a quanto ha fatto la Spagna in materia raggiungendo risultati importanti. Altrimenti, nei prossimi anni continueremo sempre più stancamente a contare le donne uccise.
Da molti anni lavoro in un Centro antiviolenza e, da molti anni, scrivo su questo giornale dello stesso argomento, che a dir poco è vecchio di millenni. Non ti sei stancata? mi chiedono. E io rispondo di sì, certo che mi sono stancata. Ma la durezza di cui è fatto l’ostacolo, il suo centro, cioè il dominio di una metà del genere umano sull’altra metà, sembra inscalfibile. È per questo che la foto che vi propongo oggi rappresenta una donna sdraiata, che appare ancorata per sempre a questa posizione, come schiacciata al suolo. È ripresa di schiena, senza volto. Mi ha fatto pensare a quegli stati di depressione profonda in cui non si ha la forza nemmeno di alzarsi e stare in piedi. Un velo bianco - forse è da sposa ma può darsi che sia una benda chirurgica di enorme grandezza - avvolge il corpo lasciando libera solo una mano sottile, impegnata a reggere la nuca, forse a ripararla. Tutta l’immagine mi trasmette un angoscioso senso di immobilità, di rifiuto, di protesta muta. L’autrice è Charlotte Lartilleux, che ha pubblicato da poco il libro “Sine fine” con le foto della mostra dallo stesso nome, commentate da molte firme, Segre, Maraini, Cossu, Ravera e tante altre. Questa che vedete fa parte, dunque, di un lavoro complesso dedicato alla violenza sulle donne che sembra all’autrice, e al curatore del libro Pietro del Re, “Sine Fine”. Perché l’ho scelta? Perché anch’io sperimento, giorno per giorno l’interminabile angoscia che atterra le donne, le rende senza volto, le imbavaglia, le trasforma da vive a morte e, ancor più spesso, in semi-vive.
Donne accartocciate su se stesse, prive di energia vitale, prive di speranza.
È orribile quello che ho appena scritto. Ma cos’altro pensereste voi, se il vostro lavoro fosse quello di ascoltare, tentare di proteggere e aiutare donne vittime di violenza cieca, fisica e materiale, oppure insinuante, quasi invisibile al mondo, tutta psicologica. In mille variazioni di un paradigma che si declina arrivando quasi sempre allo stesso finale: la sconfitta. Ogni giorno leggiamo nuovi studi, corredati da statistiche non equivocabili, sullo “stato dell’arte” in Italia. Fa impressione, intanto, il numero di femminicidi che non accenna a diminuire e, insieme a questo, il numero crescente di denunce da parte delle donne. Questo aumento ha un doppio valore: da un lato ci dice quanto sia esteso il fenomeno della violenza maschile sulle donne; dall’altro, ci rappresenta un’urgenza di risposta che non ottiene soddisfazione, quando lo mettiamo a confronto sia con il numero delle denunce che vengono ritirate, sia con quello dei procedimenti giudiziari che fanno seguito a quanto le donne denunciano. Si cerca qui il bandolo di questa intricata materia che riunisce in una sola, gigantesca matassa giudiziaria i reati commessi ai danni di donne, in genere legate da relazioni intime e malate ai loro persecutori con i provvedimenti civili che riguardano i figli nati da quelle relazioni. Vi si aggiunge, per rendere ancor più complesso il problema, il tema dei diritti umani inalienabili, che andrebbero difesi da parte di chi lavora nel sistema del welfare. Niente di tutto questo regge, tuttavia, di fronte al muro dell’ urgenza di certi racconti di donne concrete che non possono aspettare i tempi della cosiddetta normalità dei servizi. Non regge se Anna, che sta parlando con te, porta ancora i segni sul collo di un tentativo di soffocamento, e piange da giorni per lo choc e il terrore di un nuovo incontro con il padre di suo figlio, che finge di non capire (peggio ancora, davvero non capisce) come mai lei si sia rifugiata col figlio di tre anni a casa della sorella, e continua a intimarle di tornare a casa. Insieme. E purtroppo non è questa l’unica remora alla denuncia, perché uno dei poliziotti che hanno verbalizzato il suo racconto in pronto soccorso le ha detto: attenta potrebbero (chi? perché?) toglierti tuo figlio, ti conviene denunciarlo? cosa ne ricavi?. Se aggiungiamo che Anna lavora ma è pagata in nero, mentre suo marito lavora regolarmente, abbiamo un quadro della differenza di potere nella coppia, che gioca un ruolo decisivo sulla decisione di denunciare o no la violenza subita. La donna esita, sua sorella non potrà ospitarla per sempre. Una casa rifugio in autonomia sarebbe per lei e suo figlio l’ideale. Ma i posti sono pochi, anche questo c’è scritto nel rapporti che leggiamo, ed il sud, manco a dirlo, è il fanalino di coda per investimenti malgrado le buone leggi, le buone norme regionali, disattese malgrado le buone intenzioni, gli impegni politici e il lavoro incessante delle associazioni e agenzie di volontariato. Che si fa con Anna? Si aspetta. A settembre, di sicuro ci sarà la possibilità di inserire questa donna in un corso formativo retribuito, si sarà liberato un posto in una casa alloggio ecc ecc. Tutti verbi al futuro, in risposta a tutti i verbi coniugati al passato nel verbale di polizia: “mi prese a spintoni, mi gettò sul letto e per difendermi lo graffiai, poi mi strinse il collo e vidi tutto nero…”. A questa donna andrebbe risposto con i tempi del presente, l’urgenza non fa ipotesi al futuro. E dunque, sarà pure banale scriverlo, ma perché meravigliarsi quando Anna mi manda un vocale e mi dice, con una voce senza colore, che quell’uomo è pur sempre il padre di suo figlio e lei non sa dove andare, dunque non denuncerà e tornerà a casa. Ecco. Vi ho raccontato solo l’ultimo “incontro”, sia pure virtuale dopo quelli di persona, con una delle donne che ho conosciuto e con cui ho tentato di collaborare, nella ricerca di un mezzo per uscire dalla condizione di vittima di violenza. Dalla condizione mentale e fisica di chi non padroneggia il proprio corpo e la propria mente, perché sopraffatta fin dall’infanzia da una mentalità, un’educazione e un contesto familiare, educativo, sociale che induce le donne a mantenere un atteggiamento passivo, intimamente rinunciatario.
È facile, tra l’altro, cadere nell’equivoco di ritenere che la violenza contro le donne sia una caratteristica di un ceto sociale deprivato, poco istruito, arretrato culturalmente. Questo tipo di pregiudizio cadrebbe all’istante, se solo si volessero ascoltare, o leggere, le testimonianze delle donne dal fondo della spirale della violenza subita.
È ciò che tenta di fare Letizia Muratori, tra le scrittrici dei brani che commentano le foto di Lartilleux. “Entrai in casa senza permesso. Era buio, solo una lama di luce appariva in fondo al corridoio[…] e così la trovai: Luisa stava accucciata sotto i cappotti. Le tesi la mano, ci si aggrappò sollevandosi a stento. Era nuda. […] Odorava di naftalina, di un veleno domestico e antico. “Si appoggi pure a me, le dissi”. Il racconto termina con un’offerta di aiuto, che Luisa rifiuta.
Per me la più grave sconfitta è questa: non riuscire ad offrire un aiuto adeguato e competente, che non rappresenti una stampella, segno e stigma di una condizione di inferiorità, bisogno e inaccettabile perdita. Guardiamola, questa foto, e chiediamoci come mai quella donna ci volta le spalle, e non l’avevamo mai notata.
Allegati