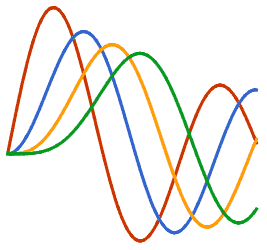Giustizia civile - Elvira Reale - 21/02/2025
Elvira Reale, Protocollo Napoli, interpella Alessandra Capuano del foro di Vicenza sul ruolo dell’avvocato nel Procedimento speciale in materia di persone e minori
sul ruolo dell’avvocato nel: “Procedimento speciale in materia di persone e minori in caso di allegazioni di violenza: l’istruttoria e le prove”.
Alessandra Capuano, risponde.
Il D.L.gs 149/2022, più noto come riforma Cartabia del processo civile, ha introdotto significativi cambiamenti nei processi riguardanti la famiglia e i minori. Certamente la più innovativa delle modifiche riguarda l’introduzione di un procedimento speciale per i casi di abusi familiari, condotte di violenza domestica o di genere, i cui capisaldi sono contenuti negli artt.473 bis.40 e ss del codice di rito.
La relazione illustrativa chiarisce gli aspetti fortemente innovativi del nuovo procedimento, concepito come strumento di attuazione della Convenzione del Consiglio d’ Europa per la prevenzione ed il contrasto alla violenza domestica e di genere, siglata ad Istanbul l’11 maggio 2011, che l’Italia ha ratificato con la legge n. 77/2013. L’adesione alla convenzione impone agli stati membri l’adozione di mezzi giuridici coerenti con la finalità perseguita e l’organismo permanente di controllo sull’attuazione della convenzione (GREVIO) redige rapporti periodici sullo stato delle leggi e dei sistemi giuridici dei Paesi aderenti. Ne consegue che il diffuso atteggiamento di sistematica disapplicazione dei principi della convenzione che si registra tuttora nei Tribunali è il risultato di un errore di valutazione e di scarsa conoscenza del quadro normativo. Parimenti erronea è la convinzione che la definizione delle forme di violenza contenuta nell’art.3 della convenzione citata non abbia valore cogente nel nostro ordinamento. Al contrario, l’Italia è tenuta a dare forma e sostanza, con le proprie leggi e la propria giurisprudenza, alle definizioni e ai principi contenuti nella normativa sovranazionale, dovendone comunque applicare direttamente i precetti come è stato nuovamente e chiaramente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (I sez. civile ord. n.11631/2024.).
Di conseguenza nel processo civile di famiglia, in forza delle norme processuali sopra richiamate, il Giudice civile è tenuto a considerare prima di ogni altra circostanza l’esistenza di ogni forma di violenza che emerga dagli atti, adottando i conseguenti provvedimenti in coerenza con i principi della convenzione. Perciò il Giudice dovrà cogliere negli atti del procedimento l’allegazione di ogni forma di violenza psicologica, economica, fisica e sessuale, per orientare la propria decisione all’isolamento dei soggetti violenti e alla protezione della libertà e sicurezza delle vittime. Il rilievo della violenza è necessario per scongiurare la vittimizzazione secondaria, che “ si realizza quando le stesse autorità chiamate a reprimere il fenomeno delle violenze, non riconoscendolo o sottovalutandolo, non adottano nei confronti della vittima le necessarie tutele per proteggerla da possibili condizionamenti e reiterazioni delle violenze stesse” (Cass.cit.).
In questo compito il Giudice deve essere aiutato e sostenuto dell’avvocato delle vittime, sul quale grava l’onere di fornire il quadro dettagliato e nitido del contesto in cui la violenza o la condotta abusiva si sono realizzate.
Per cominciare va detto che è un ottimo accorgimento, sebbene non sia prescritto dalla legge, quello di intitolare l’atto con diretto riferimento al procedimento speciale. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti la mancata intitolazione dell’atto ovviamente non è preclusiva dell’applicazione delle norme speciali, nondimeno l’indicazione si rivelerà utile, se non altro per facilitare il compito della registrazione del fascicolo.
In ogni caso l’onere processuale principale dell’avvocato della vittima di violenza sarà quello di fornire al Giudice la rappresentazione chiara dei fatti e delle condotte, riportando gli episodi salienti in cui la violenza o gli abusi si sono manifestati. Non vanno taciuti gli episodi sintomatici della violenza psicologica, che si esercita attraverso il controllo coercitivo sull’esistenza della vittima, perchè essa è normalmente prodromica ad altre forme di violenza. Il controllo coercitivo difficilmente passa inosservato nell’entourage della vittima, perché si realizza attraverso divieti, ritorsioni, controlli indebiti e intimazioni che emergono anche nel contesto sociale ed economico. Non si dovrà, quindi, offrire al giudice un giudizio sulla persona autrice di violenza, bensì riportare la sequela di circostanze che ne manifestano la condotta e l’indole. Spetterà poi al giudice, ed alla sua sensibilità, far rientrare gli episodi narrati nel concetto di abuso familiare, di violenza domestica o di genere, in applicazione della normativa nazionale e sovranazionale vigente.
L’opera descrittiva dell’avvocato deve essere poi corredata da quanta più documentazione sia possibile esibire, non soltanto con riferimento alla violenza fisica - dove è più facile disporre di riscontri obiettivi- ma altresì relativamente alle altre forme di violenza. E’ noto che nel nostro processo civile la testimonianza scritta, introdotta con l’art. 257 bis cpc, ha avuto ben poca fortuna, essendo ammissibile soltanto su accordo delle parti. Tuttavia ciò non significa che, a titolo di principio di prova, o anche soltanto per sollecitare il giudice all’ascolto di informatori, l’acquisizione di dichiarazioni scritte - su temi e circostanze significativi- sia da considerarsi inutile. Ovviamente coloro che rilasciano la dichiarazione su richiesta della parte potranno poi essere sentiti dal giudice nel contraddittorio delle parti per confermare quanto dichiarato. Ma se tali dichiarazioni provengono da soggetti realmente terzi rispetto alle parti in contesa, quali possono essere medici, pediatri, insegnanti, datori di lavoro, colleghi, gestori di locali pubblici ove si siano verificati episodi rilevanti, esse possono servire quantomeno a dimostrare al giudice che esiste del materiale istruttorio rilevante e facilmente acquisibile, rassicurandolo perciò sulla concretezza dell’offerta probatoria della parte.
E’ comunemente accettata la massima per cui la realtà supera la fantasia, ed è anche per questo che il compito dell’avvocato non è quello di immaginare, ipotizzare o formulare richieste sulla base di stereotipi, ma quello di ricostruire pazientemente l’immagine della vita domestica, familiare e personale della parte rappresentata, come se si trattasse di un puzzle che è necessario portare in giudizio con il maggior numero di pezzi che sia possibile reperire. I pezzi mancanti, perché non si dispone di una prova legale né di una prova tipica, visto che la relazione personale tra le parti è di natura intima, dovranno essere inseriti ricorrendo a due strumenti dei quali non si deve dimenticare l’importanza: il principio di non contestazione e le presunzioni semplici. E’ evidente, infatti, che a fronte di allegazioni generiche, controparte potrà facilmente contrastarle in modo altrettanto generico, per di più abbandonandosi al vittimismo di chi si dichiara oggetto di denigrazione. Qualora, invece, il quadro complessivo della relazione personale connotata dalla violenza venga rappresentata descrivendo numerose condotte ed episodi rilevanti che non trovano contestazione specifica, il Giudice potrà giudicare sulla base delle presunzioni semplici.
Va anche ricordato che, nella fase dell’adozione dei provvedimenti temporanei o urgenti, il giudice non potrà più ignorare le allegazioni di violenza in attesa che su di esse si acquisisca piena prova all’esito dell’istruttoria, poiché la Riforma ha messo a sua disposizione strumenti efficaci per l’accertamento, in via anticipatoria, della sussistenza del concreto pericolo di perpetuazione dei fatti di violenza al fine di evitare la vittimizzazione secondaria.
Al giudice è perciò attribuito il potere di svolgere accertamenti e acquisire elementi di prova, anche al di fuori degli standard di ammissibilità ordinari, con il solo limite del rispetto del principio del giusto processo, e cioè del diritto al contraddittorio ed alla prova contraria.
L’onere che grava sulla parte, pertanto, concerne la mera allegazione dei fatti di abuso o delle condotte di violenza domestica o di genere, dei quali sia vittima essa stessa o lo siano gli altri componenti del nucleo familiare, come espressamente disposto dall’art.473 bis.40. cpc.
Non è quindi necessario, per la parte istante, fornire la prova delle condotte descritte, né dare conto di avere terminato, e neppure iniziato, il percorso di accertamento della responsabilità penale dell’autore delle violenze. Sarà il giudice che, letti gli atti e ritenuto che i fatti esposti descrivono un contesto di violenza, dovrà condurre i rapidi accertamenti d’ufficio necessari ad adottare i provvedimenti utili a mettere in sicurezza le vittime.
In tal senso la relazione illustrativa del D.Lgs 149/2022 chiarisce che le norme di cui all’art.473 bis.40. e ss cpc impongono che “il procedimento venga trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità con il fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni, affinché l’adozione dei provvedimenti, anche provvisori, non avvenga con formule stereotipate, ma solo dopo aver accertato, anche solo a livello di fumus, se l’allegazione di violenza sia fondata o meno.” (cfr. pag.19 relazione).
Il giudice, pertanto, non dovrà condurre una compiuta istruttoria per l’accertamento dei fatti di violenza narrati, ma attivare sin dalla prima fase del procedimento tutte quelle sommarie indagini dalle quali trarre il convincimento dell’esistenza di condotte violente a carico della parte o dei minori. Osserva a questo proposito un recente arresto della Corte di Cassazione che “ la presunzione d'innocenza opera esclusivamente in sede penale e, pur dovendosi negare carattere decisivo alla sola pendenza di procedimenti penali per l'accertamento di comportamenti penalmente censurabili, il giudice civile deve comunque procedere ad un'autonoma valutazione dei predetti comportamenti” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 16 settembre 2024, n. 24726.).
Un giudice preparato sui temi della violenza domestica e di genere conosce i meccanismi che alimentano il cosiddetto “ciclo della violenza” e perciò non si aspetta dalla vittima iniziative coraggiose, coerenti e univoche, poiché gli è noto che il processo di affrancamento è lungo e tortuoso, ma sicuramente destinato all’insuccesso qualora lo Stato anzichè fornire il necessario sostegno operi in modo da aggravare la condizione della vittima con i meccanismi ormai noti della vittimizzazione secondaria.
Resta tuttavia indiscusso che è onere della parte esporre, con precisione e chiarezza i fatti, documentandoli ove possibile, al fine di fornire al giudice il quadro preciso del contesto esistenziale di riferimento, come prescritto dagli artt.473 bis 12. lett.e) e 473 bis 13. lett.d) cpc.
Gli avvocati americani dicono che vince la causa chi in Tribunale racconta la storia migliore, ma non è vero. Ottiene giustizia chi racconta con diligenza, precisione e chiarezza una storia vera.
Alessandra Capuano, avvocata del foro di Vicenza
In allegato l'articolo integrale
Allegati