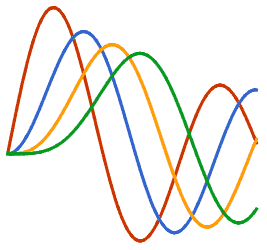Deboli, svantaggiati - Giuseppe Piccardo - 30/06/2023
Linguaggio di genere e sessismo: una questione (strutturale e culturale) non risolta
In questi giorni, diversi quotidiani, i media e i c.d. “Social”, hanno riportato la notizia relativa a “chat” telefoniche di dipendenti di una grande azienda, contenenti messaggi che commentavano l’aspetto fisico di colleghe, con allusioni di tipo sessuali molto forti, con un linguaggio lesivo della dignità del genere femminile.
I messaggi della chat, diventati pubblici, che volutamente riporto integralmente, senza asterischi, o altri segni di censura, sono del seguente, letterale tenore:
Primo messaggio della chat: “Però a quella le tette sono un po’ scese”
Risposte e commenti successivi: “Si vabbè, ma che culo sodo però”; “Glielo infilerei così tanto nel culo da farle uscire le palle dalla gola”
Secondo messaggio: “E’ talmente cessa e grassa che che le infilerei un sacchetto in testa e me la scoperei comunque, di prepotenza”
Credo che ogni commento ad affermazioni simili, espresse con un linguaggio così “triviale” e scomposto, e come tale inaccettabile, debba far riflettere, ancora una volta, sull’importanza del linguaggio di genere e sulla situazione allarmante, nella quale ci troviamo, a livello sociale.
Infatti, se come ho più volte avuto modo di rilevare, la nostra legislazione, anche grazie ad atti giuridici internazionali, quali la Convenzione di Istanbul, è adeguata,, almeno formalmente, agli standard necessari di tutela delle vittime di violenza fisica ( e non solo fisica), sotto il profilo sociale e culturale la situazione è molto più complessa e preoccupante.
Infatti, non solo destano allarme le continue uccisioni di donne, come ho ricordato in occasione della tragica morte, di recente, di Giulia Tramontano, ma l’utilizzo, da parte di molti giornali, dei media, e, purtroppo, di molti giuristi, di un linguaggio e di una narrazione che mette sul banco degli imputati la donna, e non l’aggressore o l’omicida; il linguaggio, dunque, risente in modo evidente di fattori culturali, di stereotipi di genere radicati e consolidati nella nostra società, che i giornali, i mass media e i tribunali continuano, pervicacemente, a riproporre. Per questo motivo, occorre che il contrasto alla violenza di genere passi, in modo sempre più forte, attraverso l’analisi del linguaggio di genere e dall’uso corretto delle parole, che costituiscono armi potentissime di diffusione di messaggi stereotipati, errati e violenti nei confronti del genere femminile.
Dunque, non si può che convenire con la professoressa Raffaella Scarpa, che nel volume “Lo stile dell’abuso – Violenza domestica e linguaggio”(edito da Treccani, 2022) evidenzia come nell’analisi della problematica della violenza domestica, nulla più del linguaggio venga sistematicamente sottovalutato, quando, invece, lo“stile del discorso”costituisce il mezzo fondamentale per ridurre e mantenere la donna in uno stato di soggezione e soccombenza. Il linguaggio è un’arma di potere e di soggezione molto pericolosa, quando non si sa utilizzarlo correttamente, e la violenza di genere si fonda proprio sul potere e sulla prevaricazione.
E tutto quanto sopra, è ancora più importante se si pensa che l’uso scorretto del linguaggio di genere può avere, quale conseguenza immediata e diretta, la legittimazione ad utilizzare, con disinvoltura e sicurezza, espressioni quali quelle che sono contenute nei messaggi sopra riportati, con la conseguenza di vedere la domma non solo vittima di violenza e di abusi sessuali, ma anche di un linguaggio che la descrive come un oggetto di proprietà dell’uomo, da utilizzare per i propri piaceri sessuali e sulla quale modellare fantasie sessuali e possibili stupri considerati legittimi e naturali, come ben precisato nell’ultimo dei messaggi riportati.
A conclusione di questa breve nota, vorrei riportare, ancora una volta, da un lato le parole della scrittrice Maria Dell’Anno, autrice di un volume che segna un cambio di passo culturale significativo, in tema di violenza di genere, nella direzione dell’analisi del fenomeno femminicidio in relazione alle sue cause più vere e profonde, quelle culturali, dall’altro le parole della Professoressa Claudia Palone, docente di lettere a Savona, e molto attiva nel contrasto alla violenza di genere e all’educazione alla parità di genere, moderatrice della presentazione del volume della Dottoressa Dell’Anno, al quale si è fatto cenno, “Parole e pregiudizi”, lo scorso anno, a Savona.
Dunque, così, leggiamo, nel libro sopra citato: (…) Allora diventa evidente perché è così importante riflettere sul linguaggio, riflettere non solo su cosa ci viene raccontato ma soprattutto su come ci viene raccontato. Perché l’informazione non solo informa, ma forma le nostre idee sulla realtà in cui viviamo. Il giornale non solo ci dice cosa è successo, ma anche cosa dobbiamo provare nei confronti di ciò che è successo”.
A commento della narrazione giornalistica dell’episodio del femminicidio di Daniela Neza, di recente, a Savona, invece, così si esprimeva, la Professoressa Claudia Palone, su un noto social network:“Ennesimo femminicidio. Un altro esempio di uso tendenzioso del linguaggio. Alcuni passaggi che denotano la propensione ad accusare la vittima responsabile della sua stessa morte. Lui incensurato, lei INVECE no. Lei ha usato parole FORTI che avrebbero QUINDI scatenato l'ira di lui , PORTANDOLO all'insano gesto!!ma quanto dobbiamo ancora lavorare per evitare di leggere simili articoli?? E poi la foto con la pozza di sangue in primo piano, cui prodest?
I messaggi sessisti oggetto d questo articolo dimostrano che la domanda della Professoressa Palone non è retorica: il lavoro da svolgere, purtroppo, è ancora molto lungo e impegnativo linguaggio utilizzato dai giornali e dai tribunali italiani nella narrazione del femminicidio. Come tutti i problemi che hanno le proprie cause nella cultura della società di appartenenza, lo studio del linguaggio aiuta a far emergere quegli stereotipi e quelle discriminazioni implicite che, proprio perché profondamente radicate nel sentire sociale, non appaiono immediatamente evidenti. Svelare queste strategie linguistiche e simboliche può quindi contribuire a produrre una nuova consapevolezza della realtà sociale.
Nel mio libro “Parole e pregiudizi” [1] ho voluto analizzare quasi 300 articoli apparsi sui più diffusi quotidiani italiani nel corso di un anno (da aprile 2019 ad aprile 2020) riguardanti 26 casi di femminicidio, al fine di verificare se la narrazione che viene restituita a chi legge sia coerente o no con gli obiettivi di prevenzione della violenza e di ogni forma di discriminazione imposti in primo luogo dalla Convenzione di Istanbul.
Tre sono i frame narrativi principali in cui viene inserita la narrazione dei femminicidi. Propongo un esempio per ciascuno, a cui ricollego l’analisi delle sentenze penali che a due di questi casi sono seguite, in modo da proporre una riflessione parallela sui due linguaggi.
Il primo frame interpretativo,uello più ricorrente nella stampa, è la perdita di controllo, che io ho chiamato “perifrasi per non dire raptus”. In questi casi, il femminicidio viene descritto come il gesto di un uomo che nel contesto di una lite – o più spesso “al culmine di una lite” – uccide la donna in preda ad una momentanea e incontrollabile reazione rabbiosa che gli ha fatto perdere completamente la lucidità e la ragione per qualche istante. Un impulso non ragionato, quindi, non consapevole, sarebbe quello che spinge a uccidere, motivato spesso dalla gelosia o da qualche comportamento della donna. Il caso esemplare che propongo è il femminicidio di CHARLOTTE AKASSI YAPI (uccisa dal suo compagno a Pozzo D’Adda il 24/09/2019).
Il secondo frame narrativo è quello che ho chiamato “una morte annunciata”, in cui si collocano i femminicidi avvenuti all’esito di una vita di violenze, spesso già denunciate, già giudicate e punite, in cui quindi si ritiene che fosse inevitabile che quell’uomo prima o poi finisse per uccidere sua moglie. Il caso esemplare che propongo è il femminicidio di ADRIANA SIGNORELLI (uccisa da suo marito a Milano il 1/09/2019).
Il terzo frame narrativo è quello che ho chiamato “un amore tragico”: in questi casi non solo l’uomo femicida viene descritto come innamorato della donna che ha ucciso, ma il femminicidio viene descritto come una tragedia familiare, che si è abbattuta sulla coppia unitamente intesa. Tale frame ricorre soprattutto nei casi di femminicidio-suicidio, e il caso esemplare che propongo è quello di ALICE BREDICE (uccisa da suo marito a Ragusa il 29/04/2019).
Dall’analisi della narrazione – giornalistica e giudiziaria – di questi tre casi esemplari, constatiamo che il femminicidio viene rappresentato come opera di un uomo innamorato che è stato sopraffatto dagli eventi, che ha perso il lume della ragione in conseguenza di qualche azione della donna; come un fatto sporadico e incontrollabile, o al contrario come inevitabile conclusione di una relazione violenta. Eppure l’uccisione di una donna da parte di un uomo a lei vicino non nasce mai dal niente, ma è l’esito di un continuum di violenze, sopraffazioni, offese, abusi fisici e verbali, anche se spesso questi atteggiamenti non vengono visti o correttamente interpretati.
La narrazione del femminicidio, quindi, ancora lo priva del suo carattere strutturale: ogni femminicidio è isolato dall’altro, è un fatto privato della coppia dove amore romantico e gelosia tendono a giustificare e deresponsabilizzare. Il problema è che se soggetti autorevoli come la stampa e i tribunali scelgono di descrivere i femminicidi adottando una serie limitata e preconfezionata di frame narrativi, sarà difficile che l’opinione pubblica, che non ha una formazione propria su quella problematica sociale, riesca ad adottare una visione critica di quel racconto, bensì lo accetterà come corretto, ancor di più perché va a confermare gli stereotipi culturali con cui tutti e tutte siamo cresciuti e con cui quindi la nostra mente si sente a suo agio. Se non si inizia seriamente a riflettere sul potere delle parole e sulle rappresentazioni che esse veicolano non sarà possibile modificare né il racconto della realtà, né tantomeno la realtà stessa in cui viviamo.
Il mio intervento propone una riflessione sul linguaggio utilizzato dai giornali e dai tribunali italiani nella narrazione del femminicidio. Come tutti i problemi che hanno le proprie cause nella cultura della società di appartenenza, lo studio del linguaggio aiuta a far emergere quegli stereotipi e quelle discriminazioni implicite che, proprio perché profondamente radicate nel sentire sociale, non appaiono immediatamente evidenti. Svelare queste strategie linguistiche e simboliche può quindi contribuire a produrre una nuova consapevolezza della realtà sociale.
Nel mio libro “Parole e pregiudizi” [1] ho voluto analizzare quasi 300 articoli apparsi sui più diffusi quotidiani italiani nel corso di un anno (da aprile 2019 ad aprile 2020) riguardanti 26 casi di femminicidio, al fine di verificare se la narrazione che viene restituita a chi legge sia coerente o no con gli obiettivi di prevenzione della violenza e di ogni forma di discriminazione imposti in primo luogo dalla Convenzione di Istanbul.
Tre sono i frame narrativi principali in cui viene inserita la narrazione dei femminicidi. Propongo un esempio per ciascuno, a cui ricollego l’analisi delle sentenze penali che a due di questi casi sono seguite, in modo da proporre una riflessione parallela sui due linguaggi.
Il primo frame interpretativo, quello più ricorrente nella stampa, è la perdita di controllo, che io ho chiamato “perifrasi per non dire raptus”. In questi casi, il femminicidio viene descritto come il gesto di un uomo che nel contesto di una lite – o più spesso “al culmine di una lite” – uccide la donna in preda ad una momentanea e incontrollabile reazione rabbiosa che gli ha fatto perdere completamente la lucidità e la ragione per qualche istante. Un impulso non ragionato, quindi, non consapevole, sarebbe quello che spinge a uccidere, motivato spesso dalla gelosia o da qualche comportamento della donna. Il caso esemplare che propongo è il femminicidio di CHARLOTTE AKASSI YAPI (uccisa dal suo compagno a Pozzo D’Adda il 24/09/2019).
Il secondo frame narrativo è quello che ho chiamato “una morte annunciata”, in cui si collocano i femminicidi avvenuti all’esito di una vita di violenze, spesso già denunciate, già giudicate e punite, in cui quindi si ritiene che fosse inevitabile che quell’uomo prima o poi finisse per uccidere sua moglie. Il caso esemplare che propongo è il femminicidio di ADRIANA SIGNORELLI (uccisa da suo marito a Milano il 1/09/2019).
Il terzo frame narrativo è quello che ho chiamato “un amore tragico”: in questi casi non solo l’uomo femicida viene descritto come innamorato della donna che ha ucciso, ma il femminicidio viene descritto come una tragedia familiare, che si è abbattuta sulla coppia unitamente intesa. Tale frame ricorre soprattutto nei casi di femminicidio-suicidio, e il caso esemplare che propongo è quello di ALICE BREDICE (uccisa da suo marito a Ragusa il 29/04/2019).
Dall’analisi della narrazione – giornalistica e giudiziaria – di questi tre casi esemplari, constatiamo che il femminicidio viene rappresentato come opera di un uomo innamorato che è stato sopraffatto dagli eventi, che ha perso il lume della ragione in conseguenza di qualche azione della donna; come un fatto sporadico e incontrollabile, o al contrario come inevitabile conclusione di una relazione violenta. Eppure l’uccisione di una donna da parte di un uomo a lei vicino non nasce mai dal niente, ma è l’esito di un continuum di violenze, sopraffazioni, offese, abusi fisici e verbali, anche se spesso questi atteggiamenti non vengono visti o correttamente interpretati.
La narrazione del femminicidio, quindi, ancora lo priva del suo carattere strutturale: ogni femminicidio è isolato dall’altro, è un fatto privato della coppia dove amore romantico e gelosia tendono a giustificare e deresponsabilizzare. Il problema è che se soggetti autorevoli come la stampa e i tribunali scelgono di descrivere i femminicidi adottando una serie limitata e preconfezionata di frame narrativi, sarà difficile che l’opinione pubblica, che non ha una formazione propria su quella problematica sociale, riesca ad adottare una visione critica di quel racconto, bensì lo accetterà come corretto, ancor di più perché va a confermare gli stereotipi culturali con cui tutti e tutte siamo cresciuti e con cui quindi la nostra mente si sente a suo agio. Se non si inizia seriamente a riflettere sul potere delle parole e sulle rappresentazioni che esse veicolano non sarà possibile modificare né il racconto della realtà, né tantomeno la realtà stessa in cui viviamo.