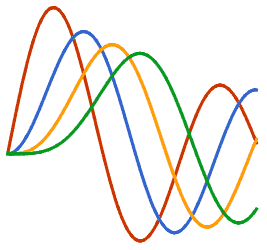Deboli, svantaggiati - Elvira Reale - 12/12/2022
I profili di rischio dei femminicidi negli anni 2017-2018
Analisi di alcuni dati tratti dalla relazione della Commissione femminicidio al Senato
Elvira Reale, Giusy Forte, Fabrizia Longo, Angelica Pipitò
Associazione Salute Donna
I femminicidi nel corso degli anni, dati Ministero della Giustizia
I femminicidi e l’inchiesta
Il numero di femminicidi è un dato stabile con poche variazioni, in un contesto in cui invece diminuiscono gli omicidi in generale; il fenomeno nella sua persistenza interroga la società e la politica sulle modalità per contrastarlo.
Il femminicidio costituisce un caso di omicido compiuto da un uomo su una donna in quanto tale. Questo fenomeno è per sua natura strutturale e, quindi, stabile nel tempo: si verifica in tutto il mondo, all’interno di stesse comunità e principalmente in coppia. Dunque, non costituisce solo un fenomeno culturale, ma esso è trasversale a tutte le società e per questo motivo difficile da controllare.
Su questo fenomeno e sulla violenza contro le donne è stata istituita nel gennaio 2017 la Commissione parlamentare d’inchiesta che ha, infatti, tra i suoi compiti istituzionali primari, proprio quello di «svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio […]» (Articolo2, comma 1, lettera a).
La Commissione poi, nella XVIII legislatura, ha svolto un’indagine approfondita non solo sui dati quantitativi, che varie istituzioni annualmente raccolgono e pubblicano (ISTAT, EURES ecc.) ma sugli atti processuali per indagare anche le criticità delle istituzioni giudiziarie nell’affrontare la violenza e prevenire il femminicidio. Quest’indagine ha riguardato i femminicidi commessi negli anni 2017 e 2018.
Il primo lavoro della Commissione è stato quello di definire i casi oggetto dell’indagine, ovvero distinguere tra uccisioni di donne e femminicidi, in assenza di una definizione normativa di questo crimine, e di tenere presente l’elemento fondamentale che l’autore del delitto sia una persona di sesso maschile. Attualmente in Belgio è stato presentato un progetto di legge, primo in Europa, che punta a dare una precisa definizione dei casi di femminicidio.
Sulla base di queste premesse, quindi, la Commissione ha concentrato l’indagine sui casi nei quali la morte violenta di una donna è dipesa da«motivi di genere», mentre invece sono stati esclusi gli omicidi di donne in cui l’appartenenza al genere femminile della vittima non aveva assunto alcun valore nella scelta criminale.
L’obiettivo dell’indagine è stato quello di acquisire elementi utili per individuare caratteristiche e ragioni della sua diffusione, di verificare l’efficacia della legislazione, nonché di identificare le cause di eventuali disfunzioni nel sistema della rete di protezione delle donne vittime di violenza, nell’ambito sociale, sanitario, giudiziario e di tutte le strutture sul territorio.
I risultati dell’analisi statistica riportano che nel biennio 2017-18, in Italia, le donne vittime di omicidio volontario sono state 273 (di cui 132 nel 2017 e 141 nel 2018). Di questi, il numero di casi che la Commissione ha ritenuto potenziali femminicidi si è attestato a 211 (di cui 96 nel 2017 e 115 nel 2018).
Tali omicidi hanno causato un numero totale di vittime donne pari a 216 (il che vuol dire che in alcuni casi per mano di uno stesso autore vi sono state più donne uccise).
La rilevazione statistica sul profilo delle donne e degli autori ha escluso poi i 19 casi, analizzati a parte, dei procedimenti penali definiti con sentenza di assoluzione dell’autore.
I dati complessivi si riferiscono quindi a 192 casi con 197 donne uccise nel biennio indagato (di cui 83 nel 2017 e 114 nel 2018).
I dati dell’inchiesta sul profilo delle vittime
Età
Le fasce più colpite sono, in primis, la fascia di età intermedia 25-54 anni con una percentuale pari a 49,2, seguita dalle donne oltre i 55 anni comprendente la fascia di donne anziane attestate sul 39,6% e poi dalle giovanissime al di sotto dei 25 anni, per il 10,6% (lo 0,5% non rilevato). Le minorenni sono 7 pari al 3,5%, i cui autori sono i padri.
Occupazione
Il 48,8% circa delle vittime ha un reddito proprio desunto da un’occupazione (78 donne) o da una pensione (18 donne). Le disoccupate (29), le inattive (15) e le studentesse (8), che non hanno invece un proprio reddito di autonomia, sono il 26,39 %. Nel 24,8 dei casi la condizione lavorativa non è stata rilevata (49 donne).
Tra le donne che lavoravano, la maggior parte è costituita da impiegate (16), badanti (15) donne in prostituzione (7), operaie (7) e infermiere (5).
Nazionalità
Le donne sono al 78% italiane ed al 21% straniere (1% non rilevata), ma anche gli autori sono in maggioranza italiani.
Inoltre, l’83% delle uccisioni viene commesso da un uomo che ha la stessa nazionalità della vittima: in 136 casi, infatti, sia autore che vittima sono italiani e in 25 casi sono entrambi stranieri.
Nel 13%, invece, le nazionalità sono diverse e di questi, 14 casi su 25 sono stati commessi da un italiano ai danni di una straniera, mentre in 11casi avviene il contrario.
Le zone geografiche
Non emergono particolari differenze a livello territoriale. I femminicidi avvengono in comuni di ogni dimensione. Essi si distribuiscono, infatti, in modo proporzionale alla popolazione residente.
La relazione vittima-autore
Nel 70,1% dei casi la vittima è stata uccisa da un partner o da un ex partner.
La relazione di coppia è indicativa anche del movente dell’uccisione, ovvero la gelosia e il possesso. La situazione poi precipita nel fenomeno omicidiario quando il violento percepisce in vari modi di non avere più il controllo sulla donna, vuoi nella fase separativa , vuoi nella situazione di stato quando ad esempio la donna dà segni di maggiore autonomia o non soddisfa più a pieno i criteri comportamentali di soggezione imposti dall’uomo.
Nel 20% circa le donne sono uccise da un altro familiare: i figli (18 vittime, il 9,1%) o i padri (9 vittime, il 4,6%) oppure un altro parente (12 vittime, il 6,1%).
Nel restante 10% circa, le donne sono uccise da conoscenti, sconosciuti o clienti
Analizzando i dati dei partner e ex-partner come autori si rileva come: più della metà, ovvero il 57,4% delle vittime, sono state uccise dal partner che può costituire un marito, un compagno, un fidanzato o un amante (113 donne) . Di queste solo nel 77,9% dei casi vi era convivenza (88 donne).
Ma nelle relazioni di coppia dai fascicoli si evince che nel 38% dei casi vi era una intenzionalità espressa di separazione da parte della donna (4 coppie su 10 circa); ovvero in particolare nel 4,4% dei casi la coppia era separata di fatto, nel 9,7% la separazione era in corso e nel 23,9% la donna aveva espresso la volontà di separarsi. Questa valutazione porta a far lievitare il dato delle donne in separazione che passa dal 12,7% circa al 50,7 % dei casi di femminicidio, iscrivendo così anche la sola intenzione o comunicazione della volontà di separarsi come momento di elevato rischio per la donna.
Bisogna quindi valutare la separazione (25 donne, il 12,7 % dei casi) insieme anche alle separazioni di fatto o all’intenzione espressa di separazione (38% dei casi) che porta quindi a considerare, come per altro indicato dalla letteratura internazionale, che i femminicidi avvengono in modo pressoché paritario sia nelle relazioni in atto sia in quelle in cui vi è stata o vi è in fieri una separazione. Ma il dato allarmante riguarda proprio i casi in cui le donne hanno manifestato solo l’intenzione di separarsi perché questo avrebbe determinato nel breve volgere del tempo la loro uccisione (23,9% dei casi).
Gli autori (192 rispetto a 197 femminicidi)
Le tipologie socio-anagrafiche età e occupazione, nazionalità sono similari a quelle delle vittime. Si evince solo un numero minore di occupati e in attività (72 uomini, il 37,5% escludendo i pensionati) rispetto alle donne (78 donne, il 39,6%, escluse le pensionate). Il dato occupazionale, minore negli uomini, sottolinea un contrasto con quello della popolazione generale maschile, sempre più elevato nei tassi di attività lavorativa rispetto alle donne.
Le tipologie di lavoro negli uomini si invertono nella loro frequenza, rispetto a quelle femminili, indicando anche nelle donne un più elevato indice di scolarizzazione (dato questo che corrisponde a quello della popolazione generale). Le occupazioni più frequenti negli uomini sono infatti quelle di operaio a cui fanno seguito gli impiegati (rapporto invertito nelle donne). Tra gli autori abbiamo anche 9 appartenenti alle forze dell’ordine.
Dei 192 autori, oggetto di questa analisi, 67 (il 34,9%) si sono suicidati e i procedimenti penali quindi archiviati. Il suicidio risulta decisamente più frequente della media tra gli autori padri e i partner. Un fattore che appare piuttosto collegato al fenomeno del suicidio degli autori di femminicidio è il possesso di un porto d’armi.
È stata rilevata in 52 casi (il 27,1%) anche la presenza di tre specifiche tipologie di abuso da parte dell’autore, di alcool, droga, e psicofarmaci.
In un terzo circa dei casi (62) l’autore aveva precedenti penali o giudiziari. Inoltre, in 13 (il 6,8 % dei casi) erano stati anche sottoposti a misure cautelari per reati contro la persona.
Per quanto riguarda l’uso del mezzo omicidiario si evince che: il 28% delle donne è stato ucciso con modalità efferate. Queste condizioni si sono verificate più frequentemente quando l’omicida era il cliente / spacciatore o un altro conoscente della donna.
La modalità di uccisione più frequente è l’accoltellamento (32%), seguono l’uso di armi da fuoco (25%) ,poi le mani nude o con oggetti contundenti usati per picchiare/colpire la donna con lo scopo di provocarne la morte. Tra gli oggetti usati, che sono stati rilevati nel 54%dei casi, risultano: spranghe, tubi o pestelli di ferro (5), bastoni (5), martelli) (3), asce (2), pietre (2), mazza da baseball(1), bottiglia di vetro (1), batticarne (1).
Sempre escludendo gli autori non identificati e quelli che si sono suicidati dopo aver compiuto il femminicidio, il 64% degli autori ha ammesso il fatto (89 su 139).
Le denunce
- Il 63% delle donne uccise non aveva parlato della violenza subita.
- Il 22% ne aveva parlato con qualcuno.
- Soltanto il 15% (29 donne su 197) invece aveva denunciato.
Relativamente al 63% delle donne uccise che non aveva riferito a nessuno, comprese le autorità, delle violenze subite, bisogna valutare la grande difficoltà delle donne nel cercare e trovare aiuto. Le donne che si aprono con qualcuno, segnalano, o denunciano, la violenza subita (73 su 196, il 37%) tendono a farlo, in primo luogo, con persone a loro vicine.
Di questi casi, 29 (il 15%) proseguono nella denuncia, ma 44 (il 22%) rimangono nel solco di confidenze ai familiari o amici o di informazioni date a soggetti terzi, tra cui anche responsabili di servizi pubblici che trascurano i loro obblighi di segnalazione come: i servizi sociali, 15 donne; il pronto soccorso, 13 donne; e il medico di base, 9 donne.
Le donne hanno denunciato più volte
Per quanto riguarda, invece, il 15% (29 donne) che ha sporto denuncia per precedenti violenze subite, 27 avevano denunciato più volte, di queste: 17 fanno una seconda denuncia ed ancora 10 fanno una terza denuncia.
In aggiunta, quando avviene la denuncia solitamente la donna lo fa per più di un solo reato.
I reati maggiormente denunciati sono per il 35% maltrattamenti in famiglia, per il 27% minaccia, anche con armi, per il 23% lesioni personali, per il 18% atti persecutori e per il 7% violenza sessuale.
In media, tra la prima denuncia e il femminicidio passano circa 2,4 anni. La mediana, tuttavia, è sensibilmente minore, e inferiore all’anno (pari a 324 giorni). Vi sono, poi, 6 casi in cui tra la denuncia e la morte della donna trascorre un tempo che si attesta ben al di sopra dei 4 anni.
Dalle informazioni raccolte, sia attraverso le denunce sia attraverso le testimonianze delle persone informate dei fatti in totale 73 donne (29 che hanno denunciato e 44 che ne hanno solo parlato), si evincono anche i dati che illuminano la condizione di rischio che la donna viveva prima della sua uccisione. La maggior parte delle donne segnala infatti “di temere per la propria vita (il 60%, 43 su 73), di avere subito minacce di morte (il 53,4%, 39 su 73), di percepire il soffocante senso di possesso dell’uomo (il 43,8%, 32 su 73), di avere verificato una escalation della violenza (il 30,1%, 22 su 73), di sapere che l’uomo aveva un’arma (il 20,5%, 15 su 73). In due casi, poi, la donna segnala l’intento suicida dell’uomo, e in un solo caso di essere stata dissuasa dai familiari dal denunciare”.
Delle donne che avevano riferito della violenza, il 75% aveva figli (53 su 71, escludendo due donne uccise dai figli).
Queste ultime, nel riferire della violenza alle Autorità o alle persone vicine, avevano comunicato:
– in 26 casi (il 49%), di temere per la vita dei figli, oltre che per la propria;
– in 6 casi (l’11,3%), di temere che se avessero denunciato le avrebbero potuto « togliere i figli ».
I figli orfani sono 169, negli anni 2017/18
Un terzo (55 su 169, il 32,5%) è rimasto orfano anche del padre,
Complessivamente, i figli delle donne vittime sono 172, poiché 3 di questi sono stati uccisi insieme alla madre. Il 74% dei figli rimasti orfani di madre (125 su 169) erano della coppia, mentre nel restante 26% essi erano solo della vittima.
Il 46,7% dei figli sopravvissuti (79 su 169) aveva assistito alle precedenti violenze del padre sulla madre e, di questi, la maggioranza era minorenne (43 su 79, il 54,4%).
Inoltre, il 17,2% dei figli sopravvissuti (29 su 169) era presente al femminicidio, dei quali il 72,4% era minorenne (21 su 29), e addirittura il 30% dei figli sopravvissuti (50 su 169) ha trovato il corpo della madre (19 erano minorenni).
Gli esiti dei procedimenti penali
Si registrano un’archiviazione nel 37% dei casi(79), e un rito abbreviato nell’81,2% dei processi.
L’archiviazione in maggioranza si registra nei casi per morte del reo (58 casi), in 5 casi l’autore è rimasto ignoto, e i rimanenti casi non sono chiari.
Nelle sentenze definitive sono più numerose le condanne inferiori ai 20 anni di quelle superiori ai 30. A questo proposito l’inchiesta mette in luce come siano spesso date le circostante attenuanti: “Attraverso l’applicazione delle circostanze attenuanti (generiche o vizio parziale di mente) può essere fortemente ridimensionata la pena prevista dal Codice penale che, come già rilevato, è in astratto l’ergastolo se vengono contestate con il femminicidio le aggravanti che ricorrono quasi sempre, a partire da quella della relazione di parentela. Tuttavia, sebbene l’articolo 90 del codice penale stabilisca che gli stati emotivi e passionali non incidono sull’imputabilità, in diverse sentenze (cfr. 4.2.1) emerge che essi vengono valorizzati, con quasi esclusivo riferimento alla gelosia e alla rabbia, nel diverso ambito della commisurazione della pena, con riduzioni che arrivano sino a un terzo. Talvolta le attenuanti generiche vengono applicate anche colpevolizzando la vittima, ad esempio quando il femminicidio è stato ritenuto una reazione al suo comportamento provocatorio rispetto ad un imputato che è stato nello stesso tempo « illuso e disilluso » provocandone profonda delusione e risentimento” (pag.71).
Gli esiti definitivi dei 118 processi arrivati a sentenza sono: 98 sentenze di condanna (81,5%), 19 assoluzioni (16%) e 1 patteggiamento. Di queste 118 sentenze, 98 sono da considerarsi definitive, e comprendono 81 condanne e 17 assoluzioni, mentre 20 sono ancora pendenti, e comprendono 17 condanne, 2 assoluzioni e 1 patteggiamento.
I 19 casi di assoluzione
In 16 casi le sentenze assolutorie si sono verificate per totale incapacità di intendere e di volere e comprendono due gruppi: quelli in cui l’imputato era già in cura per disturbi psichiatrici precedenti; quelli in cui, invece, non era mai stato preso in carico da un centro di salute mentale o comunque non aveva manifestato alcuna patologia pregressa al delitto.
“Al primo gruppo sono riferibili 6 casi (4 del 2017 e 2 del 2018) in cui risulta un’antecedente diagnosi psichiatrica dell’imputato per psicosi dissociativa o per schizofrenia di tipo paranoide per le quali era in cura. In tutti, autore e vittima erano conviventi e la donna uccisa si prendeva cura dell’imputato.
Al secondo gruppo sono riferibili 10 casi (8 del 2017 e 2 del 2018). in cui l’imputato non aveva disturbi antecedenti certificati, ma questi erano stati diagnosticati solo dopo il suo arresto a seguito della custodia cautelare in carcere e della valutazione da parte di psichiatri nominati dall’Autorità giudiziaria. Altri due casi l’assoluzione è stata data per insussistenza del fatto. In un caso perché la vittima si sarebbe sparata per volontà suicida e nell’altro perché sarebbe morta a seguito di una caduta, entrambe impugnate (in un caso dalla parte civile e nell’altra dal Pm) ed attualmente pendenti in appello; in un altro caso l’assoluzione è stata determinata ‘per non aver commesso il fatto’ perché i giudici hanno ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova che l’imputato fosse l’autore del femminicidio” (pag. 78).
Discussione dei dati
Dai dati biografici il profilo delle donne, come quello degli autori, ci indica che non ci sono tipologie specifiche di donne e uomini, né connotati specifici che riguardano l’appartenenza territoriale geografica o le diverse nazionalità e religioni di vittime e carnefici, ma che il fenomeno è trasversale nella popolazione generale.
L’unico dato che sembra emergere a carico degli autori è un maggior tasso di disoccupazione al momento del femminicidio, rispetto alla popolazione generale. Questo dato fa pensare non tanto ad un fattore causale della violenza, che in tutte le situazioni si protrae per anni e anni (quindi anche in una condizione occupazionale dell’uomo) e compare, o viene percepito dalla donna, già all’epoca della nascita dei figli (come da dati internazionali e nazionali), quanto piuttosto ad un possibile innesco della volontà separativa della donna. La perdita del lavoro dell’uomo coincide spesso con la valutazione costi-benefici della relazione di coppia (con saldo negativo per i benefici) che una donna vittima di violenza può fare, in rapporto alla perdita del lavoro del partner, dopo anni di tolleranza delle condotte violente e oppressive in nome dell’unità familiare, della necessità di un supporto economico, e del ‘bene dei figli’.
Le donne, nella fascia di età prevalente che va dai 25 ai 54 anni sono nella maggioranza dei casi madri con figli minori, che rimarranno segnati a vita dall’evento omicidiario. I figli sopravvissuti e non (3 sono uccisi per mano del padre insieme alla madre) sono 172 per 197 donne.
Il dato che siano principalmente madri le donne assassinate induce ad una riflessione, che si riconnette con l’altra inchiesta della Commissione sulla vittimizzazione secondaria che ha messo in luce il fatto che le donne sono vittimizzate nei tribunali civili.
Le donne vanno tutelate anche nel loro ruolo di madri quando vittime di violenza, il che significa che i tribunali civili e minorili in cui si discute l’affido dei figli minori non possono applicare gli stessi metodi e criteri che applicano nelle situazioni in cui non vi sia violenza. Il rischio che le donne corrono è elevato e quello dei figli anche, perché quando non vengono uccisi, portano per sempre i segni di un trauma irreversibile.
Dall’inchiesta sul femminicidio emerge invece un comportamento, per i casi in cui la violenza era stata rilevata, di totale sottovalutazione e negazione della pericolosità delle condizioni di vita di donne e minori: “Ed infatti in alcuni casi per le donne prese in carico dai servizi sociali (anche su richiesta di altre autorità) non è stato considerato il contesto di violenza in cui vivevano con i loro figli, ritenendo comunque prioritario il mantenimento del rapporto genitoriale con l’autore delle violenze”.
Un altro dato riguarda le donne in prostituzione che costituiscono spesso un sommerso del fenomeno femminicidio, in quanto le indagini non sono fatte in modo adeguato e rimangono sconosciuti gli autori, più spesso sono stigmatizzate e trattate come donne di serie b:” Le vittime di femminicidio quando svolgono attività di prostituzione vengono chiamate prostitute e non con nome e cognome, così vittimizzandole e stigmatizzandole”. Inoltre nell’inchiesta vengono rimarcate le condizioni di particolare efferatezza delle loro uccisioni “Forme di inaudita crudeltà sul corpo della vittima sono state riscontrate soprattutto su donne che svolgevano attività prostitutiva, o quando il movente principale è rappresentato dalla punizione della vittima rispetto all’esercizio di un minimale diritto di libertà: più grave è stato ritenuto l’affronto ai valori socio-culturali dell’uomo, più brutale è stata la morte della donna” .
L’interesse di questa indagine oltre l’accurata analisi statistica, è quindi nella valutazione dei comportamenti sia della magistratura, sia di altri soggetti, nel confronto delle plurime denunce delle donne, e delle loro esternazioni sui timori per la propria vita.
Le donne nel 37% dei casi, come emerge dall’indagine, hanno rilevato a parenti, amici, servizi e Autorità Giudiziaria, quelli che sono considerati a livello internazionale i fattori di rischio per il femminicidio, senza che nessuno sapesse leggerli e prenderli in carico; né i familiari o gli amici, attivando maggiormente le donne nell’autotutela o nella richiesta di aiuto a istituzioni e centri anti-violenza o nella denuncia; né i servizi sociali e sanitari che pure avevano obblighi di segnalazione di condotte in cui erano ravvisabili reati; né poi i pubblici ministeri e i giudici delle indagini preliminari assolutamente disinformati sia della valutazione del rischio femminicidio sia più in generale delle convenzioni e leggi a tutela delle donne (in primis la Convenzione di Istanbul, legge 77/13).
Tra i vari fattori che si sarebbe dovuto prendere in considerazione, va segnalato come primo fattore la paura di essere uccise, che le donne avevano comunicato. L’inchiesta infatti ci dice che nel 60% dei casi le donne uccise avevano espresso fortemente, nelle denunce o nelle loro esternazioni ad altri soggetti, la loro paura di essere uccise dal partner, perché avevano ricevute plurime minacce, perché ne avevano conosciuto la potenza lesiva in precedenti aggressioni e violenze (compresi i tentativi di strangolamento o le mani al collo che frequentemente si registrano nei referti ospedalieri) o le spinte o la violenza sulle cose, ecc. ecc. Ma questa paura non viene mai presa in considerazione e la si considera, sbagliando, come frutto di una fragilità femminile che porta le donne a sopravvalutare un pericolo.
Poi emerge dalle carte che secondariamente le donne hanno riferito di aver subito plurime minacce di morte; colpisce a questo riguardo come i magistrati, pronti a prendere in seria considerazione le minacce di morte della criminalità organizzata, tanto da fornir immediate scorte a personaggi pubblici, siano così sottovalutanti e superficiali se le minacce di morte provengono da un ambiente familiare, nonostante le statistiche ci dicano che ogni tre giorni una donna viene uccisa in questo ambito.
I magistrati: alcuni casi e le criticità relativamente all’inapplicazione di misure che potevano ridurre il rischio femminicidio
Di fatto nei casi delle denunce formalizzate (29 su 197) che non sono riuscite a fermare i femminicidi leggiamo che in alcun di queste siano presenti gravi sottovalutazioni del rischio femminicidio: “Con specifico riguardo poi ai 15 casi dei quali sono stati acquisiti anche gli atti relativi al precedente procedimento penale iscritto a seguito di denuncia presentata dalla stessa vittima, sono state rilevate alcune criticità sul piano della adeguatezza delle misure di protezione delle persone offese, da ricondursi in particolare alla mancata richiesta di applicazione di misure cautelari, anche a fronte di espresse sollecitazioni da parte della Polizia giudiziaria in caso di evidente pericolo per la vittima. E' emerso infatti che in 6 casi su 15 il Pubblico Ministero aveva richiesto misure cautelari a carico dell’uomo violento (di cui la custodia in carcere in 1 caso, negli altri 5 misure non detentive ). Peraltro solo nella metà dei casi questa richiesta è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari Tale circostanza sembra confermare la sottostima di questi reati derivante principalmente dalla non del tutto adeguata formazione sul piano in particolare della valutazione del rischio. Emblematici sono a tal proposito alcuni dei casi considerati. In un primo caso una donna aveva presentato nell’arco di pochi mesi e con un crescendo di violenze, plurime denunce per reati gravi (di cui due tentativi di strangolamento), l’ultima 7 giorni prima della sua morte. In questo caso non solo la Polizia Giudiziaria, pur intervenuta, non aveva proceduto all’arresto in flagranza dell’autore dei delitti, ma il Pubblico ministero non aveva neppure richiesto alcuna misura cautelare. La donna, in fase di separazione, era stata uccisa davanti al bambino di pochi anni da parte del marito che poteva vedere il figlio senza restrizioni . In altri tre casi il Pubblico Ministero non aveva chiesto per mesi misure restrittive nei confronti dell’uomo violento, nonostante la gravità e la reiterazione dei fatti denunciati e la insistente sollecitazione della Polizia giudiziaria, provvedendovi con urgenza solo dopo la morte della donna. In un provvedimento si legge che non era stata richiesta la misura cautelare, nonostante la denuncia della giovanissima vittima di violenza sessuale reiterata da parte del padre convivente, in quanto la ragazza riferiva di non essere preoccupata. Infatti, nonostante il padre avesse chiesto di fare sesso due volte, la stessa si era rifiutata e la questione si era chiusa lì..
Nei 15 casi esaminati si riscontrano infine una ridotta e tardiva applicazione di alcuni ulteriori istituti processuali posti a presidio della tutela delle vittime dei reati di violenza di genere. Oltre allo scarso ricorso all’istituto dell’incidente probatorio per l’ascolto delle vittime si rileva come frequentemente l’attività di ascolto delle persone offese – pur a fronte di casi complessi e delicati – sia stata delegata dal Pubblico Ministero al personale di Polizia giudiziaria, non sempre adeguatamente specializzato. Si registra, poi, una scarsa applicazione del braccialetto elettronico (da ricondursi anche alla a oggettiva difficoltà di reperimento di tali strumenti di controllo) nei casi di arresti domiciliari, sebbene il codice di procedura penale lo prevedesse come obbligatorio imponendo al giudice di motivarne, in fatto, perché ritenuto non necessario. Ancora, si rilevano la scarsa impugnazione davanti al Tribunale del riesame dei provvedimenti di rigetto delle richieste di misure cautelari e il mancato monitoraggio o svolgimento di attività investigativa dopo le rimessioni di querela o le ritrattazioni o i forti ridimensionamenti che notoriamente sono spesso determinati da paura della vittima e da gravi pressioni e violenze dell’autore. Non risulta, ad esempio, il ricorso alle intercettazioni telefoniche, strumento, invece, utilizzato per tutti i reati in quanto consente la valutazione complessiva del contesto e del rischio per l' incolumità personale della vittima” .
I servizi sanitari, alcuni casi
Dall’inchiesta emerge un j’accuse rispetto ai servizi sanitari che dovrebbero organizzare e istituire nei pronto soccorso i percorsi dedicati alle vittime di violenza secondo quanto previsto dagli artt. 790/91 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Della situazione dei Pronto Soccorso e dei servizi dedicati alla salute si è occupata un’altra inchiesta della Commissione, rilevando una situazione di applicazione della legge del 2015, sui percorsi dedicati alle vittime di violenza, a macchia di leopardo sul territorio nazionale .“Nei pochi casi in cui questo è avvenuto, talvolta persino rappresentando che l’autore di quelle fratture o bruciature o violenze sessuali fosse una persona della famiglia, non risulta dagli atti che le donne abbiano trovato percorsi specifici, protocolli che le prendessero in carico anche con la finalità di metterle in protezione o di sostenerle nonché medici specializzati: sono state trattate tutte in modo routinario e rimandate a casa, e questo nonostante nel 2017 siano state adottate Linee guida nazionali per Asl e Ospedali proprio per assumere una tempestiva e adeguata presa in carico delle donne vittime di violenza”.
Stessa situazione di non conoscenza delle leggi e dei propri doveri professionali si evince anche per i medici di base: “Dall’indagine è emerso infatti che molte donne avevano confidato solo a loro gli atteggiamenti vessatori subiti al fine di chiedere la prescrizione di farmaci per l’insonnia o per gli attacchi di panico o una qualsiasi forma i supporto; i disagi comportamentali o fisici dei bambini della coppia; le preoccupazioni per la condizione di salute mentale del marito. Specie rispetto a coppie anziane, è risultato che i medici di famiglia conoscono anche la storia clinica del futuro femminicida, poiché raccolgono le sue confidenze circa i suoi stati di disagio” .
I servizi sociali
Come i servizi sanitari anche i servizi sociali mostrano nell’inchiesta sul femminicidio una totale mancanza di cognizione della pericolosità della violenza domestica esercitata da un partner o ex partner e una mancanza di conoscenza dei loro obblighi professionali a termine di legge: “Infatti, da alcune relazioni dei servizi sociali acquisite nell’inchiesta, è risultato anche che, nonostante tali soggetti fossero a conoscenza della violenza esercitata dall’uomo, non abbiano escluso l’affidamento al padre dei minorenni (contrariamente a quanto previsto dall’articolo 31 della Convenzione di Istanbul); abbiano adottato lo strumento della mediazione tra la vittima e l’autore dei reati (contrariamente a quanto previsto dall’articolo 48 della Convenzione di Istanbul); non abbiano provveduto alla segnalazione alle autorità competenti (Polizia giudiziaria e autorità giudiziaria) anche a fronte di gravi violenze (contrariamente a quanto previsto dall’articolo 331 del codice di procedura penale). Dalla lettura di alcuni atti giudiziari è emerso che, in diverse occasioni, l’autorità giudiziaria penale non aveva adottato provvedimenti restrittivi nei confronti del maltrattante proprio in virtù delle relazioni redatte da alcuni assistenti sociali i quali, pur avendo sentito le vittime, ne avevano forte-mente ridimensionato il racconto, talvolta mettendolo in dubbio e valorizzando o giustificando persino la condotta dell’uomo violento”.
Le donne: come difendersi
Da questi dati si evidenzia da un lato come le donne si tengano lontane dalle istituzioni e denuncino in poche o in poche rivelino a terzi le violenze subite in famiglia, e dall’altro lato come le poche denunce spesso attivino un processo di vittimizzazione secondaria ( le donne non sono credute, i loro timori non sono presi inconsiderazione, le loro denunce sono sottostimate e svalorizzate, ecc.). IN questo quadro poco favorevole, le donne devono comunque trarre delle indicazioni per regolare i propri comportamenti con il violento e migliorare le loro competenze al contrasto della violenza.
Dall’inchiesta emerge infatti una quota di donne che ritiene di poter uscire dalla violenza innescando un percorso separativo e nel contesto in cui comunica al partner violento la sua volontà di separarsi, o avvia una separazione, viene uccisa. Si rileva quindi come un ulteriore fattore di rischio il separarsi da un partner violento senza le dovute condizioni di sicurezza. Nel momento in cui il processo decisionale è avviato o concluso la donna prima di qualsiasi comunicazione al partner, di cui teme la reazione aggressiva, è bene che pensi ad una forma di messa in sicurezza per sé e i figli. In questo caso può giovarsi dell’aiuto dei Centri anti-violenza con cui concertare un’adeguata uscita dalla relazione violenta, con un’attenta valutazione del rischio. L’inchiesta ci rimanda invece una fotografia in cui i centri anti-violenza sono contattati dalle donne in modo residuale (2,5% circa).
Per tutti gli operatori dei vari contesti, socio sanitari e giudiziari, valgono poi le seguenti raccomandazioni:
- saper leggere senza sottovalutarli i vari alert che le donne danno alle istituzioni sulla loro situazione di pericolo e di rischio, che nel 75% dei casi coinvolge anche i figli;
- conoscere e rispettare tutte le indicazioni normative sulla violenza contro le donne e i minori e in particolare modo la Convenzione di Istanbul;
- combattere contro ogni pratica socio-assistenziale e psico-giudiziaria che penalizza le donne e le dissuade dal denunciare (come quella dei tribunali civili che decidono dell’affido dei figli minori, misconoscendo le situazioni di violenza, così come emerso anche nell’altra inchiesta della commissione sulla vittimizzazione (già citata).
- In particolare il settore giudiziario deve saper sviluppare nel contesto dei reati domestici, pari per gravità ad altre forme di criminalità, quelle misure di tutela, ai primi segnali di rischio omicidiario, come le minacce di morte, l’escalation della violenza non solo fisica, ma anche psicologica e lo stalking, e la paura delle donne di essere uccise dal partner.
Per quanto riguarda le modifiche delle prassi del contesto giudiziario la Commissione raccomanda:
- la previsione dell’arresto, anche fuori dei casi di flagranza, per i reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, lesioni e atti persecutori;
- la possibilità di disporre le intercettazioni in presenza di sufficienti indizi circa la commissione dei delitti sopra citati;
- l’obbligo di disporre l' incidente probatorio per l’ascolto delle vittime;
- l’obbligo di trasmissione del verbale di incidente probatorio relativo alle dichiarazioni rese dal minorenne o dalla donna vittima di violenza domestica al giudice civile e al giudice minorile;
- l’obbligo di applicare i dispositivi elettronici di controllo per l’indagato sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, salva specifica ed adeguata motivazione fondata su elementi oggettivi;
- l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni per gli autori dei reati di violenza di genere;
- l’obbligo, ove sia disposto l’allontanamento dell’indagato dall’abitazione familiare, dell’ingiunzione di pagamento periodico di assegno previsto dall’articolo 282-bis, comma 2, del codice di procedura penale a favore delle persone conviventi, salva oggettiva impossibilità per mancanza di redditi dell’obbligato (NdR: l’obbligo di sospendere la responsabilità genitoriale).
In allegato l'articolo integrale con note
Allegati