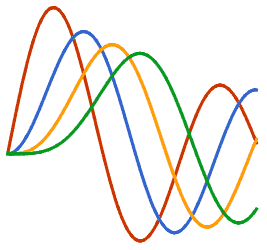Fragilita, storie, diritti - Michela del Vecchio - 15/02/2017
Perché fare testamento? – Michela del Vecchio
Sin dai primi studi giuridici universitari associavo la successione testamentaria alla volontà di una persona, oramai avanti nell'età, di affidare agli affetti più cari i propri beni per evitare che si disperdessero: in altri termini lasciare loro un "ricordo". "Fare testamento" dunque veniva dalla sottoscritta associato alla mera disposizione dei propri averi.
Nel corso degli studi è mutata la mia opinione del "fare testamento" ma certamente è rimasta ancorata all'idea di disposizione patrimoniale, di volontà di non dispersione di quanto costruito nella vita e di contributo e memoria da lasciare alle persone vicine (parenti e non).
La vita professionale, poi, mi ha allontanato dagli studi sulle successioni impegnata a leggere ed interpretare più volontà contrattuali che ultime volontà né la mia vita personale, almeno fino ad oggi, mi ha mai costretta a rivolgere l'attenzione alle successioni.
E ciò fintanto che il caso e la mia personale curiosità non mi hanno spinto a conoscere la c.d. DAT (dichiarazione anticipata di trattamento medico) confrontandomi, leggendo, consultando ed apprendendo l' "equiparazione" delle stesse al testamento (nella specie biologico).
Se di testamento si tratta però, le DAT non necessariamente sono esternate da persona anziana né soprattutto implicano dei "lasciti" in termini strettamente patrimoniali. Al contrario.
La "scoperta" per me più stravolgente è che le dichiarazioni di cui trattasi non necessariamente erano esternate da persone gravemente malate o prossime a delicati interventi chirurgici. E dunque, perché decidere sui trattamenti medici cui sottoporre o meno il proprio corpo. Non è tale decisione una disposizione stessa del proprio corpo?
La risposta è chiaramente varia a seconda degli orientamenti anche religiosi e/o spirituali di ciascuno di noi.
Nell'approfondire la ricerca e nel porre domande a medici e pazienti mi è stato consegnato un testamento biologico: una descrizione del vissuto di un medico e la conseguente sua volontà nelle ipotesi di inattività o inabilità o comunque di difficoltà anche transeunte di carattere fisico o psichico.
Nell'indicato testamento si affermava la sacralità della vita, la difesa dei deboli, la relatività dell'accanimento terapeutico ma anche delle determinazione ad una celere risoluzione della sofferenza.
Un testo ricco di riflessioni e spunti in cui è evidente la stretta soggettività delle volontà che, in un testamento quale quello letto (e più in generale nelle D.A.T.), non necessariamente devono essere "ultime" (nel senso letterario del termine) ma certamente cogenti ed imperanti: al verificarsi della condizione ivi prevista (malattia, indebolimento, lutto, solitudine, pazzia e via discorrendo) è assolutamente doveroso attenersi alle prescrizioni lasciate.
"Fare testamento" dunque come "lasciare chiaramente scritte le proprie volontà non solo in merito a patrimoni ma anche e soprattutto relativamente ai propri sentimenti, alle proprie decisioni mediche e non, ai propri desideri ed alle proprie possibilità".
"Fare testamento" non per motivi di "continuità di famiglia" ma per la necessità di dettare regole sulla propria vita in un momento in cui si gode ancora di piena autonomia decisionale.
"Fare testamento" dunque non solo in punto di morte o a fine vita ma in qualunque momento della propria quotidiana esistenza e tutte le volte che si ravvisi il desiderio di comunicare ora per l'avvenire la volontà in merito ai trattamenti sanitari e non cui essere o meno sottoposti nel verificarsi di una condizione di difficoltà.
Quali comportamenti adottare in tali condizioni non è prescritto né deve esserlo in alcuna norma ma è lasciato alla sensibilità di ognuno, al proprio vissuto ed alla propria spiritualità ma "fare testamento" quando si è nella piena facoltà di determinazione della e sulla propria esistenza è certamente un'impronta che si lascia della propria vita per un avvenire non certo né nell'an né sul "quomodo".