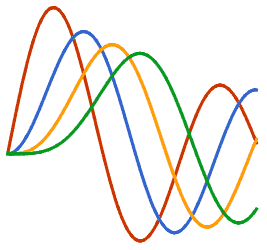Deboli, svantaggiati - Redazione P&D - 13/01/2022
La legge 68/99 funziona davvero - Edoardo Romano Scotti
- La Legge n.68/99
Il nostro sistema normativo si è occupato della tutela lavorativa dei disabili molto tardi rispetto alle altre minoranze ed altre forme di discriminazione. Fino alla fine degli anni 60, infatti, l’argomento è stato trattato come un tema relativo alle singole vicende di quei lavoratori che continuavano a dare il loro apporto al sistema produttivo nonostante le menomazioni che potevano aver riportato in servizio o in guerra.
Si trattava dunque di qualcosa che, per il senso comune, veniva relegato allo stretto ambito della filantropia o del volontariato, giammai - fino ad allora - come qualcosa che potesse far emergere una spinta egualitaria all'interno della nostra società, come vorrebbe il dettato costituzionale. Non vi era dunque un vero e proprio riconoscimento del diritto dovere del lavoro anche per i cittadini colpiti da menomazioni o disabilità di vario tipo.
Questa grave mancanza o sottovalutazione del problema ha portato a non avere nemmeno una definizione, fino a quell'epoca, di diritto del lavoro per chi fosse a tutti gli effetti disabile. In un certo senso era impensabile avere un sistema di diritti riconosciuti se ne mancava perfino la definizione sul dizionario. Una normazione prelude ad una serie di diritti riconosciuti che fino a quel momento evidentemente potevano trarre forza solo dalle normative sovranazionali. Per poter giungere ad una qualsiasi salvaguardia del diritto del lavoro delle persone disabili il nostro paese, l’Italia, ha sempre avuto bisogno del faro guida delle normative internazionali, non importa che si trattasse della Convenzione ONU sui diritti dei disabili o della copiosa giurisprudenza comunitaria che ha avuto l'indubbio merito sia di ampliare l'orizzonte dei diritti sia di inquadrare in modo coerente e unitario una serie di rimedi attuabili in caso di condotta discriminatoria in ambito lavorativo.
Nel nostro ordinamento il principio di ancoraggio che viene a tutt’oggi seguito è quello della capacità lavorativa residua: questo, inevitabilmente, finisce per pregiudicare sia i lavoratori con disabilità più grave, sia quelli con disabilità meno grave.
L'abbassamento della soglia di invalidità potrebbe essere una soluzione rispetto ad alcune discriminazioni che, nei fatti, si verificano. Ma se il problema della violazione dei diritti si fa sentire anche per le persone che hanno un grado di disabilità non elevato, si potrebbe dire, a giusta ragione, che, purtroppo, essa sia doppia per coloro che sono considerati disabili gravi. Infatti, la presenza di norme di salvaguardia, o anche di norme sul collocamento obbligatorio (la legge 68/99 o la legge 67/2006), non impediscono, anche all’interno di un sistema che potremmo dire efficiente ed evoluto, che si possano formare sacche di discriminazione basate sulla mancanza di principi chiari in materia di reclutamento e di formazione del lavoratore disabile.
Sembra quasi superfluo osservare come anche un sistema perfettamente orientato alla non discriminazione possa finire poi per compiere discriminazioni palesi in campo lavorativo laddove non si riescano a recepire le potenzialità e anche la possibile spinta produttiva dei singoli lavoratori disabili. Non sto dicendo che tutti i disabili dovrebbero lavorare, ma semplicemente che coloro che se la sentono dovrebbero essere maggiormente presi in considerazione, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista economico, cosa che - evidentemente - ad oggi non avviene.
Si è dimostrato come la legge sul collocamento mirato 68/99 possa in realtà raggiungere gli obiettivi che il legislatore si era prefissato se affiancata, però, da un progetto strutturato da parte degli enti regionali e - inutile dirlo - da un budget che possa adeguatamente soddisfare gli oneri di spesa progettuali. Per fare in modo che un progetto regionale si riveli all'altezza, occorre però una concreta sinergia tra l’Ente interessato, i soggetti presi in carico e talune realtà private.
L’ adeguata applicazione della legge di cui si discute può portare, secondo molti, all'instaurazione di quel circolo virtuoso che, almeno in parte, potrebbe contribuire all' abbattimento di alcune barriere sociali che si frappongono tra i lavoratori disabili, la loro emancipazione e il loro diritto al lavoro. Certamente, secondo chi scrive, il collocamento deve andare verso una procedura per così dire personalizzata e dunque tenere conto delle potenzialità dei singoli lavoratori con disabilità. Appare chiaro come una valutazione in questi frangenti non possa mai tendere a generalizzare, ma deve essere il più possibile particolareggiata, perché, purtroppo, molteplici sono i tipi di disabilità e dunque anche il percepire l’apporto di un singolo, in una determinata realtà lavorativa, non può essere altro che il frutto di un'elaborazione ragionata, tendente a mettere insieme tutta una serie di fattori che possono anche non dipendere dal valore o dalla professionalità del singolo lavoratore con disabilità.
Nell'instaurare un rapporto di lavoro proficuo, purtroppo, può giocare un grande ruolo in negativo il fattore ambientale. Magari i responsabili di un ente o un'amministrazione reclutano un lavoratore con disabilità bravissimo ma poi, nella loro sede, non sono in grado di farlo muovere, o farlo interagire adeguatamente con i colleghi e ciò può vanificare quasi del tutto le potenzialità del lavoratore.
Porto questo esempio per dimostrare come la personalizzazione e il conoscere le caratteristiche del lavoratore non siano, in questi casi, elementi accidentali del rapporto di lavoro, ma elementi fondanti che, se ignorati, potrebbero portare al naufragio di un qualsiasi progetto di integrazione lavorativa. Secondo me, nella mia esperienza, due sono i pericoli principali: il primo potrebbe essere quello di reclutare un lavoratore disabile, senza poi mettergli a disposizione uno spazio di lavoro adeguato, in cui possa gestirsi il più possibile autonomamente; il secondo reclutare un lavoratore disabile senza inserirlo a pieno titolo nel gruppo di lavoro. Dunque, anche in quest'ottica, si rivela d’aiuto guardare alla legge 68 /99, perché scegliere il posto di lavoro più adatto, secondo lo spirito della norma, serve ed ha lo scopo ultimo di limitare il più possibile gli effetti negativi dell'handicap, favorendo l'inserimento sia nell'organizzazione (aziendale o pubblica) sia nella società.
Così, anche l'evocato adattamento dei posti di lavoro non appare di secondaria importanza. Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, fortunatamente sembra che, almeno per quel che riguarda le amministrazioni pubbliche, siano molteplici i bandi orientati a fornire contributi per colmare questo tipo di gap. Naturalmente però lo scopo di una buona legge è anche quello di estendere determinati tipi di benefici a tutti i lavoratori, indipendentemente che siano lavoratori pubblici o privati.
Altro punto della legge da considerare positivamente, sia sotto il profilo giurisprudenziale sia sotto il profilo normativo, è il fatto che l'assunzione o il reclutamento non possono essere mai confusi con un intervento di tipo assistenziale dal momento che la stessa legge prevede che il datore di lavoro, una volta che il lavoratore si sia rivelato inidoneo alla mansione, non abbia alcun obbligo di riassunzione nei suoi confronti. Quindi, una volta di più, il principio ispiratore della legge appare quello di mettere il lavoratore nelle migliori condizioni possibili, ponendo però in capo al lavoratore medesimo, giustamente, l'obbligo di adempiere diligentemente alla prestazione richiesta dal contratto.
2. Progetti regionali e ampliamento delle competenze del lavoratore con disabilità.
L'analisi dei possibili interventi per raggiungere la piena integrazione dei lavoratori disabili ci porta ad analizzare quali prospettive offrano i progetti regionali. Innanzitutto bisogna chiarire se i progetti posti in essere da una pluralità di regioni italiane siano realmente finanziati e concretamente in grado di raggiungere gli obiettivi fissati nei rispettivi programmi. Sicuramente il concreto successo dei progetti regionali sull'occupazione dei lavoratori disabili anche questa volta è legato indiscutibilmente al budget messo disposizione dalle regioni. Dunque, ad un determinato budget, corrisponderà un adeguato numero di soggetti occupati, a patto che la procedura utilizzata sia trasparente, in linea col progetto iniziale e non viziata da conflitti d’interesse.
Dopo avere esaminato una pluralità piuttosto ampia di progetti regionali, credo nel mio piccolo, di essere riuscito a capire quando l'obiettivo di un progetto regionale si possa considerare raggiunto. Un obiettivo è raggiunto quando, ad esempio, il Comune di x assume due lavoratori disabili provenienti dalla cooperativa Delta su impulso del progetto della Regione di y.
Quanto riportato nell'esempio andrà sicuramente annotato nel rapporto regionale su occupazione e disabilità come obiettivo raggiunto, annotando scrupolosamente sia il budget, sia i lavoratori impiegati, sia i costi aggiuntivi e la trafila di reclutamento (come mi è capitato più volte di leggere nei report molto dettagliati della regione Emilia Romagna).
La principale obiezione che si porterebbe muovere a questo tipo di progetto è che questo sia un modello che non crea occupazione, ma la produce artificialmente; ma, a mio modesto avviso, per quello che ho potuto leggere in questi mesi ritengo che si tratti piuttosto di una felice modalità di intervento rapportata ad uno qualsiasi dei settori in crisi del nostro paese.
La classificazione degli obiettivi raggiunti nei report regionali serve a rendere meno astratto sia per i lavoratori sia per le aziende il percorso occupazionale. Sicuramente una migliore divulgazione dei progetti regionali porta a maggiore fiducia da parte dei soggetti privati che, inevitabilmente, finiranno per cooperare con gli enti alla buona riuscita del programma occupazionale delineato dal progetto regionale.
Altra possibile obiezione che si potrebbe fare a questo approccio è quella che talune volte le aziende private potrebbero aderire a questo tipo di progetto solo per farsi pubblicità, purtuttavia anche questo tipo di obiezione mi sembra da respingere al mittente soprattutto quando il progetto finisca effettivamente per realizzarsi creando, di conseguenza, nuova occupazione. A cancellare definitivamente le perplessità dovrebbe essere inoltre la considerazione che la presenza di un'imprenditoria etica, cioè di soggetti privati virtuosi, potrebbe essere vista con favore anche rispetto all’attuale momento storico.
3) La ricerca delle potenzialità.
La ricerca delle potenzialità del lavoratore/ professionista disabile non dovrebbe essere, ad avviso di chi scrive, un grosso problema. L'applicazione da parte dei privati di buone pratiche di reclutamento, anche con l'aiuto di progetti regionali mirati, non deve dunque essere vista con diffidenza, ma semmai inquadrata in un'ottica più lungimirante di reciproco vantaggio. Difficilmente un imprenditore potrà agire in un prossimo futuro senza tener conto di alcuni principi etici che devono e, a maggior ragione dovranno, essere presenti nel suo operato, perché la sua fortuna dipenderà sempre più spesso da un corretto approccio ad una pluralità di temi sensibili.
La ricerca sopra menzionata non dovrebbe essere per nulla difficile specialmente per i profili a più alta istruzione, infatti le nostre università, oltre ad essere molto competitive nel panorama europeo, sono state grado di rendere la loro offerta formativa sempre più completa e di abbattere anche quelle barriere architettoniche che, in alcuni casi, impedivano un'adeguata fruizione delle lezioni. Se il numero di laureati con disabilità è in netta crescita da vent'anni a questa parte lo si deve anche ad una serie di pratiche precise che hanno portato le Università ad essere attrici principali di una strategia di inclusione basata sulla conoscenza e sulla condivisione dei saperi che non trascurasse in alcun modo l’accessibilità ai luoghi di lezione. Se poi le conoscenze acquisite dagli studenti con o senza disabilità siano sfruttate adeguatamente dal mondo del lavoro, questo non è sempre chiaro. Lo spreco di risorse formative di cui soffre il sistema Italia dipende principalmente, dalla poca attitudine da parte di aziende ed enti, negli anni passati a fare scouting nelle università, accontentandosi così di personale spesso poco motivato se non poco aggiornato. Si potrebbe dire con un po' di cinismo che le acquisizioni commerciali avvenute negli ultimi dieci anni da parte di gruppi stranieri altro non siano che il risultato di un dissennato sperpero di risorse intellettuali regalate senza motivo ad altri competitori.
Le potenzialità si traggono dunque dalle scuole e dalle università e questo vale per qualsiasi professionista disabile o meno.
4. Possibili interventi a protezione del lavoro.
In questo momento storico, inoltre, come rammentato dalla Federazione per il Superamento dell’Handicap (F.I.S.H.), occorre ancora salvaguardare la salute e l'occupazione dei cosiddetti soggetti fragili o per meglio dire lavoratori fragili.
Questa preoccupazione, oltre a tener conto delle molte e necessarie proroghe dello Stato di emergenza, dovrebbe fare i conti anche con la realtà oggettiva e la paura prospettata da molte associazioni, che la fine dello Stato di emergenza coincida anche con la fine delle misure alternative al lavoro in presenza.
Nel prossimo futuro penso che sia fondamentale cercare di bilanciare le diverse esigenze, cioè cercare di mandare in presenza chi se la sente di andare in presenza senza che questo voglia dire obbligare al lavoro in presenza altri lavoratori disabili che giustamente cercano di proteggere la propria salute ed aumentare quanto più possibile la propria aspettativa di vita. Dunque questo periodo non deve portare ad acuire le già molteplici situazioni di esclusione dal lavoro, che già vivono le persone con disabilità, (sia quelle in cerca di occupazione, sia quelle discriminate nel momento della proposizione del loro curriculum, sia quelle che cercano disperatamente di mantenere la loro posizione), ma deve essere invece un periodo in cui le diverse modalità del lavorare si potenzino a vicenda. In questo senso una serie di misure di tutela per i lavoratori fragili sono state prorogate e, si spera, abbiano vita lunga.
Ma la paura che dopo la fase di pandemia si possa assistere ad un drastico ridimensionamento dei diritti acquisiti é presente purtroppo in quasi la totalità dei lavoratori con disabilità.
Servono, dunque, misure sistematiche che non vadano a indebolire, ma semmai a rilanciare quella legge 68 che, più di 20 anni fa, aveva segnato una svolta fondamentale.
Il fatto che questa legge non sembri aver dato i frutti sperati, non vuol dire che non vada rilanciata alla luce delle attuali stringenti necessità. Per questo si auspicano nuovi incentivi pubblici per migliorare la legge e renderla sempre più in grado di fronteggiare l’attuale emergenza nazionale.
L’aumento dei fondi regionali oltre a migliorare l’efficacia della legge sul collocamento obbligatorio dovrebbe conseguentemente portare a sbloccare i numerosi progetti regionali in tema di vita indipendente.
Lo spirito della legge, infine, potrebbe essere definitivamente rilanciato grazie ad una serie di interventi economici che possano sia incentivare le assunzioni e renderle automatiche, sia snellire alcune procedure del collocamento obbligatorio.
5. I casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e possibili rimedi.
La legge 68/99 all'articolo 10 pone un limite al potere di recesso datoriale. Questo limite riguarda più precisamente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La norma stabilisce infatti la nullità del licenziamento quando il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva. Questa ipotesi sancisce quindi il diritto del lavoratore di mantenere il posto anche in caso di procedure volte alla riduzione del personale. Nei casi descritti, infatti, il provvedimento espulsivo sarà annullato là dove il numero di lavoratori disabili impiegati finisca per non coprire l'intera quota di riserva.
La ratio normativa, ovviamente, è quella di evitare che un licenziamento per crisi aziendale nasconda, in realtà, un trattamento discriminatorio. Analogamente anche per il licenziamento individuale, se un posto in sovrappiù risulta occupato da un lavoratore disabile e la sua espulsione finisce per violare la quota di riserva, il datore di lavoro sarà tenuto ad assumere un altro lavoratore disabile o a tenere il licenziando in sovrannumero. Non manca chi naturalmente ha finito per trovare questa regola eccessiva. A questo proposito si può tranquillamente constatare come, alla fine, in sede giurisprudenziale, sia prevalsa la tesi secondo la quale è possibile avallare il licenziamento del lavoratore disabile, laddove la presenza del medesimo si riveli inutile per gli equilibri aziendali, in assenza di posti giudicati compatibili. In questo senso, dunque, si avrà una mitigazione degli obblighi del datore di lavoro, peraltro coerente con la facoltà di libera impresa costituzionalmente garantita. Ovviamente per mitigare gli effetti negativi del licenziamento per il lavoratore disabile, l'articolo 10 prevede che il datore di lavoro debba comunicare la risoluzione in oggetto entro 10 giorni agli uffici competenti, così da garantire la sostituzione con altro lavoratore avente diritto in graduatoria; solo dopo avere verificato la copertura della quota, il licenziamento sarà ammissibile.
Nel caso in cui invece il datore di lavoro sia già in regola con le quote, il medesimo dovrà comunque avvertire l'ufficio competente.
Una volta esaminati questi limiti, ci si chiede se esista un ristoro per il lavoratore disabile licenziato. Qui dovrebbe soccorrere il decreto legge 4 Marzo 2015 numero 23 e la tutela prevista per tutti i lavoratori dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. In tutti questi casi infatti dovrebbe prevalere la tutela reintegratoria attenuata che prevede appunto il pagamento di una reintegra compresa tra un minimo di quattro mesi ed un massimo di dodici mesi.
La legge prevede però dei rimedi. Infatti, la dove si scopra, in una fase successiva, che il licenziamento fosse in realtà collegabile alle condizioni psicofisiche del lavoratore licenziato, questo potrà senza dubbio attivare la tutela risarcitoria e contestare i motivi discriminatori del licenziamento. Questa contestazione darà accesso al lavoratore ad una tutela reintegratoria piena con condanna del datore di lavoro. L’evocata tutela partirà dal giorno del licenziamento fino ad arrivare a quello successivamente deciso dall’udienza di reintegro. Da un'attenta analisi della norma, oltretutto sembra chiaramente possibile che questo tipo di salvaguardia sia applicabile anche ai casi di disabilità molto lieve. Si chiarisce inoltre che, mentre la tutela forte si applica necessariamente a tutti i datori di lavoro previsti dallo statuto, quella attenuata si avrà solo per quei soggetti che abbiano un'organizzazione aziendale sotto il limite dei quindici dipendenti.
Necessariamente la scelta fatta dal legislatore nel 2015 innalzando le tutele in caso di licenziamento discriminatorio, non può che essere vista con favore dal nostro ordinamento. Questa scelta pare sicuramente coerente perché non si può negare che un licenziamento basato puramente sulla condizione fisica o psichica del lavoratore sia, a tutti gli effetti di legge, discriminatorio.
Oltretutto, secondo la giurisprudenza, anche un lavoratore disabile assunto da un datore non obbligato, può a buona ragione, reclamare le medesime tutele del caso sopra esaminato. In esito alla procedura di licenziamento, quindi. oltre alla già ricordata corresponsione delle mensilità da quattro a dodici mesi in favore del lavoratore, sarà sempre fatta salva l'ipotesi risarcitoria da domandarsi al giudice civile.
Ulteriormente, dall'impianto della legge 68 del 99 emerge ancora come una legge di maggiore tutela sia la miglior garanzia per i lavoratori in condizioni di svantaggio, ma, nello stesso tempo, occorre chiedersi come il lavoratore si debba comportare davanti ad altre situazioni discriminatorie che possano verificarsi nel corso della sua carriera.
Come più volte richiamato, la vita lavorativa di un singolo lavoratore disabile può sin dall'inizio incontrare ostacoli inizialmente nemmeno immaginati. Naturalmente queste situazioni di difficoltà richiederanno una più forte collaborazione tra datore di lavoro e dipendente. Sarà dunque il datore di lavoro, coerentemente con quanto dispone la normativa comunitaria, a doversi fare carico dei cosiddetti “ragionevoli accomodamenti”. Si tratta di misure in grado di agevolare il lavoro che il principale dovrà adottare quando riscontri delle giustificate esigenze da parte del dipendente. Queste misure, in realtà, proteggendo l'interesse reciproco alla prestazione e all'esatto adempimento sono d’interesse paritario e comune ad entrambe le parti. Ciò nonostante però l'applicazione nella pratica di ragionevoli accomodamenti appare tutt’altro che scontata. Questo è dovuto probabilmente al fatto che il principio in questione è stato recepito dal nostro ordinamento più tardi rispetto agli altri paesi d’Europa.
Si pensi in questo senso anche alla legge numero 67 del 2006 legge sulla discriminazione diretta ed indiretta ai danni delle persone con disabilità. Qui però intendiamo soffermarci solo sul concetto di accomodamento ragionevole e sulle conseguenze di un comportamento poco conciliante da parte del datore di lavoro. Sicuramente la mancanza di un accordo relativo ad un accomodamento ragionevole può comportare, ai sensi dell'art. 28 comma 5 DLgs n. 150 del 2011, per il datore di lavoro l'obbligo di risarcire il danno anche non patrimoniale derivante dal comportamento discriminatorio, nonché l'ulteriore obbligo di cessare il comportamento dannoso in atto. Un'eventuale condanna, dunque, costringerà il datore di lavoro a mettere in atto tutte quelle misure in grado di eliminare la discriminazione.
Com'è facile intuire, il giudice, per esempio, ben potrà intimare al datore di lavoro di abbattere una o più barriere architettoniche che impediscano al lavoratore la libera fruizione del luogo di lavoro.
6. Barriere architettoniche.
La progettazione senza barriere architettoniche viene ancora oggi considerata come un tipo di progettazione dedicata alle persone con disabilità. Questa concezione, fortunatamente, al giorno d'oggi sta passando a beneficio di un di un molto più rassicurante concetto di architettura universale o integrata. I concetti architettonici di cui si discute, infatti, non devono, già dall'origine, contenere barriere.
La scienza della progettazione si è evoluta e ha trovato un approccio inclusivo che ha finito per assorbire i principi della progettazione universale.
dall'inizio degli anni 90 il paradigma della progettazione senza barriere si è ampliato acquisendo quell'approccio inclusivo dovuto in gran parte all'approvazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità che ha portato a superare il concetto di luogo riservato o esclusivamente dedicato, a favore di ambienti e servizi idonei a favorire la socializzazione, il lavoro senza discriminare in relazione alla disabilità sia essa fisica sensoriale o cognitiva. A consolidare questa concezione soccorse la legge nazionale numero 13 del 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche che non prevede il concetto di spazio dedicato, ma piuttosto codifica il concetto di ostacolo fisico. Ostacolo fisico è ciò che crea disagio alla mobilità di chiunque (specialmente a chi ha capacità motorie ridotte). Ostacoli o barriere sono ulteriormente definiti dalla normativa come quegli ostacoli che limitano il comodo e sicuro utilizzo degli spazi da parte di chiunque (quindi non solo soggetti con disabilita).
A tutto questo si deve necessariamente aggiungere la presenza di percorsi che consentano, in sicurezza, la fruizione della struttura da parte dei non vedenti e non udenti. Il concetto di barriera architettonica, così come voluto dalla legge, non riguarda espressamente le persone disabili ma tutti i cittadini che possono trovare intralci nella fruizione degli edifici o delle strade pubbliche. Dunque la normativa, essendo molto egualitaria, riserva alle persone con disabilità solo maggior attenzione
Ovviamente la domanda perché progettare senza barriere trova la sua più facile risposta nell'esigenza di accessibilità domandata da tutte le persone di buon senso, ma questo, per quanto possa sembrare incredibile, non basta a migliorare la situazione dal momento che l'unica pratica adottabile per porre un freno al proliferare delle barriere architettoniche, sarebbe quella di introdurre sanzioni a carico di chi costruisce in un certo modo, relegando quel modo di costruire ad una piccola porzione di mercato ininfluente.
I criteri di agibilità di un edificio secondo la valutazione di accessibilità sono tre: 1)Piena 2) Limitata ad alcune parti (con edificio comunque agibile e visitabile), 3) Inagibile (riferito a quegli edifici in cui si debbano svolgere opere di ripristino tutt'altro che marginali e quindi inaccessibili ai soggetti con disabilità). Il concetto di Universal design coniato dall'architetto Ronald L. Mace dell'Università del Nord Carolina porta con sé sette cardini: 1) Equità nell’uso 2) Flessibilità nell’ utilizzo 3) Semplicità 4) Procettibilità, cioè deve essere in grado di trasmettere le opportune percezioni e sensazioni. 5) Tolleranza all’errore, 6) Contenimento dello sforzo fisico. 7) Misure e spazi sufficienti per l'idoneità all'accesso all'interno dell'edificio o della stanza.
Da questa emerge che il “Design for all” è un modo di pensare la progettazione di spazi ed oggetti che mette in grado tutti di accedere con pari opportunità alla partecipazione nella società. Questo approccio olistico ed innovativo costituisce una sfida creativa ed etica per ogni designer, progettista, imprenditore, amministratore pubblico e leader politico. Lo scopo del Design for All è facilitare per tutti le pari opportunità di partecipazione in ogni aspetto della società. Per realizzare lo scopo, l’ambiente costruito, gli oggetti quotidiani, i servizi, la cultura e le informazioni – in breve ogni cosa progettata e realizzata da persone perché altri la utilizzino – deve essere accessibile, comoda da usare per ognuno nella società e capace di rispondere all’evoluzione della diversità umana.”
In conclusione, al di là dei luoghi e dei tempi che vedono questa filosofia progettuale emergere nei due continenti, quello americano e quello europeo, ritengo utile ribadire che la progettazione universale vada considerata come una strategia volta a migliorare la qualità di vita per tutti, con una fascia di utenza più ampia possibile, con la realizzazione di ambienti costruiti, prodotti e sistemi di comunicazione accessibili, utilizzabili e comprensibili. Un obbiettivo da perseguire con soluzioni che risultino il più possibile naturali e garantiscano indipendenza, senza adattamenti o soluzioni di design specializzate.
Per dirla con un esempio pratico, un servizio igienico “dedicato” alle persone con disabilità non rientra in questa logica, mentre un bagno che può essere utilizzato da tutti e che risulti non solo accessibile, ma anche comodo e sicuro, in relazione alle esigenze di persone con disabilità di tipo diverso (fisico, sensoriale e cognitivo), rientra in questa filosofia.
Certamente non si può raggiungere lo stesso livello di prestazioni per ogni singola unità ambientale, e proprio per questo si parla di strategia, ossia di un metodo che va declinato con una visione olistica del progetto che, a sua volta, va centrato sulla persona.
Al concetto di Universal design si contrappone quello di free barrier concept, che sebbene per certi versi superato relativamente agli edifici di nuova costruzione, si rivela comunque utile nei casi di necessità. Luoghi successivamente rivelatisi inospitali o in tutti quei casi in cui sia sopravvenuta una momentanea inabilità. Certamente questa secondo modello di intervento architettonico risulta marginale e legato a tutte quelle situazioni di emergenza in cui non sarebbe possibile fruire di un edificio senza gli opportuni adeguamenti. In questa prospettiva sarà necessario, a posteriori capire cosa puo’ costituire una barriera, pensare alla singola menomazione della persona, rivedere tutto dalla struttura al più piccolo dettaglio (a seconda della situazione che si presenta) e, infine, imparare dall’esperienza.