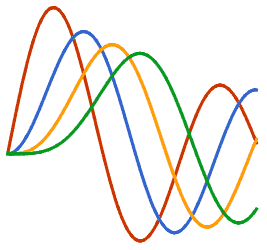Fragilita, storie, diritti - Michela del Vecchio - 09/03/2016
Una speciale normalità – Michela Del Vecchio
E' solito affermare che la realtà orienta il nostro agire omettendo però di considerare che la lettura della realtà è interpretazione e tale interpretazione, come tutti i processi di elaborazione mentale, coinvolge pregiudizi ed opinioni che ciascun essere umano ha acquisito in ragione di un vissuto personale. Tale riflessione manifesta la sua rilevanza ed attualità principal modo quando si affronta la tematica della disabilità. Quando ci si confronta con una persona portatrice di un handicap l'atteggiamento, ancora oggi adottato nella società, è duplice: compassione da un lato (un comportamento caritatevole anche, se vogliamo, fastidioso) e "catalogazione" dall'altro (identificazione della disabilità con la patologia).
Si affrontano allora aspetti come l'integrazione e l'inclusione sotto il profilo della medicalizzazione del percorso di crescita e deresponsabilizzazione delle persone disabili o che convivono con questi.
Atteggiamenti assolutamente privi di validità sostanziale ove si consideri che la soggettività dell'individuo è così complessa che non può ridursi ad unità ("immigrato", "disabile", "omossessuale" e simili).
La difficoltà di conoscenza compiuta dell'io e dell' altro si manifesta già nella scuola per quanto la normativa italiana ed europea è ripetutamente intervenuta assegnando proprio alla scuola il compito di socializzazione ed integrazione tra normodotati e disabili. In realtà, da un'esperienza compiuta in alcune scuole, è emerso che la risposta che la scuola può offrire è assolutamente inadeguata, generica ed alcune volte ossessiva (scolarizzazione a parità di condizioni con presenza di insegnanti di sostegno purchè si raggiungano gli obiettivi logico matematici o linguistici).
Ai lodevoli propositi legislativi non seguono nelle realtà scolastiche concreti apporti operativi affidandosi a forme di associazionismo, a progettualità e spirito di iniziativa dei docenti non di rado impreparati ad affrontare i temi della disabilità in quanto specializzati a considerare i soli deficit del soggetto leggendoli in tema di sofferenza (disturbi morfo – funzionali, ritardi di sviluppo, mancanza di interesse, mancanza di impegno e simili) e non di risorsa del ragazzo.
Si registra così una scarsa capacità di interazione e cooperazione fra scuola ed altri soggetti chiamati a partecipare ai processi di integrazione (famiglie, servizi sanitari e sociali, volontari) aggravata dalla fisiologica mobilità del personale docente; una organizzazione "piatta" dela scuola priva di figure specialistiche o specializzate che aiutano i docenti nell'analisi delle situazione e nella ricerca dei rimedi più efficaci; alla presenza di insegnanti di sostegno dal profilo professionale incerto e poco valorizzato o - sovente - scarsamente motivati; ad una carente collaborazione delle famiglie nell'opera di co-progettazione e partecipazione all'attività quotidiana del ragazzo disabile; ad un elevato rischio di segregazione di questi ragazzi in assenza anche di orientamento delle famiglie.
Si omette, in particolare, la considerazione che il disabile è una persona ignorando quindi la sfera soggettiva ed emozionale della stessa: da una lettura della disabilità in un contesto esterno, in altri termini, dovrebbe giungersi ad una conoscenza della persona disabile nella sfera interiore.
Spostare l'attenzione dal contesto in cui il disabile è chiamato ad agire (scuola, famiglia, ambiente) all'interiorità dello stesso consente di conoscere un universo ricco di emozioni e di capacità che attendono solo di essere colte e trasmesse.
Evidente che è di fondamentale importanza liberarsi da categoria "culturali" non intendendo più la disabilità come un problema della società ed offrendo un modello sociale di identità ben individuate tutte "normalizzate": si tratta di riconoscere la persona disabile come una persona concreta con una propria storia ed una propria personalità, con una sua organizzazione logica e con la sua comune diversità. Il deficit più o meno grave è un valore aggiuntivo che presenta potenzialità soggettive e relazionali e può, anzi, deve costituire il punto di partenza per stabilire nuove relazioni personali fortificanti.
E' un impegno che, parallelamente proiettato sul normo dotato, consente di cogliere tutti gli aspetti relazionali di questo, di elaborare pregiudizi apparentemente innati e di condurre anche il normo dotato ad un diverso concetto di sé acquisendo un senso di efficacia personale che gli permette di relazionarsi con il mondo in modo più certo accettandone le regole e le difficoltà ma anche proponendone i cambiamenti.
Gli "strumenti" per avvicinare e toccare questi "universi" possono essere diversi: dalla musica al teatro, dallo sport all'arte visiva. Trattasi di attività coinvolgenti tutte la soggettività della persona educandola al confronto con le proprie emozioni e portandola gradualmente a superare sensi di inadeguatezza con il mondo esterno e conflitti con la realtà acquisendo la coscienza di sé ed una sicurezza interiore.
Un tale percorso, forse, ove attuato, potrà consentire la conoscenza dei limiti ancora attuali a difficoltà relazionali delle persone esaltandone l'individualità e, contestualmente, favorendo l'aggregazione.