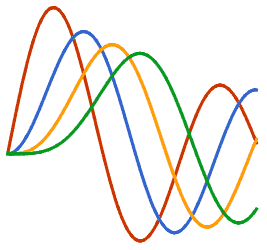- Mazzon Riccardo - 24/03/2016
TRASFORMAZIONI SOCIALI: DA CONSORZI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A SOCIETA' DI CAPITALI - Riccardo MAZZON
La trasformazione societaria può coinvolgere consorzi, società consortili, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni che vogliano trasformarsi in società di capitali: quali in questo caso i quorum da rispettare? Particolare attenzione meritano, in argomento, la trasformazione di associazioni e fondazioni in società di capitali nonché il principio generale dell'efficacia differita della trasformazione eterogenea.
Il codice civile prevede, tra le altre vicende sociali (cfr. amplius paragrafo 10., capitolo ventiduesimo del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), in società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata) possono trasformarsi i consorzi, le società consortili
"in caso di trasformazione eterogenea da società consortile in forma capitalistica in società di capitali lucrativa, non è necessario predisporre la relazione di stima del patrimonio sociale in quanto: a) la norma disciplinante la trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2500 octies c.c.) non prevede espressamente, per i consorzi e per le società consortili, la redazione di una relazione di stima, così come previsto dalla diversa disposizione (art. 2500 ter c.c.) regolante l'ipotesi di trasformazione di società di persone, b) il mutamento dello scopo - da consortile a lucrativo - non determina la necessità della predisposizione della perizia di stima, in quanto le due società, la consortile in forma capitalistica e la società di capitali derivante dalla trasformazione, appartengono allo stesso «genus» quanto alla esistenza del capitale sociale, alle norme in tema di bilancio ed alle assemblee" (Trib. Roma 21.9.2005, RN, 2006, 4, 1098);
- anche a responsabilità limitata:
"è applicabile alla trasformazione (che si ritiene eterogenea) di società consortile a r.l. in società per azioni la norma di cui all'art. 2500 novies c.c." (Trib. Vicenza 10.12.2009, RN, 2010, 2, 479); -
le comunioni d'azienda,
"quando dalla comunione d'azienda si passi alla società, di fatto e poi regolare, non vi è discontinuità nella vita dell'azienda, per cui dei debiti gravanti l'azienda stessa risponde la società conferitaria ex art. 2560 c.c." (Cass. civ., sez. trib., 18.12.2008, n. 29653, GCo, 2010, 4, 637);
le associazioni riconosciute,
"l'art. 2500 octies non è esattamente speculare al precedente art. 2500 septies: il primo prevede la trasformabilità in società di capitali delle sole associazioni riconosciute mentre il secondo contempla, fra l'altro, la trasformabilità delle società capitalistiche in associazioni non riconosciute. La scelta legislativa è stata probabilmente dettata dall'esigenza di evitare che la trasformazione diventi uno strumento attraverso cui le associazioni possano conseguire ipso iure e automaticamente la personalità giuridica. L'esclusione della trasformazione eterogenea per le associazioni non riconosciute, tuttavia, si comprende meno se si considera che lo stesso tipo di operazione è stata invece ammessa per altri enti privi di personalità giuridica come i consorzi (soggetti di diritto non personificati) o addirittura per le comunioni d'azienda (che, secondo la tradizionale ricostruzione, non sono neppure un soggetto di diritto distinto ed autonomo rispetto ai comunisti). Va sottolineato, in ogni caso, che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, alla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (art. 2500 octies, 3° co.). La ratio di quest'ultima previsione deve essere ricercata, con tutta evidenza, nell'esigenza di impedire la costituzione meramente "strumentale" di associazioni a solo fine di usufruire di contributi pubblici per poi trasformarsi in una società di capitali. Quanto alla trasformazione di una società di capitali in consorzio, società consortile o società cooperativa, essa accoglie l'orientamento di quella parte della dottrina che ne ha sottolineato la legittimità argomentando sul rilievo che consorzi, società consortili e società cooperative - oltre ad altri enti associativi, tra cui segnatamente le associazioni non riconosciute - sarebbero tutte strutture corporative a disposizione degli imprenditori per dare vita ad un organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese e, pertanto, presenterebbero una sostanziale identità della causa" (Ianniello, I nuovi confini della trasformazione eterogenea, in Soc, 2005, 576)
nonché le fondazioni:
"la trasformazione delle fondazioni può essere disposta solo dall'autorità governativa, che nell'assegnazione delle quote ed azioni dovrà osservare le norme contenute nell'art. 31, secondo le quali i beni della fondazione devono essere devoluti secondo quanto dispone l'atto costitutivo o in favore di altri enti, che hanno fini analoghi. La deliberazione, tranne che nelle fondazioni per le quali decide l'autorità governativa, deve essere assunta nei consorzi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati, nelle comunioni di azienda con il voto unanime di tutti i partecipanti, nelle società consortili e nelle associazioni riconosciute con le maggioranze stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato" (Salafia, La trasformazione delle società nella riforma, in Soc, 2004, 1064).
Quanto ai quorum richiesti dalla legge per la deliberazione di trasformazione, essa deve essere assunta:
- nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- nelle comunioni di aziende, all'unanimità;
"la trasformazione di società di capitali in comunione di azienda sia fattispecie disciplinata dagli artt. 2498, 2499, 2500 e 2500 bis) che, riguardando tutti i tipi di trasformazione, omogenea ed eterogenea e che, dunque, sono senz'altro valevoli anche per l'ipotesi in oggetto. La disciplina speciale inerente il procedimento è contenuta essenzialmente nell'art. 2500 septies. Dalla lettura di tale norma si evince che la trasformazione viene assunta con una delibera adottata nelle forme previste per le modifiche dello statuto, il che significa che sarà necessario che il verbale relativo a tale delibera sia redatto da un notaio e soggetto, secondo quanto prevede l'art. 2436, al controllo di legittimità da parte dello stesso pubblico ufficiale rogante. Quanto ai quorum necessari per l'approvazione della delibera occorre avere riguardo alla disciplina speciale, sempre contenuta all'art. 2500 septies, che richiede il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto (oltreché, ovviamente, al consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata). Prima ancora di cercare di chiarire quale sia il significato da attribuire alla poco chiara formulazione normativa relativa alla maggioranza richiesta per tale tipo di trasformazione, pare opportuno svolgere due considerazioni di carattere generale. In primo luogo si può evidenziare il fatto che anche per le fattispecie di trasformazione eterogenea il legislatore non ha ritenuto di dover derogare al principio maggioritario imponendo l'unanimità dei consensi e ciò nonostante le profonde alterazioni non solo del tipo, ma anche dello scopo perseguito cui tali vicende trasformative danno vita. In secondo luogo occorre rilevare come il quorum richiesto dalla norma in questione sia imposto in via imperativa e che quindi deroghi sia ai quorum previsti dalla legge per le modificazioni statutarie (artt. 2368, 2369 e 2479 bis), sia ad eventuali maggioranze, diverse da quelle previste dalla legge, imposte statutariamente per le stesse modifiche, a meno che, in quest'ultimo caso, non si tratti di quorum rafforzati rispetto a quello dei due terzi previsto per la fattispecie in oggetto. In definitiva il quorum previsto da tale norma è da intendersi quale limite minimo per l'adozione della delibera, non suscettibile di essere ridotto. L'ottica è, anche in questo caso, quella della conservazione dell'impresa, quindi di tutela di interessi superiori rispetto a quelli particolari di coloro che a tale impresa partecipano. In altre parole l'interesse alla conservazione del patrimonio prevale a tal punto che la maggioranza può imporne una destinazione differente rispetto a quella originariamente pattuita, evitando di dover passare attraverso una sua disgregazione, cioè attraverso le fasi di scioglimento e di liquidazione" (Maltoni, Traditi, La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione d'azienda e viceversa, in Not, 2004, 8),
- nelle società consortili e nelle associazioni, con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.
Quanto, in particolare, alla trasformazione di associazioni in società di capitali, essa può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; la trasformazione in società di capitali non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico;
"la condizione di beneficiaria di contributi pubblici impediscono, ai sensi dell'art. 2500-octies c.c. che un'associazione possa legittimamente trasformarsi in società di capitali. Allo stesso modo è di impedimento l'esistenza di una procedura fallimentare, in quanto la trasformazione in esame è possibile solo in pendenza di procedure concorsuali aventi una finalità di conservazione dell'impresa, quali sono l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e non quelle aventi una finalità solamente liquidatoria" (Trib. Verona, sez. IV, 29.11.2006, GM, 2007, 10, 2636);
qualora la trasformazione sia consentita ed avvenga, il capitale sociale - della società risultante dalla trasformazione - dev'essere diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
Quanto alla trasformazione di fondazioni in società di capitali, essa è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente; le azioni (o quote, in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata) sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31 del codice civile.
In deroga a quanto disposto, in via generale, dal terzo comma dell'articolo 2500 del codice civile (cfr. paragrafo 6., capitolo ventiduesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON), la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso:
"il diritto di opposizione dei creditori risponde alla logica di impedire che il debitore possa modificare unilateralmente il regime giuridico del suo patrimonio in presenza dei creditori stessi" (Cetra, Le trasformazioni omogenee ed eterogenee, in Abbadessa, Portale (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, Milano, 2007, 155, 157)
I creditori dell'ente trasformando possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione:
"per effetto delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario, l'eterogeneità della causa non costituisce più il principale ostacolo - generalmente addotto dalla dottrina per negare l'ammissibilità di varie ipotesi di trasformazione eterogenea - alla trasformazione da società di capitali in enti senza scopo lucrativo. La regola guida che si ritrova nel nuovo codice è quella di consentire la trasformazione fra pressoché tutte le forme associative indipendentemente dalle loro caratteristiche causali e organizzative». Peraltro, non sembrano porsi problemi sotto il profilo della tutela delle ragioni creditorie eventualmente pregiudicate dall'operazione tenuto conto della disciplina dell'art. 2500 novies, che regola gli effetti della trasformazione solo dopo il decorso di sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari. La norma può ritenersi quindi ampiamente suscettibile di applicazione analogica, anche alle ipotesi di trasformazione eterogenea non disciplinate dagli artt. 2500 septies ss., sull'ulteriore (e rilevante) presupposto della conoscibilità nei terzi dell'assetto organizzativo della società. In definitiva, «si può affermare che la disciplina della trasformazione dei tipi ordinari di società degli artt. 2498 ss. c.c. costituisce espressione di un principio generale: quello della conservazione dei patrimoni autonomi. Se è così, va respinta la tesi che tale disciplina abbia carattere eccezionale e può, al contrario, prospettarsene l'applicazione analogica - qualora ricorra la medesima ratio - a fattispecie non previste, in particolare a quelle in cui la struttura organizzativa abbandonata o acquisita sia propria di un contratto associativo (in quanto tale dotato di autonomia patrimoniale) diverso dai tipi di società del Titolo V»" (Ianniello, I nuovi confini della trasformazione eterogenea, in Soc, 2005, 573);
si applicherà, in tal caso, l'ultimo comma dell'articolo 2445 del codice civile, nel senso che il Trib., quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori - oppure l'ente trasformando abbia prestato idonea garanzia -, potrà disporre che l'operazione di trasformazione abbia luogo comunque, nonostante l'opposizione:
"in esito al giudizio, se l'opposizione sarà respinta, la garanzia eventualmente prestata rientra nella disponibilità della società nata dalla trasformazione. Se, invece, sarà accolta, i creditori avranno il diritto di soddisfare le proprie ragioni sulla garanzia predetta; in ogni caso, la trasformazione non è più reversibile, dato che l'art. 2500 bis impedisce addirittura l'accertamento della invalidità della trasformazione dopo l'esecuzione della pubblicità prescritta e, quindi, deve ritenersi implicitamente, e a maggior ragione, impedita la reversibilità del procedimento trasformativo, solo in presenza di un possibile pregiudizio per i creditori. A favore di questi si può solo configurare un diritto al risarcimento del danno nei confronti di coloro che hanno realizzato le suddette condizioni di irreversibilità" (Salafia, La trasformazione delle società nella riforma, in Soc, 2005, 1064).