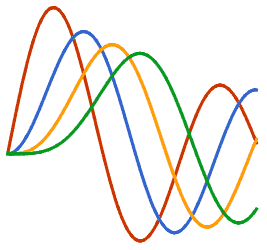Malpractice medica - Nicola Todeschini - 01/08/2017
Responsabilità medica: dalla sezioni unite un si ai danni punitivi?
Quando nelle more dell'approvazione della Legge Gelli Bianco, e non per celebrare il pesce d'aprile (il primo aprile è entrata in vigore la riforma) mi accingevo a perfezionare i primi commenti a caldo (N. Todeschini, Approvata la nuova legge sulla responsabilità medica: cosa cambia rispetto alla “Balduzzi, in QG, 2017), ho sostenuto che la regola contenuta nell'art. 7, ribadendo un concetto sconosciuto alla responsabilità civile ma caro alla Balduzzi, poteva dare accesso al danno punitivo in r.c. sanitaria. Alcuni commentatori (gli stessi per il vero che accolsero sorridendo le mie tesi sulla Balduzzi poi confermate dalla Cassazione), non hanno mancato di tacciare l'ipotesi argomentativa come fantasiosa, ma ora debbono fare i conti anche con l'arresto delle sezioni unite (Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 05/07/2017 n° 16601) che sono proprio intervenute sul tema con un'interessante e condivisibile apertura di credito a vantaggio dei punitive damages.
L'art. 7, invero, così recita discutendo della responsabilità dell'esercente:
“L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di un'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’articolo 5 della presente legge e del- l’articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall’articolo 6 della presente legge. “
Ebbene, già in passato, come premesso, la Balduzzi aveva introdotto, senza fortuna, nel nostro ordinamento giuridico una norma in parte qua analoga, sostanzialmente disapplicata perché considerata frutto d'invasione incontrollata, nel sistema civile, di una regola penale relativa invece all'influenza della condotta sulla modulazione della pena. Quando mai, fu detto, il risarcimento si calibra sulla gravità delle colpa? La funzione del risarcimento è compensativa, nulla più, mai sanzionatoria. Semmai, alcune voci isolate in dottrina hanno ipotizzato, questa volta sì con una certa fantasia, che sarebbe stata ammissibile una sola calibrazione in diminuzione, bontà loro, mai in aumento. L'ipotesi, peraltro, è stata riesumata pure a commento della regola così come riformata seppur sia mutato il contesto complessivo.
Del resto l'art. 7 immagina una regola, di per sé potenzialmente incostituzionale perché invoca -a modo suo- un trattamento diverso per alcuni professionisti (i c.d. esercenti, quindi i dipendenti di struttura), e discutendo della loro responsabilità vorrebbe che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tenesse conto della condotta.
Ancora una volta in tema di malpractice tocca agli interpreti misurarsi con l'analfabetismo -giuridico, ben inteso!- del legislatore ed immaginare significati che una calibrazione più accorta del testo avrebbe ben potuto indicare. Così facendo invece offre chance per ipotesi ermeneutiche assai più disinvolte.
Ebbene, come proposi allora, per la Balduzzi, così oggi cerco d'indagare il significato della regola immaginando come il legislatore avrebbe dovuto esprimersi se avesse inteso suggerire la lettura, maliziosa, alla quale alludono alcuni (la calibrazione ha senso solo in diminuzione, mai in aumento). Se il fine fosse stato inoltre quello di alleggerire, ancor di più, la sola posizione del medico dipendente, strappandolo alle odiose regole della responsabilità contrattuale e avvantaggiandolo pure della chance di sentirsi condannare al risarcimento mitigato del danno, magari in virtù dell'adesione alle linee guida, avrebbe potuto scrivere, per esempio:
“L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato solo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 e 6 della presente legge ha facoltà di diminuire l'entità del risarcimento.”
E invece il legislatore non abbatte per nulla la temuta ipotesi contrattuale, semmai onera il paziente di dimostrare di aver perfezionato un contratto (dimostrazione peraltro agevole), né indica una facoltà di modulazione del risarcimento solo in diminuzione. Si tratta di mera timidezza o vorrà dire qualche cosa secondo i canoni ermeneutici?
Alcuni commentatori attribuiscono al legislatore un'intenzione -si tratta di intenti che evidentemente manifesta all'orecchio di pochi eletti in consessi a loro dedicati- contraria al testo licenziato (non esclude la responsabilità contrattuale ma anzi la contempla espressamente, per un verso e, per l'altro, non prevede una facoltà in sola diminuzione); ma dimenticano che, semmai, il contesto delle regole che l'art 7 richiama (l'art. 5 e 6) sono tutt'altro che foriere di un nuovo clima rilassato per il sanitario. L'art. 5 articola, invero, un sistema di linee guida di Stato la cui valenza è tutta da apprezzare (solo indicativa, per la suprema corte) ma che vorrebbe vincolare la condotta del medico comprimendone, di fatto, la libertà salvo che non si voglia ipotizzare che la disegnata sua iper sensibilità alle regole, dalla quale sarebbe scaturita la -favola della- medicina difensiva, improvvisamente si sia trasformata in ardimento scientifico nonostante lo spauracchio delle odiate e non comprese regole.
L'art. 6, che introduce il novello art. 590 sexies c.p., aggrava infatti la posizione del sanitario dinanzi alla regola penale proprio come avevo sostenuto allora (così N. Todeschini, Non è punibile per imperizia chi rispetta le linee guida, in Responsabilità dei medici, Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2017), nonostante voci -le stesse di oggi- contrarie, ma soprattutto proprio come ha già sostenuto la Corte di Cassazione muovendo, all'incerta sintassi del legislatore, severe critiche (cfr. Cassazione Penale, Sez. IV, 7 giugno 2017 (ud. 20 aprile 2017), n. 28187 ).
Come è noto è stata abbandonata la distinzione tra colpa lieve e grave, ed adombrata una rilettura, in sede penale, della regola di cui all'art. 2236 c.c., così che ora sono inescusabili le condotte ispirate a negligenza ed imprudenza, e scusabili invece quelle connotate da imperizia...nonostante il rispetto delle -o purchè siano rispettate le- linee guida. Sull'incoerenza e contraddittorietà di tale ultima ipotesi non ricordo solo le mie critiche di allora ma quelle, se possibile ancor più aspre, del succitato arresto della suprema corte.
Il quadro, così come singolarmente ridisegnato, e richiamato dall'art. 7, è quindi quello di un legislatore che, in odio a negligenza ed imprudenza, violazioni della diligenza inescusabili, declina loro tutto il proprio biasimo, concedendo sollievo, seppur contraddittoriamente, all'imperizia ma non -si badi bene- a qualsiasi imperizia ma solo a quella che appaia parzialmente discriminata dall' -apparente?- adesione alle linee guida. Volendo trovarvi un senso, ma forzando il tessuto normativo, sembra andare nel senso semmai di rievocare l'obliterata distinzione tra colpa lieve e colpa grave per punire, appunto, l'imperizia grave e salvare semmai solo quella lieve.
Non può non essere significativo, invero, che per farci comprendere come può essere utilizzato lo strumento della modulazione del risarcimento alluda proprio alle regole che hanno mutato in modo così radicale l'orientamento. Sarebbe inconcepibile che a tale maggiore severità dovesse far eco, stante il medesimo biasimo per talune condotte, che ad esse fosse destinato in sede civile un trattamento invece più favorevole.
Ma vi è di più: la calibrazione del risarcimento del danno da condotta colposa, in presenza di tutte le condizioni della fattispecie, non ha mai conosciuto simili ipotesi di mitigazione in r.c., semmai, pur in altri sistemi, opzioni in aumento, appunto, punitive.
Ora che la funzione della responsabilità civile non è più escluso sia anche punitiva grazie anche all'arresto in commento, tanto più in un quadro che vede il sistema penale arretrare, grazie alla depenalizzazione selvaggia, lasciando al giudice civile di decidere non più solo per il risarcimento, ma pure per la punizione, come accade in ipotesi di ingiurie, non è necessaria troppa fantasia per credere nelle chance punitive, anzi solo punitive, della della regola in discussione.
Che sia legittima solo in aumento tale modulazione lo si trae anche dall'analisi serena dell'entità del pregiudizio: il danno patito, che si vuol compensare, non trova mai occasione d'essere sofferto in misura ridotta ove la condotta non sia gravemente colposa, poiché individuata una sua valenza medico legale e fissati gli indici di deficit della integrità psicofisica, non esiste, fenomenologicamente, una condizione che possa alleviarlo; accade, a ben vedere, il contrario allorché la condotta gravemente colposa racconti di un approccio scadente all'adempimento e comunque alla professione, offrendo al danneggiato la percezione, a dir poco sgradevole, dell'humus dal quale nasce l'errore.
Più è grave la distanza tra la condotta reale e quella pretesa, più la sofferenza non patrimoniale sub specie di danno morale -in particolare- ed esistenziale, denuncia indici in aumento perché si accompagna alla consapevolezza che sciatteria, noncuranza, imprudenza grave abbiano determinato l'errore; che una condotta non tanto più sapiente (perita), ma anche minimamente più attenta, avrebbe evitato.
Decisivo esempio, in tal senso, è offerto dal danno che amo definire “puro” (tipicamente morale ed esistenziale) da violazione del dovere alla completa informazione (cfr. N. Todeschini, La triplice chance di risarcimento del danno: il danno “funzionale” e quello “puro”, in La responsabilità medica, a cura di Nicola Todeschini, Utet, 2016), sin dall'arresto 2847/2010 riconosciuto addirittura in via presuntiva allorché sia violato il diritto del paziente all'autodeterminazione (diversa sorte, per i giudici, meriterebbe il danno c.d. funzionale, identificato con le complicanze taciute ma conseguenza di un trattamento perito).
Ne consegue che la violazione del dovere d'informare sia sempre sgradita all'ordinamento in quanto negligente, e mai possa essere considerata condotta che, a mente di quanto dispone l'art. 7, costituisca occasione per diminuire, ma semmai per aumentare, l'entità del danno.
Infine, seppur a corredo e non decisive, appaiono suggestive del senso qui perorato le altre regole che la Gelli Bianco prevede, nella procedura civile di contestazione del danno da malprassi, cercando di contenere i tempi della gestione del contenzioso e punire chi -il riferimento è chiaramente a medici, strutture, ma soprattutto compagnie di assicurazione- dimostri scarsa attitudine alla gestione oculata del caso non presenziando nelle occasioni atte alla conciliazione. Il giudice civile ha ora, grazie a tali nuove regole, la possibilità di “punire” una parte al di la dell'accertata entità del danno (in un caso addirittura in assenza di responsabilità) a significare che è interesse del legislatore che la sanzione civile prevenga condotte sciatte o improntate a malafede e, ove si verifichino, le sanzioni e che tale potere è attribuito, ancora una volta al giudice civile; dimostra inoltre che il legislatore crede che la punizione, tradotta nella condanna a corrispondere una somma di denaro, abbia valenza addirittura superiore al biasimo penale finendo per sostituire una delle sue funzioni precipue, quella preventiva.
Si può concludere quindi che l'inclinazione a riconoscere alla responsabilità civile una funzione punitiva appare sempre più attuale nel nostro sistema giuridico e che la regola di cui all'art. 7 e relativa alla possibilità di modulare il risarcimento in funzione della condotta sia da leggere nel senso del solo facoltizzato aumento.