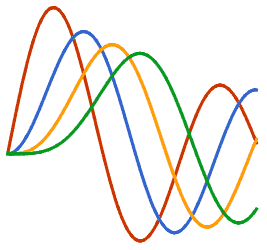- Redazione P&D - 08/03/2008
QUANDO IL DEMANSIONAMENTO PUÒ DIVENTARE OCCASIONE DI ARRICCHIMENTO DEL BAGAGLIO PROFESSIONALE – Alessia MURATORIO
(segue)
Si è ritenuto, da un lato, che l’affidamento ad una ditta esterna del servizio di vigilanza fosse stato determinato da uno stato di crisi, pacifico nei fatti, così da poter considerare il demansionamento come una soluzione alternativa ad altre di peggior impatto sulla situazione lavorativa dei dipendenti; dall’altro che le mansioni, sol perchè manuali, non avevano «depauperato il bagaglio professionale dei lavoratori». A detta dei giudici di legittimità, la motivazione della sentenza sarebbe viziata dal pregiudizio di ritenere la prevalente manualità del lavoro di per sé dequalificante rispetto al lavoro di sorveglianza, senza alcun raffronto fattuale. La Corte infatti si esprime in termini piuttosto decisi nel cassare la decisione impugnata, sottolineando come essa fosse «ispirata ad una aprioristica valutazione di superiorità del lavoro di guardiania rispetto al lavoro di produzione».
Lo stesso approccio, diciamo, imparziale vanta una lunga tradizione: la stessa Cassazione in passato aveva ritenuto pressoché irrilevante il carattere manuale delle mansioni affidate ai lavoratori, appartenenti vuoi alla categoria operaia vuoi a quella impiegatizia, in particolare per la distinzione tra le due categorie (tra tante Cass. 12 aprile 1990, n. 3106, in Mass. Giur. It., 1990).
In ordine a questa considerazione, si ha così modo di ritornare sul discrimine tra mutamenti legittimi di mansioni e dequalificazioni illegittime.
In proposito, riportandoci ai precedenti giurisprudenziali, l’aspetto determinante appare essere il necessario mantenimento del patrimonio professionale acquisito, che non deve andare disperso nell’adibizione ad altre mansioni (così Cass. 11 febbraio 2004 n. 2649, in Lav. Giur., 2004, 697). Da ciò discende che il trasferimento ad un diverso settore lavorativo non implicherebbe di per sé un illegittimo demansionamento, posto che le mansioni di destinazioni potrebbero comportare sia un aggiornamento professionale sia un eventuale ampliamento del proprio bagaglio professionale (Cass., Sez. Un., 24 novembre 2006 n. 25033, in Dir. Prat. Lav., 2007, 21, 884; Cass. 2 maggio 2006 n. 10091, in Mass. Giur. It., 2006).
Quando allora può dirsi pregiudizievole un demansionamento? Quando esso va ad intaccare il patrimonio professionale e di competenze del lavoratore attraverso l’adibizione a mansioni «decisamente dequalificanti» (così anche Cass. 23 marzo 2005 n. 6326, in Mass Giur. It., 2006). Di nessun rilievo sarebbe invece la diminuzione del trattamento economico complessivo: esso infatti, secondo la Cassazione, è strettamente collegato alla particolare modalità di prestazione od ai disagi ed alle difficoltà delle mansioni svolte, che mutando o venendo meno legittimamente sospendono i compensi prima dovuti (così anche Cass. 8 maggio 2006 n. 10449, in Mass. Giur. It., 2006).
Già in un recente caso di adibizione a mansioni inferiori, la Cassazione con la sentenza n. 3304 del 12 febbraio 2008 aveva precisato che il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti può essere ritenuto legittimo solo se proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede. La Cassazione ha ritenuto preferibile procedere alla valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti, dovendosi verificare sempre in primo luogo «la correttezza dell'operato del datore di lavoro in relazione all'eventuale illegittimità dell'esercizio dello ius variandi».
È ormai pacifico quindi che l'equivalenza delle mansioni, alla base della legittimità dello ius variandi, debba essere verificata sia sul piano oggettivo, ossia in merito all’inclusione delle nuove mansioni nella stessa area professionale di quelle iniziali, sia sul piano soggettivo, in ordine cioè alla loro affinità professionale. Con quest’ultima espressione la Cassazione intende riportarsi al «nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile l'armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo e consentirne ulteriori affinamenti e sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sé, i comuni caratteri di elementarità o semplicità delle precedenti e delle nuove mansioni» (così Cass. 11 dicembre 2003 n. 18984, in Mass. Giur. Lav., 2004, 253, con nota di Gramiccia. Si veda Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150, in Lav. Giur., 2003, 172; Cass. 1° settembre 2000, n. 11457, in Giust. Civ. Mass., 2000, 1904; Cass. 16 febbraio 1998, n. 1615 e 9 giugno 1997, n. 5162, entrambe in Giust. Civ. Mass., 1997, 950). Entrambi i profili di analisi debbono essere portati avanti parallelamente, non potendo affidarsi solo a quello oggettivo senza considerare la professionalità del lavoratore.
La Cassazione nella pronuncia in esame non fa che ribadire quanto già espresso in passato.
L’equivalenza tra le nuove mansioni e quelle precedenti, che legittima l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro, «deve essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come attitudine delle nuove mansioni a consentire la piena utilizzazione o, addirittura, l'arricchimento del patrimonio professionale dal lavoratore acquisito nella pregressa fase del rapporto» (così Cass. 26 luglio 2006, n. 17022, inedita
La verifica in ordine alle caratteristiche del legittimo ius variandi deve pertanto riguardare innanzitutto la qualifica e le mansioni del dipendente, con riferimento anche al testo del contratto collettivo (sull’equivalenza di mansioni determinata dallo stesso contratto collettivo si veda in particolare Cass., Sez. Unite, 24 novembre 2006, n. 25033, cit.; Cass. 2 ottobre 2002, n. 14150, cit.), ma soprattutto ruotare intorno al contenuto specifico delle mansioni in concreto esercitate ed alla loro potenzialità quale fonte di arricchimento della professionalità, riportandosi così al concetto dinamico di mansioni (Cass. 11 aprile 2005, n. 7351, in Mass. Giur. It., 2005; Cass. 9 marzo 2004, n. 4773, in Gius, 2004, 2838; Cass. 19 maggio 2001, n. 6856, in Mass. Giur. It., 2001).
Occorre quindi tener sempre presente che rilevante è solo il fatto che i nuovi compiti, benché estranei a quelli svolti in precedenza, «realizzino un arricchimento del bagaglio professionale del lavoratore e non comportino la dispersione professionale dell'esperienza acquisita» (Trib. Camerino 2 aprile 2007, in Lav. Giur., 2007, 1044; Cass. 15 febbraio 2003, n. 2328, in Mass. Giur. Lav. 2004, 25; Cass. 4 agosto 2000, n. 10284, in Notiz. Giur. Lav., 2001, 47; Trib. Milano 30 maggio 1997, in Riv. Critica Dir. Lav., 1997, 789).
Si può quindi rintracciare una linea di continuità nelle ultime decisioni giurisprudenziali che dilatano l'indagine circa il generale divieto di variazioni in peius ai contenuti concreti delle mansioni precedenti e di quelle nuove: l’affidamento di mansioni differenti al lavoratore non può considerarsi un demansionamento soltanto ove risulti tutelato il patrimonio di conoscenze e competenze del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione consenta al dipendente di utilizzare, ed anzi arricchire, il proprio patrimonio professionale acquisito con lo svolgimento della precedente attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio bagaglio professionale.