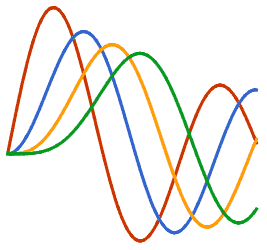Malpractice medica - Nicola Todeschini - 06/06/2019
Malasanità - quando il problema sono sempre gli altri
Quando si leggono certi commenti, anche di -apparente- qualità, o si ascoltano lamentazioni di taluni operatori del settore, in materia di consenso informato e dovere d'informare il paziente, ammetto che il desiderio di reagire è grande. Se è vero che ad alcune prese di posizione umorali, di pancia, non vale la pena offrire visibilità perché nella parallela vita vera, senza i social, mai sarebbero pronunciate, ignorarle del tutto non è poi così sensato, perché provengono dagli operatori. Ancor più gravi quelle redatte in punta, spuntata, di diritto in apparente formale ossequio alle regole (quali?).
Il contenzioso medico paziente viene da anni bui, di timor reverentialis, paternalismo, ossequio non sempre neppure formalmente corretto nei confronti dei professionisti, analogamente a quanto accade ad avvocati, notai, ingegneri. Normale che superate resistenze medievali, come quelle dell'epoca (vent'anni fa) si sia assistito ad inversione di tendenza, per alcuni overdose di malpractice.
Nel tempo (venticinque anni fa, quando cominciavo a scrivere la tesi, non era di moda) è diventata terreno anche di businnes, come tutto il mondo dei “sinistri”, ma a non voler regolamentare -la libertà, che diamine, prima di tutto!- il profilo degli operatori, delle competenze, si è assistito ad un progressivo interesse pseudo commerciale: siamo in un paese nel quale anche il macellaio può patrocinare, stragiudizialmente, un caso di supposta malasanità, ma un avvocato non può -per fortuna- macellare un vitello; un paese nel quale nessuno, nemmeno prima del ricovero, può far finta di saper fare il medico, ma chiunque può far finta di saper fare l'avvocato prima di varcare le aule di giustizia e, per farlo, non ha nemmeno subito la seduzione dalle regole che invece l'avvocato è tenuto a seguire.
E vi meravigliate che regni una certa confusione?
Ma è una confusione che anche il mondo forense contribuisce ad alimentare, basti pensare a come ha immaginato le specializzazioni, ad apparente tutela del cliente, ma in verità ben poco capaci di selezionare professionalità.
Se ci aggiungiamo approssimazione, in parte anche di categoria, spinte partigiane, lobby, politica da amatori in materia (Balduzzi, prima, e Gelli-Bianco, poi), abbiamo un quadro decisamente desolante del contesto nel quale il paziente chiede tutela e il medico non vorrebbe essere vessato.
E allora, discorrere delle reazioni che la legge consente di organizzare alla violazione del dovere d'informare il paziente può addirittura meritare il novero delle “vendette”, se non delle cattive abitudini che offendono la professionalità dei medici ed armano, improvvidamente, folte schiere di pazienti impazienti.
Pare quasi che ricordare che curare non significa, a tutti i costi, eliminare la patologia, proprio perché la salute, ce lo ricorda l'O.M.S., non è assenza di malattia, ma tendenziale benessere psicofisico e sociale, sia sinonimo di combattere la funzione nobile del medico, ma non è così. Anzi, significa suggerire l'amplificazione della sua funzione consulenziale, in linea con il diritto all'autodeterminazione del paziente (ma anche del medico quando veste i panni del paziente), e diminuire drasticamente il contenzioso (ma se lo dice un avvocato che fa le cause ai medici non vale, lo so), grazie alla sua capacità di rinsaldare l'alleanza terapeutica.
Ma se la resistenza è più pervicace, e riguarda la difficoltà di essere consulente, piuttosto che prescrittore di trattamenti che si debbono fare perché li suggerisce -astrattamente- la scienza, il tema da affrontare è più delicato e riguarda la revisione di una certa professionalità (vale anche per noi avvocati) calata dall'alto, imposta, paternalista e stizzosa, da colletto bianco che con arroganza ricorda quanto sa, quanto può, che si ammira allo specchio mentre pontifica.
Quanti ne conosciamo con la toga e con il camice? Tanti, se ce lo nascondiamo facciamo un'operazione ipocrita.
E allora il problema non può mai essere quello di tutelare il diritto del paziente all'autodeterminazione, e nemmeno quello di prevedere il diritto alla riparazione del relativo danno, accettiamo la sfida?