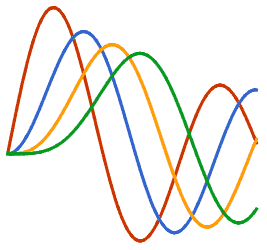Malpractice medica - Nicola Todeschini - 06/02/2018
Malasanità: il consenso, la prova
La pronuncia in commento 2369/2018 mi è stata segnalata con un certo allarme seguito alla lettura di un commento in particolare (non l'unico), poi rivelatosi fuorviante, in quanto avrebbe segnato un cambiamento di passo della giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento di consenso informato; mi sono quindi subito affrettato a reperire il contenuto integrale della pronuncia e già l'indicazione di Travaglino come Presidente mi ha tranquillizzato. Ancor più chiaro il testo, che rimane perfettamente nel solco della 2847/2010 e delle successive che ne hanno sviluppato gli argomenti.
Il commento che mi è stato segnalato, tuttavia, è talmente impreciso da meritare una revisione, se non altro perché inserito in un contesto di divulgazione orientata soprattutto ai medici che difficilmente dispongono delle nozioni di diritto utili a comprenderne l'incompletezza.
Ne traggo spunto perché rappresenta l'ennesima occasione mancata per offrire un angolo visuale coerente del percorso della giurisprudenza.
Secondo la criticata tesi la pronuncia si segnalerebbe per aver “negato il risarcimento del danno da assenza di consenso se il paziente avrebbe comunque acconsentito all'intervento. Secondo la Cassazione in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito dal quale siano derivate conseguenze dannose, l'assenza di consenso informato può comportare il risarcimento del danno solo se il paziente dimostra che, se avesse ricevuto un'adeguata informazione, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento. E’ il paziente che deve dimostrare l’assenza di consenso informato e il risarcimento del danno può essere previsto solo se questo può provare che se fosse stato adeguatamente informato avrebbe rifiutato un intervento o sarebbe stato più sereno nell’affrontare le conseguenze potenziali.”
La sentenza non ha per nulla posto in questi termini la questione.
L'errata ermeneusi si fonda verosimilmente nella mancata cognizione già del contenuto anzitutto della 2847/2010 che individua due essenziali danni risarcibili: il primo, consistente nel danno alla salute -rappresentato dalle complicanze, taciute al paziente, ma sorte in conseguenza di un trattamento perito- risarcibile solo se il paziente dimostri, anche a mezzo di presunzioni che, ove correttamente informato, avrebbe negato il consenso (e che appello, nei miei contributi, “danno funzionale”); il secondo, all'autodeterminazione, che prescinde dalla prova del rifiuto, e che piuttosto si presume si verifichi allorché sia tradita la fiducia del paziente (pregiudizio che appello, invece, “danno proprio”).
Non è quindi il riconoscimento del danno proprio ad essere condizionato dalla dimostrazione, gravante su paziente, ma solo il danno funzionale (quello alla salute, consistente nelle complicanze, taciute, sorte all'esito di un trattamento perito).
Che sia così, peraltro, e che i pregiudizi possano essere annoverati in due categorie, e che confonderli sia assai delicato, si deduce agevolmente dalla stessa pronunzia, ove si legge testualmente che “la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori quando siano configurabili conseguenze pregiudizievoli derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in sé considerato, a prescindere dalla lesione incolpevole della salute del paziente”.
Il primo, quindi, è il danno all'autodeterminazione (il danno proprio), il secondo alla salute (il danno funzionale), e di quest'ultimo discorre l'arresto allorquando afferma che “diversamente, il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non prevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito...ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione...deve necessariamente allegare...che avrebbe rifiutato quel determinato trattamento se fosse stato adeguatamente informato...”.
Lo scenario, quindi, è del tutto diverso da quello sintetizzato da alcuni commenti che risultano fuorvianti perché alludono ad un trattamento univoco del pregiudizio come se non esistessero due distinte categorie alle quali ascriverlo.
Nemmeno è vero, inoltre, che il paziente debba “dimostrare l'assenza di consenso informato” (come erroneamente sostenuto) poiché la pronuncia letteralmente ricorda invece che il paziente “deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (cass. n. 16503/2017)...che avrebbe rifiutato quel determinato trattamento se fosse stato adeguatamente informato”.
Ma osserva pure che “il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo aver ricevuto adeguata informazione, anch'essa esplicita; presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stata prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico (sez. III, sent. n. 20984 del 27.11.2012)”.
Non cambia l'orientamento, dunque, già in precedenza espresso e rimane ferma la chance di pretendere sia il risarcimento del danno patito per la violazione del diritto all'autodeterminazione, che si può presumere; che per la violazione del danno alla salute pur se, in tale secondo caso (e non nel primo!), il paziente debba, anche facendo uso dell'argomento presuntivo, dimostrare che se correttamente informato non avrebbe prestato il proprio assenso.