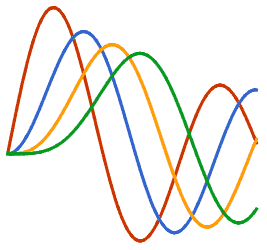Malpractice medica - Nicola Todeschini - 15/02/2018
La responsabilità contrattuale, anche del medico dipendente, confermata anche dalle D.A.T.
Di recente è entrata in vigore e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 la legge 22.12.17 n. 219 “norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.
Perlopiù commentata per le nuove regole in materia di trattamenti di fine vita e biotestamento non pare ancora indagato con sufficiente attenzione l'impatto che le regole in materia di consenso informato, non a caso stabilite all'art. 1 a dar credito alla loro fondamentale importanza nel tessuto normativo, hanno espresso sugli effetti della riforma Gelli-Bianco e, in particolare, sul c.d. doppio binario.
Come ho avuto modo di far notare nell'immediato post riforma, …, e i successivi lavori …., il nuovo –o presunto tale– regime è stato forse troppo frettolosamente qualificato come “doppio binario”.
Secondo tale tesi, che non convince del tutto, la riforma avrebbe creato un doppio binario (responsabilità contrattuale della struttura, extracontrattuale del medico dipendente); si tratta tuttavia, a mio modo di vedere, di una lettura discutibile della novella.
E' nota la critica da certa dottrina manifestata nei confronti della teoria del contatto sociale, secondo alcuni bersaglio primario del legislatore: si tatterebbe di una forzatura, per lo più figlia della necessità di avvantaggiare la posizione del paziente danneggiato, artificiosa e ormai superata. E' altresì noto l'interesse che in particolare la c.d. tesi milanese ha suscitato quando, all'indomani della riforma Balduzzi, ha fatto proprie le resistenze di parte, minoritaria, della dottrina, sostenendo che già la Balduzzi consentisse il superamento della responsabilità contrattuale del medico dipendente fondata sul contatto sociale.
E' evidente, e legittimo, che la tesi abbia fondate aspettative assai importanti nelle compagnie di assicurazione tuttavia rese vane dalla conferma, a cura del supremo collegio, della fondatezza del contatto sociale e dell'assenza di novità, sotto tale profilo, della legge Balduzzi.
L'avversione contro il contatto sociale riprende agio, come detto, all'esito della Gelli Bianco, seppur vada precisato che il legislatore commette un grave errore, tra gli altri, di tecnica legislativa nel proporre, in luogo di una vera e propria novella fattispecie, una discutibile censura ad un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Nè, criticando il contatto sociale, quale varco attraverso il quale passare per far riconoscere la responsabilità contrattuale anche al titolo di responsabilità del medico dipendente, il legislatori si è affaticato nello spiegare perchè la relazione di cura di rilievo internazionale, costituzionale, deontologico, possa mai essere mistificata nel quadro di una responsabilità extracontrattuale analoga a quella del “passante” tanto da tradire la propria insicurezza nella stessa formulazione della regola che, come premesso, da molti è stata letta come se fosse stata scritta senza la precisazione, inserita in extremis, che fa salva la responsabilità contrattuale del medico dipendente ove queste abbia assunto l'obbligazione.
Con tale ultima precisazione il legislatore ha dimostrato, a mio avviso inequivocabilmente, di non credere nella ricostruzione solo in termini extracontrattuali della responsabilità del medico dipendente affidando, forse, gli interessati a dimostrare in che termini il medico si sarebbe assunto l'obbligazione, e non si fosse invece comportato come il passante o se preferite come il magazziniere che consegna un frigorifero all'acquirente, che mai annovera, quale sua controparte, il magazziniere ma piuttosto il suo datore di lavoro, come ho sostenuto in questo lavoro … ma sta di fatto che di tale precisazione come di quella, già allora, dell'art. 3 della legge Balduzzi (che alcuni hanno voluto a tuti i costi interpretare come contenente la volontà, già allora, di sopprimere vent'anni di giurisprudenza sul punto peraltro senza riuscirvi).
Che la riduzione della responsabilità contrattuale del medico dipendente faccia comodo al sistema, alle compagnie di assicurazione in particolare, è un dato di fatto, che possa essere ricavata dal tessuto contrattuale tanto discusso e sigillato poi nel testo definitivo della legge Gelli è argomento completamente diverso, così come è ben più interessante comprendere quali possano essere gli effetti dell'individuazione, del titolo di responsabilità del medico dipendente, della mera responsabilità del passante, quali siano quindi i rischi che riguardano da vicino l'autonomia del medico dipendente e quale sia oggi, soprattutto, dopo l'entrata in vigore delle norme in materia di consenso informato, in apertura ricordate, la residua autonomia della tesi negazionista.
Alcuni autori hanno sottolineato la presunta irrilevanza dell'autonomia del medico dipendete in quanto inserito in una struttura complessa, che ne condizionerebbe le scelte, a tal punto di personalizzare il rapporto di fiducia con il paziente e renderlo una sorta di esecutore di direttive, condotte prefigurate, sfornito di autonomia decisionale e pertanto non vincolabile nello schema sinallagmatico del contratto.
A tali voci sono apparse solo emotive e non sufficientemente fondate gli opposti argomenti secondo i quali invece l'autonomia del medico sia non solo affermata nel sistema delle attuali regole ma anche fondamentale per garantirne l'alta dignità e non trasformare il medico dipendente, appunto, in un mero esecutore delle direttive altrui.
Sono proprio i medici, in altri termini, a dover temere questa virata negazionista piuttosto che sorridere compiaciuti dinnanzi alla sua ripetizione a volte pedissequa e nemmeno sin troppo compresa.
Proprio durante l'invasione di commenti contrari al contatto sociale (ricordiamo che la Cassazione, d'innanzi alla prima ondata di contrarietà alla tesi del contatto sociale ha insistito nel ricordare la sua fondatezza, utilizzandolo anche nei confronti del medico di famiglia) che racconta di un medico sfornito di autonomia che non ci spiegano però perchè, invece, facendo uso dell'autonomia che le regole gli consentono invece di vantare, potrebbe informare il paziente non certo leggendo un estratto delle informazioni che la struttura gli impone di dare al paziente, esprimere il proprio personale dissenso addirittura rifiutando la prestazione come nel caso dell'obiezione di coscienza.
Dopo l'entrata in vigore della 209 del 2017, in particolare dopo la lettura dell'art.1, lo sforzo della tesi contraria a quella da me perorata dovrà essere veramente importante poiché la figura del medico, seppur dipendente della struttura, disegnata dallo stesso legislatore che ha ipotizzato la Gelli-Bianco, e che ci ha regalato il 1 aprile la Gelli-Bianco, offre un quadro completamente diverso da quello al quale le tesi contrarie fanno riferimento ed anzi ridisegna (ma sarebbe meglio dire disegna poiché le regole non sono in verità cambiate) la relazione di cura e il rapporto di fiducia tra il paziente e il medico, fondato sul consenso informato, discutendo scientemente di “autonomia professionale” e di responsabilità del medico nella gestione della relazione di cura e della fase informativa che deve rispettare l'autonomia decisionale del paziente.
Nel ricordare i principi di tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, ricordando che nessun trattamento sanitario possa essere conseguito in assenza del consenso libero e informato della persona interessata (tranne i casi espressamente previsti dalla legge che qui non interessano) e ricordando soprattutto che il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura, intendo ogni, ormai peraltro superata, tesi secondo la quale il dovere di informare non sarebbe dovere contrattuale ma sarebbe da collocare alla periferia dell'obbligazione, assegna al momento dell'informazione e della prestazione del consenso il ruolo chiave che già la Corte di Cassazione aveva nel tempo disegnato.
Se finalmente, anche secondo il legislatore e non più solo secondo la giurisprudenza, il dovere d'informare è essenziale per consentire al paziente una decisione consapevole, nella riconosciuta, espressamente, autonomia professionale e responsabilità del medico, è chiaro che continuare a sostenere che durante tale fase il medico non assuma alcuna obbligazione nei confronti del paziente è tesi fantasiosa (per usare un termine caro a chi ha cortesemente bollato lo stesso argomento da me avanzato nel lavoro commissionatomi da UTET a primo commento della riforma Gelli-Bianco).
Per quanto a mio modo di vedere non fosse necessaria certo la 219 del 2017 per avvalorare la complessità, la speciale autonomia e condivisione che lega paziente e medico nella relazione di cura, non potendo mai screditarla al punto da considerarla veramente occasionale, con ciò individuandosi inevitabilmente lo stigma dell'obbligazione contrattuale, la visione del medico dipendente automa si scioglie come neve al sole innanzi al doveroso contenuto dell'art. 1 della legge in materia di consensi informati e disposizioni anticipate di trattamento.
V'è da chiedersi se non sia quindi il caso di raccontare con maggior prudenza il significato della riforma Gelli-Bianco offrendo agli interpreti una chiave di lettura che mi pare più congrua e coerente che al più indica una preferenza del legislatore per la responsabilità extracontrattuale del medico dipendente che appare però contraddetta dall'impostazione che lo stesso legislatore da nella succitata normativa della relazione di cura, e che non sia piuttosto il caso di immaginare che il dubbio su riconoscimento della responsabilità contrattuale del medico dipendente possa, al più, e in via veramente residuale, riguardare quelle ipotesi nelle quali il medico dipendente non agisca esprimendo la sua autonomia professionale ma svolga, quale sorta di delegato, singole minime e, sotto il profilo della responsabilità normalmente indifferenti, mansioni delegate dalla struttura sulle quali non abbia obiettivamente chance di esprimere la propria autonomia professionale come quando si limita a offrire indicazioni relative all'organizzazione della struttura quali la individuazione di un appuntamento, di una modalità di esecuzione di un esame, soprattutto quando non si proponga di “curare” in alcun modo il paziente, non intrattenga con lui alcuna vera relazione di cura nemmeno, ormai è chiaro a tutti, sotto il profilo dell'informazione utile all'espressione del consenso, ma per così dire intercetti il paziente in misura estemporanea nell'ambito di un rapporto invece con altro o altri colleghi già in esecuzione senza apportarvi alcunché.
E' chiaro che si tratta di un'ipotesi che va investigata per scrupolo, e non perchè abbia un significato, sotto il profilo pratico, di rilievo ma che evidentemente non può essere giocata nemmeno nell'ambito della responsabilità della equipe, tenuto conto del condivisibile (ed anche di recente confermato...) indirizzo della Corte di Cassazione in argomento fondato come noto sul principio parziale di affidamento, e tenuto conto che nel momento in cui il medico ha la chance di intervenire anche a correzione della condotta di un collega erronea deve provvedervi non potendo giocare allo scarica barile solo perchè l'indicazione, scorretta, provenga da un collega ma sia pur riconoscibile e quindi la relativa conseguenza evitabile.