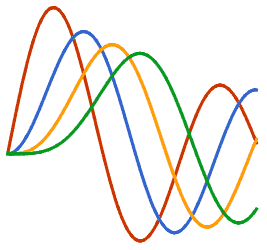Malpractice medica - Nicola Todeschini - 08/02/2018
Il dovere di informare, questo sconosciuto - Cassazione civile sez. III, sen. num. 1251 del 19.01.2018
Ha dovuto pronunciarsi la Corte di Cassazione, con la solita esemplare ed illuminata pronunzia che reca la firma del consigliere Dott. Giacomo Travaglino, per vincere l’ennesima battaglia in tema di dovere d’informare e soprattutto di rimedi alla sia violazione.
I famigliari del paziente contestano il difetto d'informazione ai sanitari che nonostante dispongano degli esiti di esami clinici dai quali emerga il pericolo di vita del paziente medesimo omettono di dargliene tempestiva informazione tanto che il paziente poi decede.
Secondo il Tribunale di primo grado e pure secondo la Corte d’Appello di Venezia (che deposita la sentenza il 18.09.2014 num. 2124/2014) non esisterebbe una norma che imponga al medico di comunicare urgentemente gli esiti dell’accertamento clinico eseguito, come se l’art. 1176, II comma cod. civ., che impone il dovere di diligenza speciale in capo ai sanitari, non avesse sufficientemente delimitato l’ambito dei doveri pure di informazione, da tempo ormai acquisiti nell’alveo dei doveri contrattuali.
E così tocca alla Corte di Cassazione far giustizia affermando un principio già ben presente alla giurisprudenza e agevolmente ricavabile dalla corretta individuazione della diligenza quale criterio di responsabilità, invitando la Corte d’Appello di Venezia ad uniformarsi al principio secondo il quale il sanitario è gravato dal dovere di segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso dell’esito di esami clinici che rivelino una condizione che, se non tempestivamente affrontata, può mettere in pericolo la vita stessa del paziente e che tale ritardo di comunicazione, ove consumato, “si risolve nella violazione del precetto di cui l’art. 1176, II comma cod. civ.” .
Che il medico possa insistere per sgravarsi dal dovere, che gli impone l’etica, la deontologia, di proteggere la salute del paziente informandolo del contenuto di un esame clinico dagli esiti allarmanti; che una struttura ospedaliera ottenga purtroppo successo in questa incomprensibile resistenza d’innanzi al Tribunale di primo grado e addirittura alla Corte d’Appello ha destato scalpore e dimostra che il tema del dovere d'informare e del consenso informato o meglio ancora del diritto del paziente all’autodeterminazione sono molto lontani dall’essere percepiti nel ruolo di centralità assoluta all’interno della relazione tra medico e paziente.
L’impressione che gravi sul corretto inquadramento di tali principi anche il retaggio di un’impostazione paternalistica della professione medica, che facciano effetto le sirene, maliziose, delle compagnie di assicurazione troppo spesso unite ai cori, partigiani, che si levano dalle organizzazioni che rappresentano gli interessi (è tutto da vedere come!) dei sanitari e che soprattutto le vittime di un errore così marchiato che in un commento recente ho addirittura visto qualificare come "non errore”, contribuiscono ad offrire della maturità raggiunta anche da certa giurisprudenza in argomento un orizzonte assai preoccupante.
Nel commento da ultimo citato addirittura si invitano i medici a prendere atto delle occasioni nelle quali dovrebbero “pagare” anche ove non commettano un errore (soddisfacendo quel filone assai di moda secondo il quale sarebbero vittime di pronunce spietate), come se, appunto, violare il dovere contrattuale di informare non fosse un “errore” ascrivibile appunto alla violazione dei precetti ricavabili dall’art. 1176, II comma.
Si tratta, a ben guardare, dello stesso terreno di scontro tra chi invoca la trasformazione della responsabilità contrattuale medica in responsabilità ex delicto, e quindi in quella del passante, e chi invece insiste per il riconoscimento del cumulo così di responsabilità contrattuale -anche del medico dipendente- e di responsabilità extracontrattuale.
Nemmeno la riforma Gelli Bianco, che maliziosamente ha indicato un percorso, interpretativo, lasciandone aperto pure un altro (alludo all’apparente ricostruzione in termini extracontrattuali della responsabilità del medico dipendente, che risponde però contrattualmente quando assuma l'obbligazione -come se si trattasse di un bevanda disgustosa-) viene da alcuni commentatori letta drasticamente come ritorno al passato; anche a costo di dimenticare non solo un ventennio di giurisprudenza costante in argomento ma pure la lettera della novella che, invece, fa esplicito riferimento all’obbligazione che può ben sorgere tra il paziente e il medico dipendete della struttura dalla quale non possono che derivare riflessi di natura contrattuale.
E’ infatti pacifico, per chi scrive, che proprio il terreno della relazione che si crea tra chi informa, il sanitario, e chi presta il consenso al trattamento, il paziente, è tipica del perfezionamento di un’obbligazione e pertanto ritengo che l’unica ipotesi ermeneutica compatibile con il tessuto normativo, con gli argomenti della giurisprudenza, con un attento sguardo alla pratica della relazione di cura, portino ad attrarre nell’alveo del rapporto contrattuale anzitutto ogni relazione, medico -dipendente di struttura- e paziente, nel corso della quale il primo adempia al proprio dovere d'informare e riceva il consenso del paziente. Solo grazie alla relazione di cura che si stringe tra quel medico e quel paziente, caratterizzata esattamente dalle informazioni che quel medico è stato in grado di fornire a quel paziente, e non ad un astratto malato, si individuano i contenuti dell’obbligazione, la qualità dell’informazione medesima e si possano quindi trarre gli elementi per considerare validamente prestato il consenso e, in alcuni casi, addirittura dedotto nel contratto un risultato, inequivocabile, allorché il sanitario, come purtroppo frequentemente accade, garantisca il risultato atteso dal paziente minimizzando i rischi, presenti invece in qualsiasi trattamento, e impedendo di fatto il paziente di operare una valutazione costi-benefici veramente consapevole ed informata.