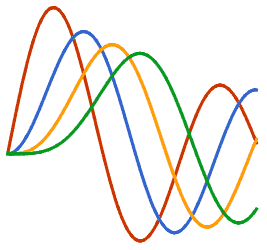Amministrazione di sostegno - Redazione P&D - 27/10/2023
Il danno per la violazione del dissenso espresso alle emotrasfusioni - Marta Paradisi con nota di Paolo Cendon
Premessa
La decisione in esame ripropone il discusso tema della autodeterminazione del paziente in ambito sanitario e del delicato rapporto tra quest’ultimo e l’intervento del medico, con particolare riferimento alle cure c.d. salvavita.
Tale rapporto è stato affrontato e trova oggi compiuta disciplina nella legge n. 219/2017 che non solo ha codificato il consenso informato [con sentenza n. 242/2019 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la legge n. 219/2017 ha cristallizzato i princìpi che erano stati già individuati dalla giurisprudenza: “Ciò, in forza della L. 22 dicembre 2017, n. 219 ... la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a seguito delle sentenze sui casi W. (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed E. (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207 del 2018): principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008”], ma ha anche regolamentato i rapporti tra medico e paziente, improntati a quella che viene definita “relazione di cura”, oltre che introdotto nell’ordinamento le “Disposizioni anticipate di trattamento” (c.d. DAT) quale modalità di espressione del diritto di autodeterminazione dell’individuo in vista di futuri momenti di incapacità ad esprimere la propria volontà.
Rimane ancora aperta la regolazione di tutti quei casi sorti antecedentemente l’entrata in vigore della predetta legge.
Come devono essere risolti i casi in cui, precedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, vi sia un contrasto fra medici e paziente circa la necessità di un trattamento sanitario considerato salvavita? Quale valore attribuire al dissenso espresso da un paziente divenuto, nel frattempo, incapace di esprimere direttamente le proprie volontà? Quel dissenso può essere validamente espresso da un amministratore di sostegno nominato ad acta?
La decisione in commento risponde a questi interrogativi attingendo sia dai princìpi costituzionali, che agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità più pertinenti in materia. Oltre a questo, la sentenza si fa apprezzare per il tentativo di individuare dei criteri di quantificazione del danno da riconoscere al paziente qualora il suo rifiuto non sia rispettato.
La vicenda
Il Tribunale modenese è stato chiamato a pronunciarsi nel caso di una signora affetta da sclerosi multipla in fase avanzata il cui marito era stato nominato amministratore di sostegno con il compito, tra l’altro, di prestare consenso informato per cure e trattamenti sanitari necessari per la salute della beneficiaria, qualora quest’ultima non fosse stata in grado di esprimerlo.
La donna veniva ricoverata d’urgenza presso il nosocomio per grave stato di shock emorragico/settico ma rifiutava per motivi religiosi, in quanto Testimone di Geova, sia direttamente sia tramite l’amministratore di sostegno nominato, il trattamento emotrasfusionale propostole, ancorché lo stesso fosse ritenuto dai sanitari indispensabile per la sua sopravvivenza.
Nonostante le forti pressioni dei medici, sia la paziente che il suo rappresentante legale rimanevano fermi e coerenti nel rifiuto viste le loro comuni e radicate convinzioni religiose, anche di fronte al progressivo peggioramento delle condizioni cliniche.
Stante il reiterato diniego, i sanitari si rivolgevano al Giudice Tutelare per ottenere indicazioni su come fosse opportuno procedere. Il Giudice Tutelare informava i sanitari che il rifiuto opposto da parte del marito amministratore di sostegno, in nome e per conto della signora, era da ritenersi “vincolante per i sanitari” in virtù dei poteri che gli erano stati attribuiti.
Pur in presenza di tale chiara indicazione, in totale spregio della volontà validamente espressa dalla paziente, i medici dell’ospedale sottoponevano la donna a ben quattro trattamenti trasfusionali che comunque non ne impedivano il decesso, avvenuto appena un mese dopo, visto il suo stato terminale.
Il marito, erede della donna, conveniva in giudizio l’ospedale ed i curanti responsabili dell’esecuzione del trattamento rifiutato per far accertare la loro responsabilità ed ottenere il ristoro dei danni sofferti (morali e biologici), sia in proprio sia dalla vittima iure hereditatis.
La struttura sanitaria ed i medici opponevano lo stato di necessità rilevando come l’esercizio della libertà di religione non potesse, in ogni caso, travalicare i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico ed imporre ai sanitari di violare gli obblighi, posti a loro carico, di protezione e salvaguardia della salute.
Il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, ha accolto le domande dell’attore partendo dai fondamenti costituzionali della validità del dissenso di un trattamento terapeutico, ante legge n.219/2017, per arrivare a fare il punto sul delicato bilanciamento tra i diritti costituzionali alla salute e di libertà di religione-coscienza in linea con l’attuale assetto giurisprudenziale di legittimità.
Fondamento giuridico del trattamento sanitario e limite dell’attività medica nel bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla libertà di autodeterminazione
Punto di partenza della sentenza in esame è il fondamento normativo del trattamento sanitario identificato, oltre che nell’art.32, comma 2 Cost., nell’art.33 della legge n.833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto dell’inapplicabilità della legge n.219/2017 non ancora vigente all’epoca dei fatti.
Elemento imprescindibile per l’esame della fattispecie è quindi la volontarietà del trattamento sanitario, volontarietà chiaramente sancita dalle norme richiamate ed estesa anche alle cure c.d. salvavita, quali la trasfusione ematica, che, come rilevato correttamente dal Tribunale modenese, non è annoverata tra i trattamenti sanitari obbligatori [Il DM Salute 3/3/2005 (Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti) all’art.11 (Consenso informato del ricevente) stabilisce “Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali procedure possono non essere comunque esenti da rischio, è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso”. Il testo è ripetuto anche nel successivo DM 2/11/2015 all’art.24].
È così che il problema sorge quando il paziente oppone il proprio rifiuto al trattamento sanitario ritenuto necessario, come nel caso del dissenso dei Testimoni di Geova alle emotrasfusioni.
Su tale tema - in base al consolidato quadro giurisprudenziale secondo cui i trattamenti medici, anche di sostegno vitale, non possono essere imposti contro la volontà del paziente - la sentenza in commento argomenta ampiamente sul difficile rapporto medico-paziente, ovvero tra il diritto alla salute, che la professione sanitaria è preposto a tutelare, e quello all’autodeterminazione a garanzia delle libertà individuali del singolo.
La decisione si sofferma anzitutto sul ruolo attribuito dalla legge agli esercenti le professioni sanitarie a garanzia della salute degli individui, anche in base a quanto previsto dall’art. 40 c.p. e dal codice deontologico. Ciò impone al medico di attivarsi a tutela della salute, quale fondamentale diritto dell’individuo.
Poste tali premesse, la sentenza ha il pregio di richiamare ed applicare al caso concreto i princìpi ispiratori dell’attività medica, individuati nell’art.1 della legge n.833/1978, nell’art.1 della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e medicina firmata a Oviedo il 4/4/1997 (ratificata con legge n.145/2001) che espressamente sancisce “Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”, nell’art.3 comma 1 della Carta dei diritti fondamentali UE (“Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica”) ed, infine nel Codice di deontologia medica che elenca fra i doveri del medico la tutela della vita, della salute psico-fisica del paziente “nel rispetto della libertà e della dignità della persona”.
Dette norme, infatti, sanciscono i limiti dell’attività medica, sottolineando l’imprescindibile rispetto della volontà, libertà e dignità della persona che accede alle cure.
Secondo il Giudice modenese, il rispetto della libertà e dignità umana impone al medico non solo di prospettare al paziente terapie efficaci, ma anche di attuarle con modalità il più possibile rispettose della dignità e della libertà di quest’ultimo.
Sulle base di tali considerazioni, il Tribunale di Modena ha ritenuto che nel caso della signora, di fronte al volere attuale di non essere sottoposta a emotrasfusioni, i medici, dando ugualmente corso alla terapia rifiutata, hanno posto in esse “un comportamento palesemente inadeguato e brutale”.
In tal modo hanno negato alla paziente, poi comunque deceduta, “una dignità nel processo del morire, imponendole decisioni terapeutiche contrarie alle sue convinzioni religiose, così annientando la sua identità”.
Di qui il richiamo ai diritti inviolabili di ogni essere umano di cui agli artt.2, 13 e 32 Cost. quali la libertà personale, la dignità, la solidarietà che impongono una soglia di rispetto invalicabile da parte di chiunque e di fronte ai quali la funzione di garanzia e l’obbligo contrattuale di adempimento della prestazione da parte dei sanitari devono arrestarsi, “non potendo fondare la propria legittimazione (o esigibilità) su metodi caratterizzati da violenza fisica o morale che l’ordinamento giuridico e la società civile non ammettono”.
Il bilanciamento, quindi, fra ruolo dei medici e diritto di autodeterminazione dei pazienti viene così risolto: “Da una parte, dunque, la tutela della vita che implica la competenza tecnica del medico, dall’altra il richiamo forte, reiterato, al rispetto della volontà, libertà e dignità che garantisce la collettività dal rischio che nell’intervento terapeutico l’attenzione si sposti dalla cura della persona alla cura in quanto tale e che la vulnerabilità dell’individuo malato venga utilizzata nella relazione come occasione di possibile prevaricazione piuttosto che condizione ispiratrice di un’azione – anche – etica, personalistica del medico”.
Come statuito dal Tribunale, nel caso esaminato “si è verificato un superamento della posizione di garanzia giacché l’eccesso di intervento ha fatto sì che l’azione dei sanitari non risultasse più concretamente adeguata al perseguimento della tutela della salute”.
Pertanto, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, la posizione di garanzia attribuita ai medici (ex art. 40 c.p.) si arresta di fronte al dissenso espresso del paziente, nel rispetto del diritto di autodeterminazione e di rispetto della “persona umana” [come indicato da F. MANTOVANI, Diritto Penale, Parte Generale, XI ed., pp. 286, 287, 297, il sanitario che si trovi innanzi a un esplicito e libero (dunque valido) dissenso, non solo non “deve” procedere con i trattamenti e le cure rifiutate (essendo con tale rifiuto venuto meno l’obbligo impostogli dalla legge), ma neanche “può” farlo invocando il fatto che la “facoltà” che si assume possa essergli concessa da uno “stato di necessità” ex art. 54 c.p. Se ciò fosse vero, si farebbe prevalere al dettato costituzionale in specie l’art. 32, comma 2, Cost., quale fonte sovraordinata, una norma ordinaria, quale quella in esame].
La pronuncia ha l’indubbio pregio di dare rilievo e centralità ai diritti dell’individuo, anche quale espressione di libertà religiosa, in linea con i princìpi che da tempo sono entrati a far parte del nostro patrimonio giuridico, sin dalla storica sentenza Cassazione n.21748/2007 (caso Englaro) da cui anche il Tribunale modenese trae spunto.
Da allora la giurisprudenza ha fatto proprio il concetto, espresso nelle parole della citata sentenza Englaro, secondo cui “Il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del «rispetto della persona umana» in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive. Ed è altresì coerente con la nuova dimensione che ha assunto la salute, non più intesa come semplice assenza di malattia, ma come stato di completo benessere fisico e psichico, e quindi coinvolgente, in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé, anche gli aspetti interiori della vita come avvertiti e vissuti dal soggetto nella sua esperienza. (…) Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c’è spazio – nel quadro dell’“alleanza terapeutica” che tiene uniti il malato ed il medico nella ricerca, insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno – per una strategia della persuasione, perché il compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza; e c’è, prima ancora, il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico”.
La sentenza modenese, inoltre, richiama il precedente giurisprudenziale di Cassazione civile, n.29469/2020, che, proprio nell’esaminare il caso del rifiuto alle emotrasfusioni del Testimone di Geova, ha sancito il principio secondo cui il diritto all’autodeterminazione (a cui si deve aggiungere quello di libertà religiosa) non incontra principi di segno contrario dovendo ritenersi, sia il diritto alla salute sia all’autodeterminazione, beni-interessi riconducibili alla medesima posizione soggettiva del paziente e, pertanto, “il conflitto tra due beni, entrambi costituzionalmente tutelati, della salute e della libertà di coscienza, non può essere risolto sic et simpliciter a favore del primo, avendo ogni individuo il diritto di scegliere e non potendo alcuna autorità statuale, legislativa, amministrativa, giudiziaria imporre trattamenti sanitari individuali al di fuori dei casi consentiti dalla legge”. In tale pronuncia la Cassazione ha, tra l’altro, ritenuto l’art.32 Cost. una espressione del diritto dell’individuo alla tutela della salute “riconducibile alla posizione soggettiva del singolo e non ad un bene-interesse contrapposto a tale posizione (non potendosi ritenere il riferimento nella norma costituzionale all’interesse della collettività alla salute dell’individuo in contraddizione al principio di autodeterminazione enunciato dalla medesima norma” [per un commento si rinvia a Federico Papini, Lucio Marsella, Cristina Mosenscaia in Giurispr. it. 4/2021, “L’autodeterminazione sanitaria del Testimone di Geova quale espressione di liberà religiosa”, pg. 806-809. Altri precedenti sul tema che ribadiscono il rifiuto delle emotrasfusioni quali espressione del diritto della libera autodeterminazione del paziente meritevole di tutela sono: Cassazione civile, sez. III, 6/9/2022, n.26209; Cassazione civile, sez. III, 15/1/2020, n.515; Cassazione civile, sez. I, 15/5/2019, n.12998; Cassazione civile, sez. I, 7/6/2017, n.14158].
Né può trascurarsi, anche se non citata nella sentenza in commento, l’ampia casistica giurisprudenziale che si è formata a livello europeo sulla scorta dei medesimi princìpi e valori espressi dagli artt.3, 8, 9 e 14 della Convenzione europea quali, tra le varie, Testimoni di Geova di Mosca c. Russia del 10/6/2010 [il paragrafo 135 afferma “Il rispetto della dignità e della libertà dell’uomo è l’essenza stessa della Convenzione, e i concetti di autodeterminazione e autonomia della persona sono principi importanti alla base dell’interpretazione delle sue garanzie (…) Nel campo dell’assistenza sanitaria, anche nei casi in cui il rifiuto di una particolare cura potrebbe condurre a un esito fatale, l’imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente adulto e capace di intendere e volere interferirebbe con il diritto di quest’ultimo all’integrità fisica, e violerebbe i diritti protetti dall’Articolo 8 della Convenzione”], Caso Taganrog LRO e altri v. Russia, 7 giugno 2022 [il paragrafo 162 dichiara che “… la libertà di accettare o rifiutare un trattamento medico specifico o di scegliere una forma alternativa di trattamento è fondamentale per i principi di autodeterminazione e autonomia personale. Affinché questa libertà sia significativa, i pazienti devono avere il diritto di fare scelte che siano in accordo con le loro opinioni e i loro valori, a prescindere da quanto irrazionali, imprudenti o irrazionali possano apparire agli altri. Un paziente adulto e competente è libero di decidere, ad esempio, se sottoporsi o meno a un intervento chirurgico o, allo stesso modo, se sottoporsi a una trasfusione di sangue o se preferire alternative al sangue. La libera scelta e l'autodeterminazione sono componenti fondamentali della vita e che, in assenza di indicazioni sulla necessità di proteggere la salute pubblica, lo Stato deve astenersi dall'interferire con la libertà di scelta individuale nell'ambito dell'assistenza sanitaria, poiché tale interferenza può solo diminuire e non aumentare il valore della vita]; Pretty c. Regno Unito del 29/4/2002, Soares de Melo c. Portogallo del 16/2/2016, Grande Camera, 05/06/2016, Lambert c. Francia.
Infine, si ricorda in base a quanto stabilito sia dalla giurisprudenza di merito (vedi sentenza Tribunale Penale di Termini Imerese n. 465/2018, confermata dalla Corte di Appello di Palermo, n. 4101/2020, 11.11.2020 e Tribunale Penale di Tivoli n. 1179/20 del 01.10.2020, riferite entrambe a trasfusioni forzate nei confronti di pazienti testimoni di Geova pre-legge 219/2017), che da quella di legittimità (su tutti le SS.UU. penali n. 2437/2009 c.d. Giulini), che il trattamento sanitario praticato contro il dissenso espresso di una persona, anche se considerato salvavita, integra il reato di violenza privata ex art. 610 c.p..
La liquidazione del danno
Quanto all’entità del risarcimento del danno iure hereditatis, il Tribunale fa propria la valutazione contenuta nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel 2021 che prevedono espressamente la voce di danno relativa alla lesione dell’autodeterminazione per il caso delle trasfusioni di sangue in paziente Testimone di Geova (inserita tra il danno di eccezionale gravità).
Il giudice ha personalizzato il limite minimo previsto dalle tabelle per un importo di 30.000 euro e questo in base alla durata della sofferenza, intesa come tempo di percezione del danno, che è andato dalla somministrazione della terapia al decesso. Quindi per “soli” 37 giorni di sofferenza – tanto è stato infatti il lasso di tempo in cui la paziente è vissuta dopo le trasfusioni – il tribunale ha riconosciuto un incremento del 50% rispetto al minimo tabellare (pari a 20.000 euro).
Per il danno iure proprio in favore del marito, liquidato in via equitativa per 8.000 euro, il Tribunale ha “considerato il legame che li univa non solo nella vita ma altresì nella condivisione della fede religiosa, lo stato d'animo e la sofferenza che una tale privazione deve avere determinato”.
Conclusioni
La sentenza in commento dimostra, ancora una volta, la capacità della nostra Costituzione di saperci veder lungo o, come si espresse Piero Calamandrei in un suo intervento in Assemblea Costituente, di “essere presbite”. A volte, quello che serve, è forse solo lo sforzo di saperci guardare dentro, senza preconcetti, avendo cura di mantener pulite le proprie lenti.
OSSERVAZIONI PAOLO CENDON
1 - Il fatto che, nella sentenza in esame, venga assegnato un preciso rilievo alla responsabilità civile, come istituto cui ricorrere per le violazioni del consenso informato; la circostanza cioè che ottenga tutela risarcitoria, presso il giudice, la persona la quale aveva espresso un formale ‘’dissenso al trattamento’’, e che se lo era visto poi, nel corso della vicenda, disattendere/snobbare dai sanitari: orbene, tutto ciò non è propriamente una novità per il diritto privato.
E tanto meno appare una sorpresa, aggiungiamo, il fatto che figuri riconosciuto, nel giudizio, un ruolo decisivo alla volontà espressa, in punto di trasfusioni, da un paziente testimone di Geova: quand’anche la scelta di rifiutare il sangue altrui si annunci – ecco il punto – tale da minacciare la morte (come accade non di rado) o comunque un’infermità residuale per il paziente.
2 - E’ evidente, val la pena di rimarcare, la distanza di tutto ciò rispetto al capitolo del c.d. ‘’Patto di rifioritura’’; quale appare avanzato, sempre più spesso, dagli interpreti che si occupano di amministrazione di sostegno.
Quando si afferma cioè che il Giudice tutelare e l’Amministratore di sostegno - allorché abbiano a che fare con tipologie di beneficiari affetti da gravi dipendenze, quali droga, alcool, ludopatia, sesso malato, disturbi alimentari e così via - avranno il potere/dovere di disattendere le ‘’indicazioni pericolose’’, espresse dall’assistito, fin lì, sul terreno sanitario: con la necessità di imporre strategicamente allo stesso, in particolare, determinati trattamenti salvifici, sia pure cercando di negoziare amabilmente i dettagli del percorso terapeutico, ogniqualvolta la strada su cui vorrebbe insistere l’assistito (il rifiuto ostinato delle cure, poniamo, il no all’ingresso in comunità, ai farmaci, all’astinenza, alla sobrietà, all’uscita dal tunnel) comporti insidie significative.
E basta pensare al frangente, particolarmente drammatico, della donna incinta la quale intenda continuare a drogarsi, come se nulla per lei fosse cambiato: ipotesi in cui è evidente che l’ordinamento dovrà fare quanto può per scongiurare la morte, o una nascita infelice, del bambino in grembo.
Nessun serio confronto, come si vede, con le ambasce proprie del testimone di Geova: situazioni in cui la questione storica, che dà luogo ai problemi curativi, nulla ha a che vedere, per se stessa, con una dipendenza di tipo morboso, para-psichiatrico; in cui cioè la scelta di rifiutare il trattamento, da parte del sofferente, mostra di poggiare su ispirazioni di tipo religioso - elementi ai quali l’ordinamento giuridico ha deciso in Italia come si sa, negli ultimi decenni, di attribuire un risalto decisivo.
3 - In ambito di danno non patrimoniale si è spesso discusso, all’inizio del dibattitto, sul piano teorico e pratico, se dovesse prevalere operativamente una linea ‘’eventistica’’, oppure una linea ‘’consequenzialistica’’: se sarà cioè sufficiente, per la vittima, dimostrare hic et nunc l’avvenuta violazione del diritto soggettivo, che gli è proprio, o se sia invece necessario nel processo, affinché possa farsi luogo al risarcimento, l’ulteriore dimostrazione del danno specificamente patito.
Si è imposta sempre più diffusamente, presso gli interpreti italiani, una lettura di stampo consequenzialistico, sia pur temperata con la sottolineatura dell’importanza che è destinato ad assumere, in questo campo, il ricorso alle presunzioni.
E da questo punto di vista, potremmo dire che la sentenza oggi in esame si inquadra tendenzialmente fra i materiali portatori, piuttosto, dell’opposta ispirazione eventistica.
La donna, vittima del mancato rispetto per il dissenso da lei prestato, si vede salvaguardata cioè, con lo strumento del risarcimento, indipendentemente o quasi da una dimostrazione puntuale del danno; protetta semplicemente per il ‘’riscontro catastale’’ del fatto antigiuridico, che è imputabile ai medici - del sacrificio formale cui il civil right è andato incontro, nella vicenda in questione.
4 - Se guardiamo più attentamente, comunque, alla natura intrinseca del pregiudizio, riconosciuto dal giudice, va preso atto come la sentenza parli di ‘’danno morale’’.
E non c’è dubbio che la presenza di tale figura, di coloritura negativa, sia quella prevalente nei casi in questione.
Le ricadute per il plaintiff si collocheranno qui, in effetti, soprattutto sul terreno della sofferenza, del patimento interiore: in quanto è stata violata la libertà del singolo, per l’appunto la sua dignità, il bastione della sua autodeterminazione, il suo santuario ideale più profondo.
Danno in re ipsa, per dirla altrimenti, da ristorare senza necessità di dimostrazioni particolari, da presumere in via automatica.
Potremo chiederci, casomai, se in evenienze del genere non potranno sussistere, a carico dell’offeso, anche profili ‘’esistenziali’’ di lesione: nel senso che sarà spesso possibile, in effetti, immaginare ‘’scelte di vita’’ che il paziente esprimerà, o non esprimerà più, semplicemente per il disagio personale del sentire in circolo, nel suo corpo, una sostanza liquida che non egli non desiderava, che aveva respinto culturalmente a monte: scelte attinenti alla comunicazione sociale, poniamo, di cittadinanza, mondane cioè in senso ampio, relative ad esempio ai farmaci per l’avvenire, alle diete, ai comportamenti spiccioli, alle relazioni correnti con gli altri, agli affetti, alla sessualità, al rapporto con il terapeuta, con la equipe sanitaria, e così via.
E potrebbero aggiungersi, talvolta, presso gli esseri più sensibili, nelle ipotesi più complesse, capitoli di ordine strettamente ‘’biologico-psichico’’.
5 - Altro profilo sul quale interrogarsi è poi quello dell’eventuale ammissibilità - in contesti come quelli qui considerati – dell’istituto della compensatio lucri cum damno: data cioè la rilevanza della posta morale/esistenziale, quale sopra tratteggiata, potrebbe mai prospettarsi che da siffatta cifra andrà diffalcata la quota corrispondente ai ‘’vantaggi’’, di tipo medico-fisiologico, quali possa comportare il fatto di avere del ‘’sangue rinnovato‘’, oggettivamente benefico, provvidenziale, nel proprio ambito corporeo?
6 - La novità più significativa, ad ogni modo, risulta quella del riconoscimento che la sentenza effettua - come passaggio meritevole di attenzione – al ‘’danno dell’amministratore di sostegno’’: seppure in questo caso risarcito con una cifra modesta (8 mila euro), la quale assume soprattutto un valore simbolico.
E’ una conclusione, sottolineiamo, che merita senz’altro di essere approvata.
E ciò proprio in nome di quella ‘’funzione empatico-partecipativa’’ – il sistema solidale coni nuclei antropologici della vittima, pronto a scandire pubblicamente tali opzioni – che si raccorda immancabilmente ai simboli
La domanda è allora la seguente: sarebbe il giudice arrivato alla stessa conclusione laddove l’amministratore di sostegno non fosse stato, come in questo caso, un parente stretto della paziente?
Può anche darsi di sì - dipenderà, può osservarsi, dalle peculiarità del caso; determinante risulterà, visto che parliamo soprattutto di danno morale, il tipo di relazione affettiva ravvisabile volta per volta, famiglia o non famiglia, tra AdS e beneficiario.
Considerato infine come il dolore sia quello legato alla vicinanza spirituale con la vittima, sarebbe ammissibile – ultimo interrogativo - una quota di risarcimento correlabile al disagio e all’umiliazione, che l’AdS subisca per il fatto di essere stato ‘’lui stesso’’ in prima persona (come gestore e vettore di indicazioni negoziali, come professionista ufficiale di aiuto) frustrato/ignorato dai medici?
Allegati