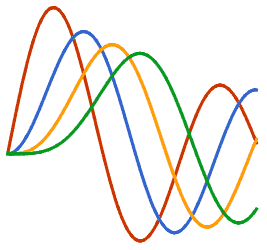- Fabbricatore Alfonso - 23/07/2015
TUTTA COLPA DI EPICURO: IL DANNO TANATOLOGICO NON E' UN DANNO RISARCIBILE - A. FABBRICATORE
"L"onda successiva rimetterà tutto a posto"
(Cendon)
Con le parole tratte da un celebre saggio ho concluso un mio pensiero in merito al danno tanatologico, alla tanto attesa pronuncia delle S.U. (Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350).
E l"onda, alla fine, è arrivata, spazzando via il castello di sabbia che qualcuno si era adoperato a costruire sul bagnasciuga della responsabilità civile. Tutto sommato, era solo un castello di sabbia.
Dopo più di un anno, la Cassazione, in pompa magna, affronta lo spinoso argomento del danno da morte immediata, riportando le lancette dell"orologio a quel lontano 22 dicembre di quasi novant"anni fa.
Il danno da morte immediata, in sintesi, non è un danno risarcibile: "nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis. Tale orientamento risalente (Cass. Sez. Un. 22 dicembre 1925, n. 3475: "se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l'esistenza di un subbietto di diritto.") ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell'impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (…) a tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento".
Dunque tanto rumore per nulla: avrò letto, in questo periodo, un migliaio di elaborati, di scritti, di idee, una produzione abnorme di parole, pensieri, definizioni, termini. Tutto inutile, o quasi. Resta comunque un vuoto evidente, che prima o poi andrà colmato.
Tuttavia l"intervento delle S.U. non chiarisce i punti più oscuri del problema; non risolve il contrasto originatosi con la pronuncia 1361/14 (in realtà già da tempo avvertito); non fornisce una interpretazione autentica ed originale dell"argomento; non consente di fugare i dubbi di coloro che da tempo non riescono a spiegarsi il perché di una tutela ridotta, in ambito aquiliano, per il bene vita; non spiega le ragioni per cui la responsabilità civile dovrebbe appiattirsi su concetti che oggi sembrano ampiamente superati.
I fattori su cui insiste la motivazione sono i soliti, tramandati in decenni di dibattiti: impossibilità di risarcire a favore della vittima dell"illecito il danno quando la morte sia immediata o segua a brevissima distanza di tempo l"evento; sviamento dalla funzione meramente compensativa attribuita alla responsabilità civile, che, in questi casi, tenderebbe grossomodo a sanzionare la condotta particolarmente riprovevole del danneggiato; uccidere non è economicamente più conveniente che ferire, in quanto il complesso delle norme penali permette di perseguire adeguatamente l"autore dell"illecito da cui derivi la morte di un altro soggetto ("coglie il vero, peraltro, il rilievo secondo cui oltre che oggetto di un diritto del titolare, insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio, la vita è bene meritevole di tutela nell'interesse della intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185, 2° comma c.p. al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato, ma non impone necessariamenteanche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse che forse sarebbe più appropriato definire generale o pubblico, piuttosto che collettivo, per l'evidente difficoltà, tutt'ora esistente per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa, di individuare e circoscrivere l'ambito della "collettività" legittimate a invocare la tutela".); risarcibilità dei soli danni-conseguenza, senza alcuna eccezione.
Si tratta di una sentenza stringata, scontata, ridondante, pletorica; si tratta di un giallo senza colpi di scena; di una fiaba senza il lupo; di una torta senza candeline. Una pronuncia arida, infeconda, piatta.
L"occasione era ghiotta: sicuramente non servita su di un piatto d"oro (non è andata esente da critiche la 1361); ma il risultato sarebbe potuto essere talvolta diverso.
Dunque, accennavo tempo fa, il revirement della Terza sezione, pur se coraggioso e molto ben architettato, grazie al quale il vaso di Pandora è stato finalmente aperto, difficilmente avrebbe superato il vaglio delle S.U..
Difficile, infatti, accogliere la tesi secondo cui il danno da perdita in sé della vita possa costituire necessaria eccezione alla teoria del danno-conseguenza, dovendosi ritenere che all"atto stesso della verificazione dell"evento il danneggiato acquisisca un credito risarcitorio per la perdita della propria vita. In questo modo si finisce comunque per attribuire al fattore temporale un ruolo fondamentale, poiché a rilevare è l"individuazione dell"esatto momento in cui un diritto può sorgere in capo alla vittima e non già il perché ed il come questo diritto possa essere riconosciuto; diverso sarebbe invece rileggere la questione sul piano logico, individuando gli antecedenti causali del fatto e le relative conseguenze eziologiche: vita e morte, si è ripetuto più e più volte, sono concetti agli antipodi, di talchè è logicamente improbabile che l"attivazione dello strumento risarcitorio possa dipendere dall"esatta individuazione del momento ultimo di vita del soggetto leso.
Con la morte della persona a seguito delle lesioni cagionate dalla condotta del terzo viene pregiudicato il bene principale che sta alla base del valore uomo: ciò fa si che nonostante la persona si sia estinta, sia necessario comunque riparare a questa perdita anche in ambito civilistico mediante l"attivazione degli strumenti tipici quali il risarcimento del danno ingiusto.
Ad essere risarcita è la perdita di tutto ciò che costituisce la persona umana, il suo manifestarsi, e tale meccanismo, anche se indirettamente, vale ad accrescere il credito da trasmettere agli eredi: dal risarcimento la vittima non trae, direttamente, vantaggio alcuno.
Non deve sembrare una forzatura: il risarcimento del danno è tipicamente uno strumento volto ad assicurare alla vittima una utilità sostitutiva del bene/interesse compromesso, non già a ripristinare la situazione antecedente la verificazione del danno. Da ciò si evince che, anche nel caso di morte, il risarcimento assicurerebbe quella funzione compensativa e correttiva come avviene in altre e numerose ipotesi: va da sé che quando venga risarcito un danno a persona, l"intento non sia quello di restituire alla vittima la stessa condizione di benessere fisico, psichico e relazionale compromessa, ma si cerchi di correggere la fase negativa, successiva all"illecito, mediante l"elargizione di una somma di denaro di cui la vittima possa usufruire per procurarsi altre utilità.
Nei casi in cui tuttavia la vittima acquisisca tale diritto nel momento stesso in cui decede (a nostro avviso, infatti, non vale neanche rilevare che la morte non sarebbe mai istantanea, poiché in questo caso, allora, il soggetto non avrebbe ancora maturato alcun diritto al risarcimento del danno da morte), non è possibile garantirle una soddisfazione personale, ma si mira principalmente ad assicurare un certo grado di giustizia nelle relazioni sociali, alla base delle quali non sta il soggetto, bensì l"interesse.
Ancora i danni da agonia, allora. Danno biologico e morale terminali o catastrofici, come si preferisce. Ancora apprezzabilità e percettibilità delle sofferenze; ancora cronografi nelle mani dei giudici, pronti a contare secondi, minuti, ore e giorni che separano la vita dalla morte; ancora errori di fondo nella valutazione dei fatti:
"Ora, in disparte che la corrispondenza a un'indistinta e difficilmente individuabile coscienzasociale, se può avere rilievo sul piano assiologico e delle modifiche normative, più o meno auspicabili, secondo le diverse opzioni culturali, non è criterio che possa legittimamente guidare l'attività dell'interprete del diritto positivo, deve rilevarsi che, secondo l'orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienzasociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato). Come è stato osservato (cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria "sia data "anche" al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti".
Torneremo ad affrontare, in maniera più approfondita, il ragionamento effettuato dalle S.U.: lo faremo punto per punto, parola per parola; cercheremo di capire quali saranno gli scenari futuri e quali le problematiche che deriveranno, nell"immediato, dalla preannunciata preclusione del danno tanatologico dall"ambito del danno risarcibile.
"Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci."
Epicuro avrebbero dovuto tacitarlo da bambino!