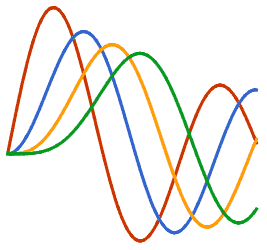- Gasparre Annalisa - 05/02/2014
LE MODIFICHE MEDIATE DEL PRECETTO PENALE - Annalisa GASPARRE
Le cd. modifiche mediate del precetto penale: l'abolitio criminis e la successione di norme "integratrici".
Gli elementi costitutivi del precetto penale sono suscettibili di modifica o abrogazione, tali da travolgere l'intero precetto. La fattispecie incriminatrice può subire conseguenze circa la sua "esistenza" e "permanenza" nel sistema, anche nelle ipotesi in cui vengono ad essere modificati elementi normativi richiamati o inclusi nella fattispecie. Si parla di modifiche "mediate" o "indirette" per distinguerle da quelle "immediate" (che riguardano gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice).
Se tali modifiche a norme diverse da quella incriminatrice determinino la "scomparsa" della fattispecie oppure una mera successione di legge, è questione controversa in dottrina e in giurisprudenza, molto dibattuta in passato, nonché oggetto di attenzione da parte delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, in arresti recenti, hanno individuato un filo comune nel disciplina e trattamento delle modifiche "mediate" e di quelle "immediate", individuando detto criterio nel discrimine tra norme integratrici e non integratrici della fattispecie incriminatrice.
La problematica, lungi dall'essere oggetto di mera speculazione scientifica, ha ricadute pratiche di grande rilievo.
Nel caso di abolitio criminis, cioè di venir meno di una fattispecie per sua abolizione, prevista dal co. 2 dell'art. 2 c.p., si annulla il giudizio di disvalore dell'ordinamento penale rispetto a un fatto (principio della retroattività della legge sostanziale più favorevole), tanto che, come noto, se è stata pronunciata condanna, ne cessa l'esecuzione (c.d iperetroattività). Un fatto, in altre parole, cessa di costituire reato. Nel caso di continuità punitiva, invece, dovrà applicarsi il criterio della successione di leggi nel tempo, previsto dal co. 4 dell'art. 2 c.p.
Nulla quaestio, sotto questo profilo, se l'abrogazione concerne l'intera fattispecie e non viene sostituita da altra. Il ragionamento invece è destinato a rendersi più complesso nel caso in cui siano abrogati o modificati (per via indiretta) singoli elementi della fattispecie, per ulteriormente intricarsi là dove si ponga alla mente che gli elementi della fattispecie possono avere natura (normativa: penale o extrapenale, extragiuridica; integrativa della norma penale in bianco; definitoria; descrittiva) ed importanza diversa nell'ossatura della fattispecie.
Variegate sono pertanto le soluzioni proposte perché variegate sono le ipotesi in cui può essere necessario interpretare il disposto dell'art. 2 co. 2 c.p. che, a ben vedere, rimanda alla nozione di "fatto" (che per una legge posteriore non costituisce reato), dove per "fatto" si intende il "fatto tipico", quindi il complesso di elementi costitutivi dell'incriminazione, cioè l'insieme dei presupposti rilevanti in concreto per l'applicazione di una fattispecie incriminatrice (secondo una lettura coerente tra primo e secondo comma dell'art. 2 c.p.).
Come accennato, gli elementi costitutivi possono essere normativi o descrittivi; questi ultimi non rilevano nella discussione in esame perché non possono essere suscettibili di modifica da parte del legislatore, attingendo alla natura e alla materialità delle cose. Altra natura (e rilevanza) hanno, invece, gli elementi normativi che sono quelli che, implicitamente o meno rinviano, a norme giuridiche che possono essere omogenee rispetto al settore penale (es. del concetto di reato sottostante al reato di calunnia) oppure eterogenee, quindi appartenenti ad altri rami dell'ordinamento (ad es. i reati colposi od omissivi impropri in riferimento alle norme cautelari o alla posizione di garanzia). Del pari, gli elementi normativi possono trovare fonte in elementi extragiuridici o culturali (si pensi al concetto di atti osceni che è suscettibile di cambiare nel tempo) o in norme c.d. definitorie, quali quelle che contengono un enunciato che "etichetta" un elemento in modo dettagliato e preciso, come il concetto di "minore".
Ciò premesso, la dottrina ha dibattuto la questione senza trovare un condiviso approccio. In estrema sintesi, alcuni Autori hanno sostenuto che la modifica di un elemento non inficerebbe la struttura della fattispecie, non alterandone il disvalore: l'esclusione di norme extrapenali dall'ordinamento non altererebbe la norma incriminatrice che tali norme richiama o presuppone, di talchè le modifiche riguarderebbero solo diversi fatti concreti, con conseguente irrilevanza ai fini del co. 2. Secondo altra tesi, occorrerebbe distinguere a seconda che l'intervento legislativo faccia venir meno il disvalore del fatto (così vi sarebbe abrogatio nel caso in cui sia depenalizzato il reato-fine dell'associazione per delinquere, perché l'associazione criminosa sarebbe privata del proprio scopo, non invece nel caso della calunnia, delitto che sarebbe insensibile – dal punto di vista del disvalore – alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di incolpazione). Altri ancora sostengono che ogni modifica di disposizioni – di qualsiasi tipo – avrebbe l'effetto di travolgere la norma incriminatrice.
La giurisprudenza, dal canto suo, dopo fisiologiche controverse pronunce, di recente – grazie all'intervento delle Sezioni Unite – si è assestata nell'identificare un criterio per stabilire se la modifica o l'esclusione di taluni elementi della fattispecie possano comportare l'abolizione della fattispecie incriminatrice che quegli elementi richiami o presupponga. Tale è il "criterio strutturale" – criterio mutuato dalla giurisprudenza in tema di modifiche immediate al precetto penale – per cui si devono confrontare strutturalmente le fattispecie che si succedono nel tempo per affermare se vi sia abolitio o successione. Se le modifiche mediate alterano la struttura della fattispecie, allora ci sarà abolitio, perché muta il giudizio politico criminale che travolge il disvalore penale precedentemente espresso.
Ebbene, secondo la Cassazione occorre guardare alla fattispecie e verificare se, a seguito alle modifiche, la fattispecie incriminatrice sia variata, ciò in quanto non tutte le norme hanno la medesima funzione: alcune sono integrative, altre no. Questo è il nodo della questione, secondo la Suprema Corte.
Funzione delle norme integrative è quella di precisare, limitare o disciplinare l'applicabilità di altre norme, ma tali connotati non sono sufficienti: la norma integratrice deve avere anche la forza di incidere sull'offesa al bene giuridico, sulla valutazione, cioè sulla struttura della fattispecie incriminatrice. Oltre che nell'integrare le norme penali in bianco, le norme integrative possono trovare spazio anche in fattispecie più complete sotto questo profilo (ad es. è norma integrativa quella che definisce la nozione di pubblico ufficiale, cui fanno riferimento tutti i delitti propri commessi contro la pubblica amministrazione) per cui non è di immediata percezione comprendere se la norma sia integratrice o meno del precetto penale, specie là dove la norma non sia palesemente definitoria.
Richiamando il criterio strutturale, la Suprema Corte ha affermato che solo le norme integratrici (quali sono per antonomasia le norme definitorie, ma non solo) possono determinare l'abolitio criminis, non invece quelle che integrative non sono. In altre parole, solo le norme idonee ad incidere sulla "struttura" della fattispecie di reato, possono essere attratte nella disciplina del co. 2 dell'art. 2 c.p., di talché solo in tali ipotesi si può parlare di norme in forza delle quali viene meno l'antigiuridicità penale per una legge posteriore rispetto al fatto. Invero, anche se la questione attiene al profilo soggettivo, e quindi alla colpevolezza, il discrimine in parola – che fa leva sull'integrazione del precetto penale – si ritrova anche nella discussione relativa all'errore su legge diversa da quella penale, declamandone la non scusabilità solo nell'ipotesi in cui siano norme integratrici del precetto, in virtù di quanto afferma l'art. 5 sull'inescusabilità della legge penale.
Nei casi in cui si escluda che vi sia abolitio criminis – cioè, secondo l'insegnamento della Cassazione, quando la norma richiamata non sia integratrice – non viene ad essere intaccata la sussistenza del reato, ma vi sarà spazio per le regole in tema di successione della legge più favorevole, in quanto vi è continuità punitiva. Il capitolo che si apre sarà quello volto a determinare quale sia la legge più favorevole al reo (co. 4 art. 2 c.p.), soluzione che va cercata in riferimento al caso concreto, considerando le conseguenze che derivano dall'applicazione delle norme (precedenti e posteriori) al caso singolo.