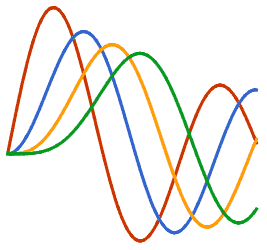- Battaglia Roberto - 03/03/2014
U.S.A. E U.E.: ORDINAMENTI A CONFRONTO - Roberto BATTAGLIA
U.S.A. e U.E.: ordinamenti a confronto.
1. Premessa.
1.1. Operare un raffronto tra l"ordinamento degli Stati Uniti d"America e l"ordinamento dell"Unione europea impone necessariamente una serie di valutazioni che, lungi dal limitarsi al lato più strettamente tecnico – giuridico, coinvolgono anche aspetti storici, politici ed economici, ai quali è opportuno fare riferimento per una corretta comprensione del fenomeno nel suo complesso.
1.2. Come risulta ictu oculi, quando parliamo di Stati uniti d"America e di Unione europea ci troviamo di fronte, in realtà, a "grandezze" non omogenee e quindi non esattamente comparabili.
I primi sono certamente uno Stato, e più in particolare rientrano nel novero degli Stati federali: L"Unione europea non è, invece, uno Stato, rappresentando bensì la stessa un fenomeno sovra-nazionale, seppure sui generis, che si differenzia dalle altre organizzazioni internazionali, e in cui il connotato "federale" può essere visto come una sua possibile evoluzione o tendenza, ma non certo come una realtà già acquisita o acquisibile nel breve periodo.
Sotto altro profilo, se con riferimento all"ordinamento statuale americano è possibile evidenziarne i connotati di Repubblica presidenziale, nel caso dell"Unione europea è discussa persino la stessa possibilità di parlare di forma di governo, non potendosi a rigore utilizzare una categoria (la forma di governo, appunto) che è propria degli ordinamenti statuali.
1.3. Si tratta perciò di ricercare, dopo aver brevemente inquadrato le caratteristiche principali dei due ordinamenti, quali siano le analogie e le differenze tra gli stessi: Sotto questo profilo, va tenuto conto che nel contesto attuale dinanzi all"emergere di divergenze tra U.S.A. ed Europa sotto il profilo geo-politico e strategico, non si può non registrare, sul versante istituzionale, una tendenziale affinità se non convergenza tra l"ordinamento statunitense e quello comunitario.
2. Gli U.S.A. come Stato federale e come Repubblica presidenziale (cenni).
2.1. Dal punto di vista della forma di Stato, gli U.S.A. sono qualificabili come uno Stato federale ([1]). Sotto questo profilo, va sottolineato come essi costituiscano la prima federazione ad aver assunto una forma statuale.
Il fenomeno dello Stato federale viene inteso come un"associazione fra Stati, secondo un modello per cui i poteri sono divisi fra un governo centrale e i governi degli Stati associati, che attuano una rinuncia a quote di sovranità, in modo tale che in alcune materie gli uni siano indipendenti rispetto agli altri e viceversa.
2.2. Va osservato che, storicamente, non sempre i processi federativi hanno portato alla formazione di uno Stato vero e proprio (id est con un potere legislativo, esecutivo e giudiziario a livello centrale), limitandosi in alcuni casi alla formazione di leghe o confederazioni; in altri casi, a tale forma intermedia ha fatto seguito la nascita di un governo centrale federale.
Si può ricordare il caso americano degli Articoli di confederazione del 1778, superati dalla Costituzione del 1787; il caso svizzero delle leghe, cui seguirono le confederazioni del 1803 e del 1815, e la creazione dello Stato federale nel 1848; ancora, la Confederazione del Reno del 1803, la Confederazione germanica del 1815, e la nascita del Reich tedesco del 1871. Va peraltro ricordato come esistano sistemi federali che scaturiscono da un processo di differenziazione all"interno di uno Stato sovrano che esiste già ed è unitario, per cui si parla di federalismo "per devoluzione", che generalmente vede la luce per passi successivi, e con un assetto asimmetrico nella distribuzione dele competenze ([2]).
2.3. Dovendo tratteggiare i tratti comuni, sotto il profilo istituzionale, dello Stato federale, essi sono rinvenibili, in primo luogo, nella presenza di una Costituzione federale scritta (che codifica l"accordo e attribuisce le competenze), suprema (ossia sovra-ordinata rispetto alle normative degli Stati federati) e rigida (essendo necessaria, nell"ambito del procedimento di revisione costituzionale, una maggioranza qualificata in entrambe le camere e la partecipazione del governo centrale e di quelli federati). In secondo luogo, all"interno della camera alta vi è la rappresentanza delle diverse entità che compongono la federazione, che partecipano alla formazione delle politiche nazionali. Nel caso degli U.S.A., vi sono due senatori per Stato, a prescindere dalla popolazione. (In Australia, vi sono dodici senatori per Stato, in Svizzera due per ogni cantone).
Nell"ambito dello Stato federale – va infine osservato - è prevista la competenza di un organo giudiziario apposito in riferimento alle problematiche relative alla divisione dei poteri, e più precisamente la risoluzione dei conflitti che riguardano l"attribuzione di competenze: nel caso americano, la Corte Suprema.
Generalmente le costituzioni federali contengono un"elencazione esplicita delle materie di competenza del governo centrale (perlopiù affari esteri, moneta, dogana), mentre le altre sono lasciate ai governi delle entità federate: ciò si spiega alla luce del fatto che le entità preesistenti, unendosi, hanno accettato limitazioni di sovranità, privandosi appunto delle competenze indicate nella costituzione stessa.
2.4. L"ordinamento americano federale si basa principalmente su tre livelli di governo: quello federale, quello dello Stato, quello del governo locale (contea o autorità municipali). Il potere legislativo federale viene esercitato dalle due Camere del Congresso: il Senato (100 membri, due per Stato, con mandato di sei anni) e la Camera dei rappresentanti (435 membri, con mandato di due anni). Vota le leggi federali, impone le tasse federali, dichiara guerra e ratifica i trattati internazionali. Il potere esecutivo non è legato a vincoli di fiducia con il potere legislativo. Il Presidente ha un mandato di quattro anni, e può essere eletto solo per due quadrienni. Il Presidente propone le leggi al Congresso, può porre il veto a proposte di legge che abbiano superato il vaglio del Congresso, ha il comando delle forze armate. Ha inoltre poteri di indirizzo dei dipartimenti e delle agenzie che fanno parte del governo federale: i capi dei dipartimenti principlali, i cd. "segretari", fanno parte del gabinetto del Presidente. Il potere giudiziario è esercitato, all"interno dell"ordinamento federale, dalla Corte suprema e da corti federali minori (corti d"appello federali e corti di distretto federale): esso ha il compito di interpretare e applicare il diritto federale (la Costituzione degli Stati Uniti, le leggi e i regolamenti federali), esercitando anche il controllo di conformità alla Costituzione degli atti normativi e risolvendo i conflitti di attribuzione tra potere legislativo ed esecutivo. A livello dei singoli Stati federati, va osservato che sono presenti i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Il capo dell"esecutivo dello Stato è il governatore, che viene eletto dal popolo (il mandato è in genere di quattro anni; in alcuni Stati è di due anni).
Fra le competenze statali basti in questa sede ricordare le comunicazioni interne, la proprietà, l"industria, gli affari, i servizi pubblici, la maggior parte degli illeciti penali. L"intervento degli stati federati non deve essere in contrasto con la Costituzione, le leggi federali e i trattati internazionali firmati dagli U.S.A.
2.5. Con riferimento alla forma di governo, gli U.S.A. sono qualificabili come una Repubblica presidenziale: il corpo elettorale elegge i ""grandi elettori" che nominano il Presidente, che è Capo dello Stato e al tempo stesso titolare monocratico del potere esecutivo; il potere legislativo è di competenza del Parlamento che è bicamerale.
Nell"ottica di una rigida divisione dei poteri (attenuata, peraltro, da forme di controllo reciproco e bilanciamento), non vi sono forme di collegamento fra potere legislativo e potere esecutivo. Il Parlamento non può, infatti, revocare il Presidente (salva l"ipotesi di impeachment, messa in stato di accusa), né quest"ultimo può sciogliere anticipatamente il Parlamento.
3. L"ordinamento comunitario: un fenomeno sovra-nazionale.
3.1. Il disegno di dare vita ad un"unione fra gli Stati europei, soprattutto nell"ottica di evitare conflitti e assicurare la pace, oltre che di costituire una difesa comune contro i pericoli esterni, è andata gradualmente delineandosi nei secoli, alla luce dell"esigenza, evidenziatasi con il sorgere degli Stati nazionali, di creare una federazione fra gli stessi ([3]). Basti ricordare lo scritto di Kant, Per una pace perpetua, in cui il filosofo alla fine del Settecento aveva prospettato la creazione, attraverso una fase intermedia costituita da una lega fra gli Stati, di una federazione tra gli Stati europei (una Comunità costituita sul modello repubblicano e con un diritto comune) per assicurare la pace ([4]).
3.2. Il progetto ambizioso di un'Europa unita attraverso un processo di integrazione è sorta nel secondo dopoguerra, sulla spinta delle esigenze di ricostruzione dell'economia e di coesione in risposta all'espansionismo dell'Unione Sovietica ([5]). Non si può negare che in altre epoche, anche remote, tale unità sia stata, almeno parzialmente (e in un senso diverso da quello in cui viene intesa nel momento storico attuale), raggiunta. Con l'Impero Romano si è certamente assistito alla creazione di un ordinamento giuridico estremamente complesso e nello stesso tempo duttile, caratterizzato da uno sforzo costante di riduzione ad unità, e con un'estensione, tra l'altro, superiore a quella dell"attuale Unione europea ([6]). Rispetto alla civiltà romana, nell"ottica della sopravvivenza dell"ordinamento dell"Impero romano d"occidente, l"esperienza del Sacro Romano Impero ha costituito un tentativo di dare continuità ([7]). L'epoca napoleonica, segnata certamente dalle continue guerre, ma anche da un'importante opera di codificazione ([8]), oltre che di organizzazione delle strutture amministrative, ha lasciato in eredità, oltre ai fermenti delle idee della Rivoluzione Francese, anche alcuni principi di diritto che hanno in vario modo ispirato le legislazioni degli Stati europei dopo la fine dell'Impero ([9]). Ma al di là dei casi in cui l'unità dell'Europa, o di gran parte del continente, era stata il risultato di un atto di forza di singoli Stati, il progetto ambizioso di un continente europeo unito si è avuto soltanto con i fermenti unitari manifestatisi dopo il secondo conflitto mondiale nell'Europa occidentale.
3.3. L'integrazione europea a livello comunitario ([10]), intesa come fenomeno non solo giuridico, ma anche politico, economico e sociale, ha conosciuto, nella sua evoluzione, varie fasi che ne hanno modificato l'estensione, la struttura, le competenze, le finalità. L'esperienza dell'integrazione europea è nata dapprima in un settore strategico ma pur sempre particolare, quello del carbone e dell'acciaio ([11]), e solo successivamente si sono affiancate la Comunità economica europea e la Comunità europea per l'energia atomica ([12]). Il Trattato di Maastricht ([13]) ha segnato il passaggio da una Comunità a fini prevalentemente economici ad una struttura ulteriore, quella dell'Unione europea (con i suoi tre pilastri), finalizzata ad un'integrazione più profonda.Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, l"integrazione nell"ambito dell"Europa occidentale si svolge dapprima secondo il metodo tradizionale della cooperazione intergovernativa, caratterizzata dalla prevalenza di organi di Stati, del principio dell"unanimità nelle decisione (con corrispondente diritto di veto del singolo Stato sovrano), e dell"assenza del potere di adottare atti vincolanti.
3. 4. Il carattere innovativo della forma di cooperazione fra Stati costituita dalle Comunità europee si spiega anche alla luce dell"esigenza di superare la regola del principio dell"unanimità e di dare maggiore autonomia alle proprie organizzazioni. In questo contesto vede la luce il cd. "metodo comunitario", caratterizzato dalla prevalenza degli organi di individui, che quindi non rappresentano lo Stato di appartenenza (Parlamento europeo, Commissione, Corte di Giustizia, Corte dei Conti, Banca centrale europea), la prevalenza del principio maggioritario (anche per il Consiglio, che è organo di Stati), e il potere di adottare atti vincolanti (assente o raro nell"ambito delle altre organizzazioni internazionali) ([14]).
3.5. Se è vero che i Trattati istitutivi sono formalmente accordi internazionali, sottoscritti e ratificati dagli Stati, sia il contenuto sia la giurisprudenza che si è sviluppata concorrono a qualificarli come un qualcosa di ulteriore rispetto a semplici accordi internazionali tra Stati che mantengono la propria sovranità.
In ambito comunitario, la Corte di Giustizia CE ha affermato, nella sentenza del 1963 Costa C. Enel, che la Comunità europea costituisce un "ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani".
In effetti, l"ordinamento comunitario, a differenza di quanto si può affermare per lo Stato, non mira riunire tutte le potestà sovrane, limitandosi a influire sul loro esercizio ([15]).
L"azione della Comunità è governata dal cd. principio di attribuzione, secondo il quale essa viene esercitata nei limiti delle competenza conferite e degli obiettivi assegnati dai Trattati (art. 5 Tr.UE).
3.6. Si è detto che la stessa possibilità di applicare al caso dell"Unione europea la categoria della forma di governo, sotto il profilo della suddivisione del potere tra gli organi costituzionali, è discussa.
Se da un lato l"impossibilità di ascrivere all"Unione europea il carattere di vero e proprio Stato pare precludere tale possibilità di qualificazione, si deve notare, dall"altro lato, che l"approccio per così dire "costituzionalista" assunto a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, parlando dei Trattati istitutivi come di una Carta Costituzionale, depone in senso positivo.
Per questo motivo, pare più prudente e più vicino alla realtà parlare, semmai, di ordinamento costituzionale in fieri o di processo di costituzionalizzazione non ancora ultimato.
3.7. Sotto tale aspetto "evolutivo" delle Comunità europee, si deve osservare che il tradizionale schema per cui la Commissione europea propone, il Consiglio decide, il Parlamento europeo esprime pareri, la Corte di Giustizia CE interpreta gli atti comunitari non è più corrispondente alla realtà: ciò alla luce della modifica dei compiti delle Istituzioni, al riadeguamento delle competenze dell"Unione europea nel suo complesso, oltre che per l"adesione progressiva di nuovi Stati. Il Parlamento europeo ha un ruolo nel procedimento normativo detto della codecisione, inoltre ha competenze in materia di bilancio e di controllo politico – istituzionale (ad es. può porre in essere una mozione di censura nei confronti della Commissione o di singoli Commissari). Il Consiglio è organo intergovernativo, con competenza legislativa e decisionale. Poiché è composta da un membri per Stato membro, rappresentante del governo, viene considerato poco rappresentativo e democratico. La Commissione, "custode dei Trattati", organo di individui, che non rappresentano lo Stato di appartenenza, è l"organo esecutivo (adotta atti di natura secondaria), con poteri di controllo (in materia di concorrenza e di divieto di aiuti di Stato alle imprese). Ha il monopolio dell"iniziativa legislativa nel I pilastro.
3.8. In ambito comunitario, non si può fare riferimento alla divisione dei poteri così come propria di un ordinamento statuale. La funzione legislativa è affidata principalmente all"organo formato dagli esecutivi nazionali (il Consiglio); la funzione esecutiva è di competenza della Commissione, che è orano tecnico indipendente; al Parlamento europeo, eletto dai cittadini, spetta principalmente il controllo politico. Nell"ambito del II e del III Pilastro, ove vige il metodo intergovernativo, il ruolo degli Stati e del Consiglio molto più pregnante. L"Unione europea prende decisioni, pur non avendo … un governo. Si noti che il Consiglio, che è composto di membri degli esecutivi (e non del potere legislativo) degli Stati membri, ha il potere di adottare atti normativi. Se la categoria della divisione dei poteri non può essere ascritta all"Unione europea, l"elemento che può contribuire spiegare un fenomeno peculiare come quello dell"ordinamento comunitario si può ricavare dalla giurisprudenza della corte di Giustizia CE, che ha parlato di "equilibrio istituzionale", il cui mancato rispetto può essere sanzionato dalla Corte stessa ([16]), cui si aggiunge quello della "leale cooperazione" tra le istituzioni, cui incombe il dovere di non ostacolare l"esercizio delle competenze attribuite ([17]).
3.9. Dopo la pausa di riflessione successiva alla bocciatura del Trattato che istituisce una Costituzione per l"Europa ([18]), il Trattato di Lisbona, che modifica il Trattato sull"Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea, detta nuove regole per il funzionamento dell"Unione europea a 27 Stati, nell"ottica di rendere più efficiente il procedimento decisionale, far aumentare la partecipazione democratica, attribuire maggiore coerenza all"azione della UE sul piano internazionale ([19]).
Si deve osservare che l"architettura istituzionale di cui alla "Costituzione" non è stato oggetto di stravolgimento alcuno. Sotto il profilo formale, traspare la volontà di "de-costituzionalizzare" il testo: Non si parla di costituzione né dei simboli europei (la bandiera, l"inno, la moneta): il Trattato stabilisce che l"Unione europea abbia personalità giuridica (potendo firmare trattati internazionali). Il termine "Comunità" è sostituito da "Unione": il Trattato CE diventerà Trattato sul funzionamento dell"Unione europea. Confermando l"opzione di cui al "Trattato-Costituzione, viene creata la figura del Presidente stabile del Consiglio europeo (che diventa pertanto un"Istituzione), con mandato di due anni e mezzo.
Viene creato un Alto Rappresentante della U.E. per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che raggruppa le funzioni dell"Alto rappresentante della PESC e del Commissario europeo alle Relazioni Esterne) che sarà anche vicepresidente della Commissione e Presidente stabile del Consiglio dei Ministri degli Affari esteri.
Lo stesso stabilisce che il Parlamento europeo elegga il Presidente della Commissione, creando in tal modo quasi un rapporto fiduciario. Un organo attualmente "tecnico" come la Commissione assumerebbe così un carattere politico.
Il ruolo dei parlamenti nazionali è rafforzato: essi potranno intervenire nella fase iniziale del procedimento normativo europeo, prima che una proposta venga esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
4. Differenze e analogie.
4.1. Le differenze sono evidenti. L"Unione europea non è uno Stato federale, perché evidentemente manca uno Stato centrale sovra-ordinato agli Stati membri.
L"ordinamento comunitario non si è formato in virtù del dissolvimento del legame preesistente con un ordinamento superiore, come invece gli U.S.A. in relazione all"Impero inglese.
Inoltre, pur avendo l"Unione europea accentrato alcuni settori nell"ambito della propria competenza (si pensi, ad es., alla politica monetaria e alla tutela della concorrenza), non ha le potestà tipiche dello Stato (ad es. una polizia, un esercito) né risorse finanziarie comparabili con quelle di una federazione. Tuttavia, poiché gli Stati membri hanno ceduto parte della loro sovranità, non si tratta di una mera confederazione, la quale, a sua volta avrebbe, a differenza della UE una vera e propria politica estera comune.
4.2 U.S.A. e U.E. hanno in comune, sotto un profilo storico – politico, il fatto che la crescita dei rispettivi ordinamenti è stata favorita in entrambi i casi dall"assenza di pericoli esterni e dal benessere economico interno: nel primo caso in virtù della protezione britannica, nel secondo caso in virtù della protezione americana.
4.3. Entrambi gli ordinamenti presentano un assetto policentrico, in cui vi appunto vi sono più centri di potere con capacità di azione. Il processo legislativo è disperso in entrambi gli ordinamenti. Il potere è territorialmente distribuito sia in ambito americano sia in ambito europeo. Sia negli U.S.A. sia nell"ambito dell"Unione europea vi è la separazione istituzionale tra potere esecutivo e potere legislativo: si tratta di una doppia separazione, sia in senso verticale sia in senso orizzontale, che – si deve osservare – non ha precedenti all"interno degli Stati europei, in cui la regola generale, sia nella repubblica (o monarchia) parlamentare sia nella "variante" semipresidenziale, è quella del collegamento tra i poteri, nel senso che il governo è espressione della maggioranza del Parlamento. L"uso concorrente e multi-livello dei poteri pubblici è presente non solo nell"ambito dell"ordinamento federale americano, ma anche nell"ambito dell"ordinamento comunitario ([20]).
4.4. Con riferimento all"Unione europea, si deve riconoscere che gli ambiti di competenza tra livello nazionale e livello sopranazionale non sono determinati con precisione in ogni settore; ciò comporta che l"organizzazione in parte è divisa, in parte è mista: se è vero che l"ordinamento comunitario ha propri organi (Commissione, Consiglio, Parlamento europeo, ecc.), è altrettanto vero che esso opera anche mediante gli organi degli Stati membri (Parlamento, Governo, ecc.) ([21]).
Alla luce delle procedure legislative che accostano il Parlamento europeo al Consiglio, oltre che in virtù dell"aumento delle materie con riferimento alle quali le due Istituzioni intervengono insieme, si intravede una qualche somiglianza con i sistemi federali in cui sono presenti una camera di rappresentanti degli Stati, e una dei cittadini ([22]). Il problema del cd. deficit democratico tuttavia permane nonostante il rafforzamento della struttura parlamentare. Se il ruolo funzionale del Parlamento europeo viene tendenzialmente sempre più valorizzato, non si è finora assistito ad un aumento del ruolo politico, per cui ciò che manca è proprio la rappresentanza politica, la dialettica fra i diversi partiti politici. Il parlamento europeo non opera secondo il binomio maggioranza e opposizione, bensì secondo logiche interistituzionali, per cui è controverso il poter parlare di forma di governo parlamentare. La partecipazione democratica attraverso i partiti rimane un fenomeno proprio del livello nazionale interno ([23]).
4.5. Un fenomeno che può essere considerato un elemento comune tra i due ordinamenti è quello del cd. lobbying che negli U.S.A. costituisce diretta espressione di un diritto costituzionalmente garantito, da cui si fa derivare la legittimità del fenomeno, salva l"esigenza di impedire degenerazioni in rapporti clientelari tra istituzioni e poteri forti. ([24]). In ambito comunitario, è prevalente la rappresentanza degli interessi sulla rappresentanza di tipo democratico – parlamentare. In proposito va osservato che sia l"assenza di veri e propri partiti europei, con conseguente carenza di legittimazione democratica dell"Unione europea, sia la presenza degli stessi in misura diversa e minore rispetto alla dialettica propria degli ordinamenti nazionali, lasciano spazio per forme di rappresentanza diverse, quali appunto i gruppi di pressione. A differenza dell"ordinamento statunitense, in ambito europeo non esiste una definizione precisa di attività di lobbying lecita e illecita. Per quanto concerne i rapporti con il Parlamento europeo, gli strumenti del lasciapassare e del codice di condotta appaiono inadeguati. Per quanto concerne la Commissione, vi è cautela ma senza imposizioni particolari. In generale, si osserva che nell"ordinamento americano la disciplina non riguarda solo chi subisce la pressione, ma anche a chi la esercita (imponendo obblighi di rendere pubbliche determinate informazioni). A livello europeo, nel cui ambito tale sistema di rappresentanza sta prendendo gradualmente piede, sono previste regole interne cui i membri delle Istituzioni debbono attenersi, secondo un approccio che prende come punto di riferimento le istituzioni come organi di gestione della governance europea, senza l"esigenza di regolamentare i gruppi di interesse. Tale scarsa attenzione comporta il pericolo che il deficit democratico, lungi dall"essere colmato da un trasparente e disciplinato fenomeno, possa invece aggravarsi nell"ipotesi di un accesso incontrollato alle Istituzioni comunitarie da parte dei gruppi di pressione.
5. Osservazioni conclusive.
Fra l"ordinamento degli Stati uniti d"America e l"ordinamento dell"Unione europea vi sono differenze fondamentali, ma anche talune analogie.
La difficoltà di qualificare con esattezza l"Unione europea è dovuta non solo alle sue caratteristiche peculiari, ma anche al fatto che il processo di integrazione europea è ancora in fieri, in divenire. L"impossibilità di operare una vera e propria comparazione tra i due mondi è dovuta soprattutto alla mancanza di sovranità da parte della U.E. e, per le sue attuali caratteristiche, per il deficit democratico e più in generale politico del suo apparato istituzionale.
Attualmente, se si può intravedere una tendenziale convergenza sotto il profilo istituzionale, si segnalano significative divergenze sotto il profilo geo-politico.
Sotto questo profilo, l"Unione europea sta attraversando una vera e propria crisi di identità; per il futuro della U.E. l"identità europea è un fattore decisivo quanto l"assetto istituzionale ([25]). Se è vero che l"identità di un soggetto (sia esso nazionale o federativo) si vede misurandone la capacità di agire in quanto tale (specie verso l"esterno), allora l"U.E. non ha ancora un"identità ben definita con riferimento alle grandi questioni internazionali ([26]).
([1]) Cfr., in generale, K. C. Wheare, On federal government, 1963, tr. it. Del governo federale, Bologna 1993; D.J Elazar, Expolring federalism, 1987, tr. it. Figure e forme del federalismo, Milano, 1998; AA. VV., Stati e federazioni. Interpretazioni del federalismo, Milano, 1998.
([3]) Per una ricostruzione storica sintetica dei precedenti dei progetti europeisti cfr. B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Srell, J. HH Weiler, L"Unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, Bologna, 2001, pag. 14 ss. Per una visione geografica, storica e politica nei suoi molteplici aspetti, si rinvia al saggio di S. Romano, Europa. Storia di un"idea. Dall"Impero all"Unione, Milano, 2004.
Con riferimento a progetti concreti, ricordiamo quello presentato nel 1713 dall"Abate di Saint-Pierre nell"ambito dei negoziati di pace di Utrecht, in cui era prevista la creazione di una lega permanente fra i principi, a garanzia del mantenimento dell"equilibrio delle potenze, e di una sorta di "Senato europeo" con poteri legislativi, esecutivi (oltre che sanzionatori nei confronti dello Stato che avesse violato i patti). Dubbi sulla realizzabilità di tale progetto, se non attraverso una rivoluzione, sarebbero stati espressi da Rousseau nel 1760 (Projet pour la paix perpetuelle en Europe). Cfr., amplius, D. de Rougemont, Vingt-huit siécles d"Europe, Parigi, 1961, pag. 136 ss.
([5]) La crisi economica e politica conseguenza dei due conflitti mondiali fu certamente uno stimolo per la realizzazione di un"unione politica dell"Europa. Già nella seconda metà dell"ottocento, peraltro, l"esigenza di una cooperazione fra gli Stati europei aveva cominciato gradualmente ad emergere sulla base dell"industrializzazione e della necessità di intensificare la collaborazione, a cominciare dai settori tecnici (trasporti, proprietà intellettuale, poste e telegrafi, diritto internazionale privato, ecc.).
Vedi B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Srell, J. HH Weiler, L"Unione europea, cit., pag. 15.
([6]) Nei limiti imposti dalla natura della presente trattazione, appare opportuno ricordare come Roma, che era nata come piccola Città-Stato di agricoltori e pastori guerrieri, diventò la capitale di un vastissimo Impero. L"espansione di Roma e i contatti con altri popoli ponevano il problema della coesistenza di più diritti; in linea di principio l"affermarsi dell"Impero seguì il principio per cui ciascun era soggetto giuridico secondo il diritto della propria civitas. si poneva, inoltre, il problema della disciplina dei rapporti tra cives romani e gli stranieri (peregrini).
L"ordinamento giuridico era venuto caratterizzandosi per una certa elasticità e adattabilità: ad esempio era possibile, in materia di diritto civile, tenere conto dello sviluppo della vita commerciale predisponendo idonei schemi negoziali (oltre ai corrispondenti rimedi processuali). Alle norme più risalenti (le antiche leggi regie, le XII Tavole e lo ius civile) elaborate in origine dalla giurisprudenza (pontificale prima e laica poi) si aggiunsero l"editto dei pretori urbano e peregrino (oltre che dell"edile curule e del governatore della Provincia), che consentivano di risolvere, via via che si presentavano concretamente, i rapporti tra i cittadini romani e fra questi e gli stranieri, mentre il regolamento dei rapporti tra sudditi di ogni Provincia era assicurato mantenendo i diritti locali.
Quando ai successori di Ottaviano Augusto furono conferiti gli stessi poteri che quest"ultimo aveva ottenuto dopo la battaglia d"Azio del 31 A.C., l"ordinamento assunse la forma del principato: le deliberazioni del Senato persero sempre più importanza, mentre assunse un ruolo rilevante l"apparato burocratico centrale (la cancelleria imperiale, i praefecti, i curatores) e quella periferica (legati, procuratores). Durante questa fase l"elaborazione dei giuristi ordinò sistematicamente le materie. Nuove fonti di diritto, le Costituzioni imperiali e i senatoconsulti furono oggetto di opere di commento, successivamente utilizzate da Giustiniano nella sua compilazione. Quando nel 212 D.C. Caracalla estese la cittadinanza a tutti i sudditi dell"Impero, fu necessario operare riassunti di opere istituzionali e raccolte di Costituzioni imperiali.
Cfr., ex multis, T. Beyer, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Filadelfia, 1953;; E. Genzmer, Il diritto romano come fattore della civiltà romana, Roma, 1956; F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, Firenze, 1968; L. Almirante, Una storia giuridica di Roma, Napoli, 1991; tra le opere di carattere istituzionale, P. Bonfante, Storia del diritto romano, Milano, 1959; A. Guarino, Storia del diritto romano, Milano, 1963;G. Grosso, Storia del diritto romano, Torino, 1965; A Burdese, Manuale di diritto pubblico romano, Torino.
([7]) L"origine del Sacro Romano Impero si deve ricondurre all"incoronazione di Carlo Magno a Roma da parte di Leone III nell"anno 800 D.C. I poteri dell"imperatore, così come i confini dell"Impero stesso variarono nei secoli, e la stessa connotazione politico-religiosa, con alterne vicende, finì per tramontare con la crescita degli Stati nazionali. Il conflitto tra Impero e Papato, la questione della supremazia di un potere sull"altro venne trattata anche dallo stesso Dante nel De monarchia.
Vedi, amplius, P. Brezzi, Roma e l"impero medievale, Roma, 1947; R. Folz, L"idée d"empire en Occident du V au XIV siècle, Parigi, 1953; J. F. Lemarignier, Dall"Impero di Roma all"Impero di Carlo Magno, Roma, 1987.
([8]) Nell"ambito del diritto civile, il Codice napoleonico del 1804 rappresenta l"opera di codificazione più significativa e importante dell"età moderna. Al suo modello si ispirò tra l"altro il Codice civile unitario italiano del 1865.
Vedi, ex multis, A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2000, pag. 19, nonché F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2000, pag. 25.
Nel settore penalistico, basti in questa sede ricordare che i principi dell"Illuminismo e l"affermazione dei diritti dell"uomo trovarono il loro culmine nella Rivoluzione francese, e furono sanciti prima nei Codici penali del 1971 e 1975, e poi nel Codice napoleonico del 1910, che trovò applicazione, tra l"altro, in gran parte del territorio italiano.
Cfr., ex multis, F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte Generale, Milano, 2000, pag. 21 ss., nonché Mantovani, Diritto penale, Padova, 2001, pag. 62.
([9]) L"esperienza napoleonica ci ha tramandato un modello di ordinamento razionalizzato, laico, tollerante. Esso era caratterizzato dall"accentramento dei poteri, ma era nello stesso tempo in grado di garantire una sostanziale uguaglianza di trattamento giuridico all"insieme dei territori soggetti alla dominazione francese, per mezzo di un apparato efficiente. Se è innegabile che gli Stati conquistati erano asserviti agli interessi dell"Impero, tuttavia è interessante rilevare come il venir meno di molte barriere doganali interne, l"unificazione di pesi e misure, un"attività tesa a favorire la circolazione delle merci (con la costruzione di strade e porti) e la libera concorrenza (con l"abolizione delle corporazioni), l"estensione del sistema catastale furono elementi di unificazione e modernità dei quali non sarebbe stato, da quel momento in poi, più possibile prescindere. Il superamento della rigidità e delle chiusure municipali e locali anticipò, costituendone le premesse, la nascita di ordinamenti muniti di carattere nazionale (come nel caso dell"Italia, ma anche della confederazione del Reno e della Polonia). Cfr., in argomento, G. Negrelli, L"età moderna, 1991, Palermo, pag. 555 ss.
([10]) Vedi N. Nugent, Governo e politiche dell'Unione europea, Bologna, 1999; B. Olivi, L'Europa difficile. Storia politica dell'integrazione europea, 1948-2000, Bologna 2000.
([11]) Come noto, il progetto era stato elaborato da Jeann Monnet nel 1950, ed era stato successivamente proposto dal ministro degli esteri francese Robert Schuman il 9 maggio 1950. Il Trattato CECA fu firmato a Parigi il 18 aprile 1951 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi ed entrò in vigore il 25 luglio 1952.
Vedi, in proposito, L. Daniele, Diritto dell"unione europea, Milano, 2004, pag. 6 ss., G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2003, pag. 4 ss., B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Srell, J. HH Weiler, L"Unione europea, cit., pag. 15 ss.
([16]) Cfr. ex multis Corte Giust. CE, 29 ottobre 1980, Roquette Frères c. Consiglio, causa 138/79, in Racc., 1979, 3333, nonché Corte Giust. CE, 22 maggio 1990, Parlamento c. Consiglio, causa 70/88, in Racc., 1990, 2041.
([17]) Cfr. Corte Giust. CE, 27 settembre 1988, Grecia c. Consiglio, causa 204/86, in Racc., 1988, 5323.
([18]) Il Trattato fu firmato il 29 ottobre 2004 dai capi di Stato e di governo dei 26 Stati membri e dei 3 paesi candidati, e approvato all"unanimità il 18 giugno 2004. Il Trattato, per entrare in vigore avrebbe dovuto essere ratificato da tutti gli Stati firmatari (secondo i rispettivi procedimenti costituzionali). La Francia e i Paesi Bassi, in virtù dei referendum rispettivamente del 29 maggio e 1 giugno 2005, si espressero per il "no". Cfr. L. Daniele, Costituzione europea e riforma istituzionale dell"Unione, in Dir. Un. Eur., 2006, 1.
([19]) Il Trattato è stato firmato il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri. Ai sensi dell"art. 6, esso dovrà essere ratificato dagli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, ed entrerà in vigore il 1 gennaio 2009, se tutti gli strumenti di ratifica saranno depositati, altrimenti il primo giorno del mese successivo al deposito dell"ultimo strumento di ratifica. L"Irlanda ha respinto la ratifica con referendum popolare del 12 giugno 2008.
([22]) Cfr., in proposito, R. Dehousse, European Institutional architecture after Amsterdam: Parliamentary System or Regulatory structure?, in Common Mark. Law Rev., 1998, 595 ss.
([23]) Si veda G. E. Rusconi, La cittadinanza europea non crea il popolo europeo, Bologna, 1996, 831.
([24]) Vedi S. Panebianco, Il lobbying europeo, Milano, 2001; T. Checcoli, Il fenomeno del lobbying negli Stati uniti e nell"Unione europea, in Quad. cost., 2006, 719 ss.