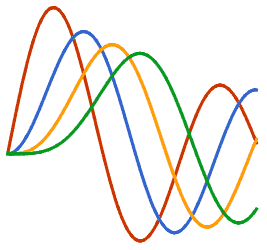- Redazione P&D - 04/01/2014
RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE E I VIZI INCOMPLETI - Cass. 21255/2013 - Natalino SAPONE
1.- Una delle parti più interessanti della sentenza che ha definito la nota controversia Fininvest/Cir - Cass., III sez. civ., 17 settembre 2013, n. 21255, pres. Trifone, rel. Travaglino - è quella che si occupa del rapporto tra violazione della buona fede precontrattuale e vizi del consenso del contratto. La Corte di Cassazione approva esplicitamente la cosiddetta teoria dei vizi incompleti, elaborata da M. Mantovani ("Vizi incompleti" del contratto e rimedio risarcitorio, Torino 1995).
Il ragionamento della Corte muove dalla "ormai pacificamente (benché non univocamente), ammessa proponibilità di un'azione di risarcimento del danno per violazione della regola di buona fede nella fase delle trattative pur in presenza di un contratto valido, e, comunque, in assenza di una domanda di impugnativa del medesimo, perché della stessa non ricorrono (più) i presupposti". Così prosegue la S.C.:
"A carico della parte che abbia callidamente e scorrettamente insidiato l'autonoma determinazione negoziale dell'altra deve, difatti, ritenersi configurabile in via generale una responsabilità risarcitoria anche quando il comportamento contrario a buona fede non sia tale da integrare il paradigma normativo di uno dei vizi del consenso così come disciplinati dal codice civile.
Tali principi hanno trovato recente ed autorevole riscontro nella elaborazione giurisprudenziale di questa stessa Corte, la quale, nel suo massimo consesso (Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), ha ravvisato nell'istituto della responsabilità precontrattuale il rimedio in grado di governare anche le situazioni del contratto valido, ma pregiudizievole per la parte che abbia subito l'altrui comportamento contrario a buona fede nelle trattative e nella formazione del contratto. L'affermazione dell'esperibilità di un'azione risarcitoria in presenza della violazione della regola di buona fede nelle trattative che dia luogo ad un assetto contrattuale più svantaggioso per la parte che abbia subito le conseguenze della condotta contraria a buona fede è stata ancora riaffermata funditus da questa Corte con la sentenza dell'8 ottobre 2008, n. 24795, pur a fronte di pronunce (non condivisibilmente) discordanti, che sono (acriticamente) tornate a sostenere la tesi classica della non esperibilità del rimedio della responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto validamente concluso (Cass. civ., 25 luglio 2006, n. 16937; Cass. civ., 5 febbraio 2007, n. 2479) (…)
Non ignora il collegio che la teoria predicativa della risarcibilità aquiliana tutte le volte che un vizio negoziale non assurga a rango di rilievo tale da consentirne l'invalidazione (la teoria dei c.d. "vizi incompleti", che consente un'azione imperniata sulla contrarietà a buona fede della condotta della controparte contrattuale pure in presenza di un contratto valido) sia stata oggetto di serrate critiche dottrinali. Sotto un primo profilo, si è difatti affermato che la debolezza della teoria si coglie già alla luce del rilievo che il concetto richiederebbe l'indicazione di un criterio di selezione cui affidare la decisione in ordine alla rilevanza o meno, sia pure ai soli fini risarcitoli, della alterazione della libertà negoziale che sia stata posta in essere - mentre, una volta abbandonato l'aggancio ai requisiti di rilevanza dei vizi del consenso, così come normativamente disciplinati, diverrebbe difficile se non impossibile individuare un "grado" o intensità dell'alterazione della libertà del volere, superato il quale (possa e) debba scattare, in presenza di tutti gli altri presupposti, il rimedio risarcitorio. Sarebbe, allora, significativo che l'unico limite che la dottrina dei vizi incompleti pone sia quello della entità del pregiudizio, così da escludere o contenere la pretesa risarcitoria nei casi in cui il danno conseguito all'altrui scorrettezza precontrattuale sia irrisorio o comunque di esigua entità, alla luce del valore economico complessivo dello scambio; ma si tratterebbe di un limite, per un verso, arbitrario, posto che l'entità del danno potrebbe semmai incidere sul quantum dell'obbligazione risarcitoria, ma non sull'affermazione, o meno, della sussistenza della responsabilità e, per altro verso, tale da introdurre un meccanismo di controllo generale circa il contenuto delle convenzioni private, difficilmente giustificabile. In questo modo, si finirebbe per generalizzare, a partire dalla disposizione dell'art. 1337 c.c., la possibilità di un controllo del contenuto contrattuale in funzione di scrutinio in ordine all'eventuale squilibrio che lo caratterizzi, ciò che, al contrario, l'ordinamento prevedrebbe solo in casi oggetto di specifiche previsioni normative - onde la conclusione secondo la quale un uso poco controllato della clausola generale di buona fede (dimentico della necessità che i risultati della "concretizzazione" di una clausola generale, per essere ragionevoli, devono - prima di tutto - essere coerenti con il sistema del diritto positivo) rischierebbe di risolversi in una fuga in avanti dell'interprete, dagli esiti "sistematicamente" discutibili. Sotto altro profilo, si è sottolineata l'erroneità, alla luce delle stesse indicazioni desumibili dalla Relazione al codice, già del presupposto generale da cui muove l'estensione del dispositivo risarcitorio dell'art. 1440 a tutte le altre ipotesi di "vizi incompleti", presupposto secondo il quale il legislatore avrebbe ricordato la distinzione tra vizio determinante e vizio incidente solo quando ha trattato del dolo, omettendo, invece, di disciplinarla negli altri casi, e spettando così all'interprete colmare tutti gli spazi lasciati vuoti dalla regola di validità. Ciò che fuoriesce dai mezzi di impugnazione, difatti, non sarebbe necessariamente un vuoto normativo che "deve" essere colmato attraverso un rimedio aquiliano concepito come "cerotto universale" di qualsiasi insoddisfazione equitativa, poichè, al contrario, le condizioni normative delle diverse ipotesi di invalidità sono rivolte a definire intenzionali ambiti di immunità la cui evidente funzione giuridica è quella di dar rilevanza ad esigenze sistematiche di carattere diverso rispetto a (ed opposto a) quelle che prendono corpo nelle discipline dei mezzi di impugnazione (diverse ed opposte esigenze che vengono solitamente riassunte nella necessità di assicurare stabilità ed efficienza al sistema dei contratti). Dal punto di vista delle disposizioni normative che concernono l'errore, la violenza e l'approfittamento dell'altrui stato di bisogno, sembrano ricavarsi indicazioni addirittura contrarie ad una tale espansione del dispositivo risarcitorio alle ipotesi in cui questi vizi presentino carattere incompleto o solo incidente, tanto più alla luce del rilievo che l'affermazione della rilevanza, ai fini risarcitoli, di un errore incompleto sarebbe in grado di entrare in collisione con l'affermazione del principio di irrilevanza dell'errore dei motivi.
Tali osservazioni critiche, se colgono con non poca efficacia alcuni aspetti sicuramente critici della teoria dei vizi incompleti, non inducono comunque a negare - in consonanza con quanto di recente affermato da altra, autorevole dottrina - l'esistenza di un residuo spazio che offra asilo ad una domanda risarcitoria per violazione dell'obbligo di buona fede anche nelle ipotesi in cui la parte, vittima dell'altrui condotta sleale, non possa esperire le impugnative contrattuali accordatele dalla disciplina generale dei contratti ovvero da quella peculiare al singolo tipo contrattuale (così come accade appunto, in materia di transazione). Di uno spazio residuo che, a più forte ragione, consenta la proposizione di una domanda risarcitoria ex art. 2043 volta che la fattispecie concreta si caratterizzi per un quid pluris e per un quid alii rispetto ad una "semplice" violazione della norma di cui all'art. 1337 c.c.. Come è stato efficacemente osservato, tale forma di responsabilità è espressiva della dimensione funzionale del rapporto, e non può integrare, a guisa di norma di chiusura, il sistema delle invalidità negoziali che ne investe invece la logica strutturale. Le regole di comportamento sono disciplina non di fattispecie ma di rapporto, non attengono al fatto rilevante per i terzi e l'ordinamento, ma alla vicenda obbligatoria che intercorre(rà) tra le parti. Il rapporto obbligatorio precede e segue l'integrazione della vicenda negoziale - intesa nella sua duplice dimensione di fatto storico e di fattispecie programmatica - ed è intergrato nella sua più intima essenza da doveri di comportamento che trovano la loro fonte tanto nel sistema della responsabilità contrattuale quanto in quello della responsabilità precontrattuale, quanto ancora, se del caso, in quella extracontrattuale: queste ultime, pur in presenza di un contratto valido, non sono necessariamente destinata a "compensare" eventuali lacune di sistema delle regole di validità, ma appaiono piuttosto funzionali a governare secondo buona fede i differenti aspetti della complessa vicenda interpersonale dipanatasi tra le parti, così operando nella (diversa e più ampia) logica del rapporto e della (complessità della) fattispecie. Di qui, la legittima predicabilità di un rimedio risarcitorio per responsabilità che ricada nella relazione antecedente la conclusione dell'affare. Un rimedio che non si pone, di per sè, in contrasto con le pur necessarie esigenze di certezze e di stabilità dei rapporti giuridici.
La preoccupazione sottesa all'affermazione di un autonomo spazio della buona fede come fonte di un rimedio risarcitorio a fronte di condotte sleali nella fase delle trattative - che possa inopinatamente indurre ad una sorta di controllo generalizzata o di revisione a posteriori, da parte del giudice, dei termini dello scambio - appare, per altro verso, quanto meno recessiva (oltreché improntata ad una romantica visione del contratto ormai appartenente a passate "età dell'oro") rispetto a casi nei quali la violazione della buona fede non consista, semplicemente, nel non avere messo a disposizione della controparte informazioni sulla convenienza dell'affare che quest'ultima avrebbe in ipotesi potuto procurarsi altrimenti, bensì nell'avere (come nella specie) intollerabilmente alterato i presupposti della trattativa precontrattuale attraverso la commissione di un illecito penale di ineffabile gravità (ciò che costituisce il quid pluris destinato a schiudere le porte alla risarcibilità ex art. 2043 c.c.). E appare oltretutto contraddetta da quanto affermato, proprio in tema di controllo del contenuto negoziale dalle stesse sezioni unite di questa Corte in tema di clausola penale manifestamente eccessiva, come tale ritenuta rilevabile ex officio da parte del giudice pur in assenza di un'eccezione di parte (Cass. ss. uu. 18128/2005).
Non si intende, in tal guisa, trasformate tale controllo, e la correlata risarcibilità autonoma, in una sorta di giusnaturalistico riconoscimento della legittimità di un danno di carattere punitivo (la cui sussistenza troverebbe, in astratto, fonte e ragione nel fatto che l'esigenza di assicurare il valore della stabilità e dell'efficienza delle contrattazioni sarebbe evidentemente recessiva in presenza di condotte di eccezionale gravità dal punto di vista della contrarietà a norme penali e, dunque, qualificate soggettivamente da un dolo di intollerabile e irredimibile intensità)".
2.- Nel ragionamento della Suprema Corte sono ravvisabili alcuni punti deboli.
La Corte sembra confutare le critiche alla teoria dei vizi incompleti in ragione della distinzione tra regole di comportamento, tra cui vi è quella di buona fede precontrattuale, e regole di validità. Le prime, dice la S.C., " sono disciplina non di fattispecie ma di rapporto, non attengono al fatto rilevante per i terzi e l'ordinamento, ma alla vicenda obbligatoria che intercorre(rà) tra le parti. Il rapporto obbligatorio precede segue l'integrazione della vicenda negoziale - intesa nella sua duplice dimensione di fatto storico e di fattispecie programmatica (…)".
Insomma, responsabilità risarcitoria per violazione della buona fede contrattuale e disciplina dei vizi del consenso non entrano in collisione in ragione del principio di non interferenza tra regole di comportamento e regole di validità. I due tipi di regole operano su piani diversi e distinti. Ecco perché vi può essere risarcimento del danno anche in presenza di contratto valido. Tale ragionamento però appare in contraddizione con l'assunto della Corte secondo cui per la risarcibilità ex art. 2043 c.c. occorre un quid pluris e un "quid alii rispetto ad una "semplice" violazione della norma di cui all'art. 1337 c.c.". Nel caso di specie tale presupposto è ravvisato nella sussistenza di un illecito penale "di ineffabile gravità (ciò che costituisce il quid pluris destinato a schiudere le porte alla risarcibilità ex art. 2043 c.c.)".
La contraddizione risiede nel fatto che, se responsabilità per violazione di buona fede precontrattuale e regole di validità sono tra loro conciliabili in virtù del principio di non interferenza, allora non si vede perché, ai fini del risarcimento per violazione di buona fede precontrattuale, occorra un quid pluris e quid alii rispetto alla "semplice" violazione della buona fede medesima. Se buona fede e regole di validità non si incontrano, allora basta la semplice violazione della buona fede per dare adito al risarcimento. Se invece si richiede un quid pluris, richiedendo una particolare qualificazione della scorrettezza precontrattuale, evidentemente si fa reagire la disciplina dei vizi del consenso sul piano della risarcibilità del danno.
La debolezza del ragionamento della S.C. appare ancor più evidente dato che la pronuncia non spiega in che cosa consista questo quid pluris e quid alii rispetto alla "semplice" violazione della buona fede. Facendo così, incorre in una delle critiche dottrinali sollevate nei confronti della teoria dei vizi incompleti (G. D"Amico, La responsabilità, in Trattato del contratto, diretto da V. Roppo, vol. 5, Rimedi, Milano 2007, 1007), secondo cui, una volta abbandonato l'aggancio ai requisiti di rilevanza dei vizi del consenso, così come normativamente disciplinati, diviene difficile se non impossibile individuare il grado o intensità dell'alterazione della libertà del volere, superato il quale possa scattare il rimedio risarcitorio. Critiche richiamate in sentenza e della cui serietà la S.C. si mostra pienamente consapevole.
3.- Se comunque il principio enunciato dalla sentenza in commento sarà confermato, sarà necessario precisare in cosa consista questo quid pluris rispetto alla semplice violazione della buona fede. Una possibile soluzione potrebbe essere rinvenuta facendo leva sul disposto dell'art. 1440 codice civile, che disciplina il dolo incidente. Si potrebbe cioè assumere il dolo incidente quale figura paradigmatica della possibilità di coordinamento tra buona fede e regole di validità contrattuale, ossia della possibilità di configurare un danno risarcibile per violazione della buona fede pur in presenza di un contratto valido. La soluzione sarebbe quella di configurare accanto al dolo incidente, anche l'errore incidente e la violenza incidente. In sostanza dalla categoria dei vizi incompleti si passerebbe a quella dei vizi incidenti.
Questa soluzione potrebbe superare la critica fondata sull'impossibilità di individuare un grado o intensità dell'alterazione della libertà negoziale necessari e sufficienti per il rimedio risarcitorio. Insomma secondo questa impostazione, occorre che il comportamento scorretto integri gli estremi dei vizi del consenso normativamente previsti, salvo solo il carattere determinante. Quindi la violenza dovrebbe rivestire i connotati previsti dal codice civile, solo che difetterebbe del requisito del carattere determinante. Medesimo discorso varrebbe per l"errore. Sarebbe il principio di buona fede a consentire l'estensione analogica della previsione sul dolo incidente anche alle altre ipotesi, autorizzando il rinvenimento della eadem ratio nella violazione della buona fede precontrattuale.
4.- Un altro punto debole della sentenza in commento lo si può ravvisare nella configurazione del danno risarcibile. La Corte di Cassazione rinviene il danno-conseguenza nella transazione stipulata a diverse e pregiudizievoli condizioni. Anche tale profilo appare incoerente rispetto al principio di non interferenza tra buona fede – regola di comportamento, quindi espressiva della logica del rapporto – e regole di validità, espressive della logica della fattispecie. Vale a dire dal punto di vista delle regole di comportamento, qual è la buona fede, il contratto rileva come fatto storico generatore del danno. Sul piano invece delle regole di validità, il contratto rileva come fattispecie programmatica. Far consistere però la conseguenza dannosa della violazione della buona fede precontrattuale nelle diverse e pregiudizievoli condizioni contrattuali tra le medesime parti del contratto, significa far rilevare il contratto - ai fini anche del risarcimento del danno - non più solo come fatto storico ma anche come fattispecie programmatica.
Per evitare questa ambiguità, occorre che il contratto rilevi solo come fatto storico; ciò significa che la stipulazione del contratto rileva solo come evento che determina la perdita di occasioni contrattuali alternative. Quindi la conseguenza dannosa consiste nelle diverse e più favorevoli condizioni del contratto che si sarebbe stipulato, ma non con il medesimo soggetto che ha posto in essere la scorrettezza precontrattuale, bensì con altro soggetto terzo. Il che implica la necessità, ai fini del risarcimento, di provare tali occasioni negoziali alternative. Se invece si fa consistere il danno nella diversità tra le condizioni del contratto effettivamente stipulato e quelle che sarebbero state concordate tra le medesime parti, si rischia di far rientrare dalla finestra risarcitoria ciò che si è fatto uscire dalla porta del principio di non interferenza. Significa dare rilievo, anche ai fini risarcitori, al contratto/regolamento e non solo al contratto/fatto.