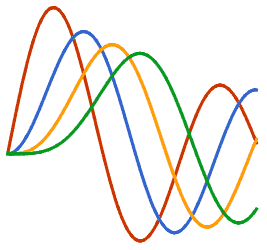- Redazione P&D - 06/11/2008
ILLECITO PENALE E ILLECITO CIVILE: AFFINITA' E DIFFERENZE - Riccardo MAZZON
L’illecito civile e l’illecito penale nascono, storicamente, finalizzati al conseguimento di scopi ben distinti: mentre, invero, il primo è perseguito dall’ordinamento con l’intento di riparazione complessiva del danno subito da interessi privati, il secondo individua violazioni dell’ordine generale di tale gravità da richiedere un intervento statale diretto alla punizione del colpevole.
“Il fallimento delle teorie che sono state enunciate per distinguere il torto penale da quello civile, induce a concludere che una diversità sostanziale non esiste. La distinzione è puramente estrinseca e legale: il reato è il torto sanzionato mediante la pena; l’illecito civile è quello che ha per conseguenza le sanzioni civili (risarcimento, restituzioni, ecc.). Insomma, è la natura della sancito jutis quella che consente di stabilire se ci troviamo di fronte all’una o all’altra specie di torto. Ciò non significa che la distinzione dipenda esclusivamente dall’arbitrio del legislatore. La scelta della sanzione, infatti, non avviene per puro capriccio, ma in base al criterio che più sopra abbiamo enunciato: la pena, essendo una sanzione onerosa anche per la comunità sociale, non viene adottata, se non quando i reggitori dello Stato ritengono che non se ne possa fare a meno; mentre, come già osservato, rispetto al risarcimento del danno essa presenta i caratteri della personalità, della necessaria determinatezza del precetto e della riserva di legge”.
F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffrè 2000
Naturalmente, si danno ipotesi fattuali concrete, quale ad esempio, in via eclatatante e generale, l’omicidio, ove lo Stato riscontra l’esigenza di tutelare entrambi gli interessi, sia quello eminentemente pubblico e diretto alla punizione del colpevole (funzione sanzionatoria del diritto penale), sia quello meramente privatistico e diretto all’ottenimento del risarcimento (funzione reintegratoria e riparatoria del diritto civile):
“In tema di danno biologico, richiesto "iure hereditatis" (ma il discorso è identico per la richiesta di danno da perdita del diritto alla vita, detto anche danno tanatologico), la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi, non rilevando in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere”.
Cassazione civile , sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632 Dalla Costa e altro c. Soc. Ras assicur. Giur. it. 2004, 495 nota BONA
Se l’illecito civile è normativamente previsto agli art. 2043 e 1218 c.c. e implica, in entrambi i casi, responsabilità civile (responsabilità extracontrattuale nel caso dell’art. 2043 c.c.; responsabilità contrattuale, per inadempimento o ritardata esecuzione, nel caso dell’art. 1218 c.c.), l’illecito penale è, al contrario, soggetto al c.d. principio di legalità, sicchè nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge (art. 1 c.p.).
“Il principio di stretta legalità vigente in diritto penale impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma incriminatrice, senza indulgere a interpretazioni analogiche e, ove la norma del tutto chiara non sia, di attenersi all'interpretazione giurisprudenziale imperante, che la abbia esplicitata, ad evitare diverse interpretazioni che espongano il cittadino a responsabilità di maggior contenuto a quelle cui il cittadino medesimo, in base al principio di cui all'art. 1 c.p., era espressamente chiamato dalla norma incriminatrice e dalla giurisprudenza al riguardo. (Nella specie relativa ad annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato di sentenza di condanna per avere l'imputato effettuato scarichi dai servizi civili, in un fosso adiacente alla propria fabbrica senza avere richiesto la prescritta autorizzazione, la s.c. ha osservato che la coincidenza dell'epoca dell'accertamento dello scarico con quella del mutamento della giurisprudenza imperante, che non richiedeva l'autorizzazione, avrebbe imposto come soluzione obbligata l'assoluzione dell'imputato, la quale, oltreché, dettata dall'art. 5 c.p. nella lettura fattane dalla corte costituzionale, è suggerita prima ancora, dal principio di stretta legalità)”.
Cassazione penale , sez. III, 06 ottobre 1993 Garofoli Mass. pen. cass. 1994, fasc. 6, 63 Giust. pen. 1995, II, 43
In ossequio ai diversi obiettivi perseguiti, è assolutamente pacifico e noto come possano aversi reati (e quindi illeciti penali) non implicanti illecito civile, così come esistano svariate ipotesi di responsabilità civile non previste dalla legge quali reati; per contro, spesso una stessa fattispecie viene a costituire illecito sia civile che penale, pur mantenendo ognuna delle due connotazioni giuridiche la propria autonomia:
“La revoca della sentenza di condanna perabolitio criminis(art. 2 comma 2 c.p.) - conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto - non comporta il venir meno della natura di illecito civile del medesimo fatto, con la conseguenza che la sentenza non deve essere revocata relativamente alle statuizioni civili derivanti da reato, le quali continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata”.
Cassazione penale , sez. V, 20 dicembre 2005, n. 4266 CED Cass. pen. 2006, 233598
Pur operando in settori alquanto differenti, ambito civile per l’illecito civile, ambito penale per l’illecito penale, i due istituti condividono, peraltro, la struttura (tripartita) che li caratterizza: entrambi possono esser, infatti, ontologicamente scomposti in fatto materiale (od oggettivo: nel diritto penale, il c.d. fatto tipico), antigiuridicità e colpevolezza.
“Modernamente si usa distinguere nell’analisi dell’atto illecito il fatto materiale, l’antigiuridicità e la colpevolezza…”
A. Trabucchi, Istituzioni di Diritto Civile, Cedam 2006
“La teoria tripartita succede storicamente alla teoria bipartita classica. Sviluppatasi in Germania all’inizio del secolo, fu recepita in Italia negli anni trenta (soprattutto ad opera di G. Delitalia). Essa distingue nel reato tre componenti fondamentali: il fatto tipico, l’antigiuridicità obiettiva e la colpevolezza”.
T. Padovani, Diritto Penale, Giuffrè 2006
L’evidente similitudine strutturale permette all’interprete (sul punto, sia permesso rinviare al volume: Riccardo Mazzon, “Responsabilità nel danno da circolazione stradale”, Maggioli 2008) di chiedersi se i tre elementi che compongono i due diversi illeciti siano suscettibili di sovrapposizione in identici paradigmi giuridici; se, cioè, il fatto materiale componente l’illecito civile possa esser spiegato ricorrendo alla teoria del fatto tipico elemento del reato; se la colpevolezza sia un unico concetto utilizzabile sia in ambito di illecito civile che in ambito di illecito penale; se l’antigiuridicità civilistica coincida o meno (ed, eventualmente, in che termini) con l’antigiuridicità obiettiva di penalistica matrice. Un tanto, ovviamente, senza voler affermare identità di istituti, bensì, al contrario, con la consapevolezza degli ontologici motivi di difformità, naturalmente conseguenti alle diverse finalità perseguite dai due tipi di illecito; si pensi, soprattutto, alla tipicità che contraddistingue l’illecito penale e alla struttura, all’opposto, atipica, che contraddistingue il neminem laedere civilistico:
“L'art. 2043 c.c. non presuppone la commissione di un illecito penale o tipizzato per valutare una condotta che abbia provocato un danno ingiusto, ma si accontenta di una valutazione complessiva della portata lesiva della condotta che si assume negligente (in quanto non conforme a norme, regolamenti, e regole deontologiche e/o di buona fede contrattuale) tenuta dall'agente, essendo esso un illecito a struttura atipica, posto a garanzia del principio solidaristico del "neminem laedere", per il quale non prevalgono le garanzie insite nell'ordinamento penale ai fini della prova della colpevolezza, ma s'impone solo la produzione di una prova rigorosa degli elementi posti a fondamento della domanda risarcitoria in capo a chi assume di avere ricevuto un danno ingiusto per un altrui fatto colposo o doloso”.
Tribunale Milano, 14 febbraio 2004 Matteini e altro c. Banca Intesa e altro Giur. milanese 2004, 155