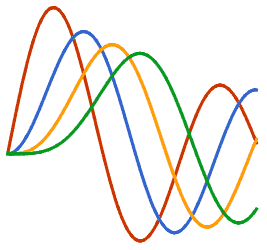Malpractice medica - Redazione P&D - 13/04/2023
Il consenso informato tra lex artis e causa di giustificazione - Cecilia De Luca
La professione medica si caratterizza, oltre che per l’elevato valore etico e sociale, anche per l’idoneità ad integrare fattispecie illecite, essendo destinata a realizzarsi sulla persona. Non a caso, infatti, a fronte della tesi secondo cui le prestazioni sanitaria sono in sé lecite, purché eseguite con l’osservanza delle regole tecniche, da più parti si è sostenuto che la liceità dell’attività medica è subordinata alla presenza di una causa di giustificazione. Si tratta della vexata quaestio del fondamento di liceità dell’attività medica, specie chirurgica, ed in particolare, ai fini che qui interessano, del problema se il consenso informato – la cui natura, come già è stato sottolineato, risulta anfibia – si identifichi nella causa di giustificazione prevista dall’articolo 50 c.p. oppure rappresenti una delle leges artis cui il professionista deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Il fondamento della liceità della pratica medica ha una propria ed autonoma rilevanza pratica ed euristica. Infatti, sostenere che la prestazione medica sulla persona, specie se chirurgica, costituisce un fatto illecito, e che quindi il professionista, per non incorrere in responsabilità, deve munirsi del consenso del paziente o comunque accertarsi della sussistenza di altra causa di giustificazione, significa affermare che tale attività è in sé illecita, come lo è, usando un’espressione simbolica, la condotta dell’aggressore “armato di coltello”. Conseguentemente, la responsabilità del medico dovrebbe essere dichiarata in virtù della prova dell’esecuzione dell’intervento, demandando al professionista la prova della sussistenza di una scriminante, proprio come avviene per l’ “accoltellatore”, che può evitare di essere condannato solo se dimostra la sussistenza di una causa di giustificazione, solitamente la legittima difesa. Diversamente, se si sostiene che ogni trattamento sanitario sia in sé lecito, in quanto attività riconosciuta e disciplinata dall’ordinamento, la mera esecuzione dell’intervento chirurgico non può essere di per sé fonte di responsabilità. Ne deriva che, per addivenire ad una sentenza di condanna, il p.m. o l’attore in sede civile devono dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità. Secondo un orientamento consolidato, il consenso informato non ha efficacia scriminante, e quindi non può rientrare nell’art. 50 c.p., perché l’attività sanitaria trova il fondamento della propria liceità nell’esimente dell’esercizio del diritto ex art. 51 c.p. Nell’ambito di questa categoria, infatti, il concetto di diritto deve essere inteso nella sua massima estensione, in quanto, se la legge ha valutato un determinato comportamento come conforme ad un interesse meritevole di tutela, il “principio di non contraddizione” impone di non sanzionarlo penalmente perché autorizzato dall’ordinamento giuridico: ciò, a prescindere dall’origine strettamente legislativa oppure interpretativa di tale autorizzazione. Su questa base è agevole inquadrare l’attività sanitaria nell’ambito dell’esercizio di un diritto, in quanto le prestazioni di carattere medico-sanitario sono autorizzate dall’ordinamento giuridico, che, anzi, obbliga il Servizio Sanitario Nazionale ad erogarle. Tuttavia, in senso contrario, è stato rilevato che, per quanto riguarda i trattamenti sanitari, il problema non è di giustificare il comportamento del professionista in astratto, bensì le attività che egli pone in essere. Di conseguenza, il criterio di legittimazione deve essere rintracciato nel consenso. Altro orientamento dottrinale sostiene che la volontà del paziente di sottoporsi al trattamento sanitario è una scriminante sui generis, non codificata, diversa dal consenso dell’avente diritto sotto un profilo sostanziale. Nell’ambito dell’art. 50 c.p., infatti, il soggetto dispone del proprio diritto in modo insindacabile, potendo scegliere di privilegiare il capriccio anche a discapito di interessi pubblici rilevanti mentre esorbita da quest’istituto, anche qualora siano in gioco solo interessi disponibili, ogni volta che l’effetto scriminante è in funzione di valori collettivi, come appunto accade nell’attività medico-chirurgica, alla quale il paziente acconsente per ottenere un miglioramento delle proprie condizioni di salute, la quale, oltre che suo diritto, è interesse della collettività ex art. 32 Cost. In altri termini, secondo questa tesi, la scelta del paziente di accettare il trattamento, costituendo atto dispositivo di un interesse pubblico, esula dalla previsione dell’art. 50 c.p. il quale, riferendosi solo a diritti, ammette che il consenso alla loro lesione o messa in pericolo sia prestato arbitrariamente e senza controlli. In senso contrario, è possibile rilevare che l’art. 50 c.p., riferendosi ad ogni lesione o messa in pericolo, ha un ambito di applicazione generale che trova necessaria specificazione nell’art. 5 c.c. Da quest’ultima disposizione si evince che la presenza dell’interesse collettivo connesso alla tutela della salute riduce l’area della disponibilità dell’integrità fisica, subordinandola ad una diminuzione non permanente di questo bene, nonché al rispetto della legge ed alla conformità all’ordine pubblico ed al buon costume, ma non compromette l’insindacabilità delle scelte relative al proprio corpo che rientrino nell’area disponibile in quanto rispondenti ai requisiti contenuti nell’art. 5 c.c. Ciò è tanto più evidente se si considera il fenomeno dei tatuaggi e dei piercing, mode che si sono dimostrate potenzialmente pericolose per la salute e che quindi, secondo la tesi criticata, richiederebbero, un consenso non insindacabile in quanto prestato in funzione di un interesse pubblico, ma che invece, sicuramente restano consentite finché non oltrepassino i limiti di cui all’art. 5 c.c. Altra critica alla tesi che attribuisce al consenso informato natura di scriminante è stata individuata nel rapporto tra l’art. 50 c.p. e l’art. 5 c.c. In proposito, poiché l’art. 50 c.p. si riferisce solo ai diritti di cui il consenziente può disporre e l’art. 5 c.c. vieta “gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica”, se si identificasse il consenso del paziente con la causa di giustificazione dell’art. 50 c.p. la sua efficacia scriminante sarebbe limitata solo agli interventi chirurgici che non riducono in modo permanente l’integrità fisica. Conseguentemente rimarrebbero nell’area dell’illecito proprio quelle operazioni che, per la loro idoneità ad incidere irrimediabilmente sull’integrità fisica, si presentano più delicate sotto il profilo della responsabilità professionale. Tuttavia, in senso contrario, il divieto contenuto nell’art. 5 c.c. non sembra applicabile agli atti di disposizione del proprio corpo a scopo terapeutico. Infatti, la rilevanza costituzionale del diritto alla salute induce a ritenere valido il consenso a trattamenti terapeutici che comportano un sacrificio per l’integrità fisica; altrimenti per salvaguardare tale bene si pregiudicherebbe il diritto di curarsi, con evidente fraintendimento della ratio dello stesso art. 5 c.c. Pertanto, è parso utile dare del concetto di integrità ex art. 5 c.c. una lettura non limitata alla sola integrità anatomica, ma comprensiva anche del profilo funzionale. Del resto, anche la Corte Costituzionale ha affermato la liceità di tutti gli atti di disposizione del proprio corpo, se finalizzati alla tutela della salute. Secondo altra autorevole dottrina, anche a voler accogliere la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 5 c.c, in relazione all’art. 32 Cost., secondo la quale l’atto di disposizione della propria integrità fisica è valido anche quando ne cagioni la diminuzione permanente, purché determini nel complesso un beneficio per la salute della persona, questa interpretazione non vale a dimostrare che il consenso informato rappresenti la causa di giustificazione dell’art. 50 c.p. e quindi sia il fondamento di liceità del trattamento medico. Infatti, l’infondatezza della tesi che attribuisce efficacia scriminante al consenso del paziente si ricava sia dall’esistenza di trattamenti sanitari considerati obbligatori ex lege, sia dalla indiscussa liceità dell’intervento eseguito su paziente incapace di intendere e di volere, e quindi di consentire, anche a prescindere dalla sussistenza di uno stato di necessità. Il primo di questi argomenti, secondo cui il consenso del paziente non costituisce fondamento di liceità dell’attività medica perché esistono trattamenti che possono lecitamente essere eseguiti senza consenso, in quanto imposti come obbligatori dalla legge, non sembra confutare la tesi che considera leciti i trattamenti sanitari solo in presenza di una causa di giustificazione, quale, appunto, il consenso dell’avente diritto, ma anche lo stato di necessità e l’adempimento del dovere. Infatti poiché i trattamenti sanitari obbligatori possono rientrare nell’esimente dell’adempimento del dovere ex art. 51 c.p., la loro esistenza non sembra sufficiente ad affermare con certezza che i trattamenti sanitari siano leciti anche in mancanza di cause di giustificazione. Altrettanto controvertibile appare la rilevanza del secondo argomento, relativo alla liceità dell’intervento senza consenso su paziente incapace di intendere e di volere. Infatti, questa tesi troverebbe una smentita, nella Convenzione d’Oviedo, la quale stabilisce all’art. 6 che il medico deve acquisire il consenso del legale rappresentante del paziente anche quando quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere. Conseguentemente, tale articolo appare compatibile con la tesi dell’illiceità in sé del trattamento medico, la quale può essere scriminata attraverso l’acquisizione del consenso informato del paziente o del suo legale rappresentante. Dunque, per una più solida confutazione della tesi del consenso come causa di giustificazione, è necessario dimostrare che le pratiche diagnostiche e terapeutiche, anche chirurgiche, siano in sé lecite. A tal fine, un solido referente normativo sembra rintracciabile nell’art. 9 Cost., ai sensi del quale “la Repubblica promuove (…) la ricerca scientifica”. Essendo difficilmente contestabile che nell’ambito della ricerca scientifica rientrino le attività di sperimentazione clinica, il riconoscimento costituzionale dell’art. 9 Cost. sembra coinvolgere anche tali prestazioni mediche. Conseguentemente, se è intrinsecamente lecita l’attività di sperimentazione clinica, perché riconosciuta e favorita al più alto livello del nostro ordinamento, appare illogico ritenere che siano, all’opposto, intrinsecamente illecite tutte le altre prestazioni mediche che sono la benefica conseguenza delle sperimentazioni. Tale conclusione trova conforto nell’art. 47 del vigente codice deontologico. Del resto, in tema di rilevanza pratica, se il consenso del paziente fosse una causa di giustificazione, non codificata oppure rientrante nell’art 50 c.p., e quindi discriminasse l’intrinseca illiceità delle prestazioni mediche, ogni trattamento sanitario costituirebbe un fatto illecito, e quindi la prova del consenso informato del malato sarebbe necessaria al medico per evitare una condanna certa, avendo posto in essere una condotta rientrante nell’area dell’antigiuridicità. Tuttavia, questa necessaria conclusione appare smentita dal nostro ordinamento e dalla pratica giudiziaria, dove né il p.m., né l’attore contestano la mera esecuzione dell’intervento, bensì chiedono la condanna del medico per aver effettuato un intervento senza valido consenso informato. Difatti, almeno in sede penale, non è il medico a dover dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di informazione, bensì è l’accusa a dover fornire la prova della mancanza o l’invalidità del consenso del paziente. In sede civile, invece, pur essendo controversa la questione dell’onere della prova, la tesi che pone in capo al medico l’onere di dimostrare di aver acquisito dal paziente un valido consenso basa questa conclusione solo sul criterio di vicinanza dell’onere della prova, e non certo sull’intrinseca illiceità del trattamento medico. In altri termini, nella responsabilità professionale, il consenso del paziente non è un elemento estraneo all’addebito di responsabilità civile o penale. Al contrario, la mancanza del consenso è interna e coessenziale alla responsabilità del medico, al punto che sia il p.m., sia l’attore la allegano a fondamento delle rispettive domande e si curano di fornirne la prova. Dunque non è il consenso del paziente a rendere lecita una condotta intrinsecamente illecita, bensì è la mancanza del consenso a rendere illecito il trattamento sanitario, che, in quanto espressione di un’attività autorizzata e disciplinata dall’ordinamento, non può che essere lecito finché non si risolva nella violazione di una delle leges artis cui l’ordinamento subordina il corretto esercizio della professione, e tra le quali è compreso il consenso informato del paziente. A sostegno di questa conclusione vi è un altro argomento logico. Se il consenso informato, invero, fosse una causa di giustificazione, disciplinata dall’art. 50 c.p. oppure non codificata, la sua acquisizione da parte del medico sarebbe un onere, e non un obbligo. Infatti, l’onere è la situazione giuridica in cui si trova il soggetto che pone in essere una determinata attività nel proprio interesse, mentre la posizione giuridica dell’obbligo grava sul soggetto che deve tenere un determinato comportamento per realizzare un interesse altrui. Dunque, quando la persona che commette una lesione acquisisce il consenso della vittima, lo fa nel proprio esclusivo interesse, perché il consenso del danneggiato le consente di beneficiare dell’applicazione della causa di giustificazione ex art. 50 c.p. Diversamente, il medico che informa il paziente in ordine al rapporto costi-benefici del trattamento cui intende sottoporlo e ne riceve il consenso, agisce in adempimento di un preciso obbligo di informazione perché realizza non già il proprio esclusivo interesse, bensì il diritto del paziente di scegliere consapevolmente a quali terapie sottoporsi. Peraltro, il fatto che l’informazione e l’acquisizione del consenso siano uno obbligo, e non un onere, del medico è coerente con la natura contrattuale del rapporto medico-paziente. Conseguentemente, si parla di consenso inforamto come leges artis cui ogni medico deve attenersi. In questa prospettiva, la giurisprudenza parla di “autolegittimazione” della professione medica in considerazione del fatto che la prestazione del professionista rappresenta il mezzo per tutelare la salute del paziente, quindi, il mezzo mediante il quale concretizzare il diritto di quest’ultimo. Quindi il consenso sembra necessario non perché l’attività svolta dal professionista sia di per sé illecita, ma perché è illecita qualsivoglia attività che intervenga a limitare la libertà di autodeterminazione del soggetto riguardo gli atti che incidono sulla propria integrità fisica.
In allegato l'articolo integrale con note
Allegati