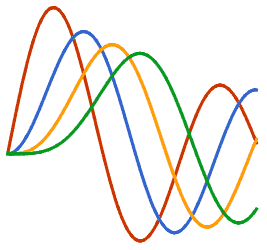- Redazione P&D - 01/03/2011
CONCORSO IN REATO E TENTATIVO: LA CONCRETA ASSUNZIONE DEI RUOLI ASSEGNATI - Riccardo MAZZON
In argomento, la Suprema Corte, sollecitata dalla seguente vicenda processuale
“il G.U.P., dopo aver premesso che l'univocità degli atti nella fattispecie tentata deve essere giudicata secondo il criterio oggettivo (e cioè senza tener conto della maggiore o minore chiarezza delle intenzioni degli imputati desumibili dalle intercettazioni telefoniche e da altre fonti di prova estrinseche rispetto alla condotta materiale), perveniva all'assoluzione dal delitto di tentata rapina escludendo l'univocità dell'azione degli imputati, e in particolare assumendo che l'azione non si era spinta a tal punto da manifestare per sè stessa, agli occhi di un osservatore esterno, la sua direzione finalistica verso la commissione del reato. Sosteneva altresì la presenza di elementi logici che facevano pensare che la rapina dovesse essere compiuta circa un'ora dopo l'intervento dei Carabinieri: le pistole non erano ancora state distribuite ai complici, le macchine "pulite" dei rapinatori erano ancora nei pressi dell'obiettivo, mentre una delle auto rubate era ancora parcheggiata lontano, e si sarebbe dovuta spostare nei pressi dell'ufficio postale da rapinare, il lasso di tempo di circa un'ora che poteva ipoteticamente stimarsi intercorrente tra gli arresti e l'orario programmato di commissione del reato spezzava il nesso di stretta contiguità cronologica tra le condotte accertate nel processo e il delitto, impedendo di configurare il tentativo. La pronuncia veniva appellata dal Procuratore della Repubblica, che chiedeva la condanna degli imputati in relazione a tutti i capi per i quali v'era stato proscioglimento, e dagli imputati condannati. Con sentenza 8 novembre 2005 depositata il 6 febbraio 2006 la Corte d'Appello di Perugia, in parziale accoglimento dell'impugnazione del P.M., dichiarava la penale responsabilità di tutti gli imputati per la tentata rapina, e inoltre la responsabilità del D.R.M., del D.S.A. e dello S.M. anche per i delitti di porto di arma clandestina e di ricettazione delle stesse armi, delitti per i quali il G.U.P. aveva pronunciato assoluzione per difetto dell'elemento psicologico. La Corte premetteva di aderire, non diversamente dal G.U.P., alla concezione oggettiva in tema di univocità della condotta nel reato tentato, ma precisava che la fattispecie concorsuale era connotata da una particolarità naturalistica della quale occorreva tener conto: la ripartizione di compiti tra i concorrenti era infatti tale da poter impedire che ciascuna delle condotte individuali, considerata isolatamente, apparisse univocamente diretta alla commissione del reato. Al fine di giudicare l'univocità degli atti ascrivibili agli imputati, occorreva perciò guardare all'insieme delle loro azioni coordinate, e non isolatamente a quelle di ciascuno. Tale impostazione del problema capovolgeva l'esito dell'analisi condotta dal G.U.P., poichè tutti i concorrenti avevano già intrapreso l'esecuzione dello specifico ruolo che avrebbero dovuto sostenere nel corso della rapina, e poichè il lasso di tempo che ancora separava i rapinatori dall'aggressione all'obiettivo non era comunque tale da far negare la sussistenza della prossimità logica e cronologica tra l'azione posta in essere e la parte conclusiva del piano. In ordine all'elemento soggettivo, la Corte d'Appello, oltre che evocare le intercettazioni dalle quali risultava chiaramente la programmazione della rapina, valorizzava anzitutto alcuni fatti oggettivi quali il porto delle armi e di un arnese da scasso (il marzabecco nel gergo degli imputati), la presenza nelle macchine di cappellini da baseball e di grosse buste intestate alle Poste Italiane che secondo il tenore delle intercettazioni dovevano servire ad indurre gli impiegati ad aprire la porta blindata, il fatto che lo S.M. avesse sostituito il cilindro d'avviamento della Uno rubata, cosa che non appariva compatibile se non con la consumazione del reato. Riguardo alle armi, la Corte riteneva che D.R.M., S.M. e D.S.A. dovessero rispondere degli stessi reati ascritti al F.G. che materialmente teneva le pistole in macchina (e cioè non solo il porto L. n. 895 del 1967, ex art. 4, ma anche il porto di arma clandestina L. n. 110 del 1975, ex art. 23 e la ricettazione), posto che, quand'anche si fosse a torto dubitato del dolo diretto, la loro responsabilità si sarebbe dovuta comunque affermare a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. Ciò posto, la Corte riuniva in continuazione i delitti contestati e condannava: - F.G. e S.M. ad anni 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa; - D.S.A. ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa; - D.R.M. ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa”
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO
e da motivi di ricorso così riassunti,
“contro la sentenza ricorrono a questa Suprema Corte i quattro predetti imputati, deducendo tutti l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà o illogicità di motivazione in relazione al tentativo, che erroneamente la Corte avrebbe ravvisato nello svolgimento dell'azione e nella condotta dei ricorrenti. In particolare, si censura la qualificazione come tentativo di condotte che non hanno realizzato alcun comportamento tipico, e che pertanto non hanno mai fatto trasmodare gli atti preparatori in un principio d'esecuzione; e si lamenta la mancata o errata considerazione di fonti di prova, quali l'intercettazione di un colloquio in carcere tra il F.G. e la moglie, nel quale l'imputato negava che il (OMISSIS) dovesse compiersi la rapina. Inoltre D.R.M., S.M. e D.S.A. deducono tutti violazione di legge e illogicità di motivazione in relazione alla loro ritenuta responsabilità per tutti i reati connessi alle armi, in quanto la relativa responsabilità penale sarebbe stata loro attribuita in forza di una deduzione logica inammissibile, e in mancanza di qualsiasi prova diretta della loro consapevolezza ed adesione all'azione tipica posta in essere dal F.G.. Il F.G. denuncia violazione degli artt. 56 e 133 c.p., avendo la Corte determinato la pena direttamente per la fattispecie tentata, senza fissare alcuna pena - base per il delitto consumato. Il D. S.A. lamenta difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Infine, il D.R.M. e il D.S.A. chiedono dichiararsi la nullità di tutto il giudizio d'appello, previa declaratoria d'inammissibilità dell'appello del P.M. ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10. Secondo il ricorrente detta norma doveva applicarsi anche ai procedimenti - come quello in questione - nei quali, al momento dell'entrata in vigore della norma, era stata già depositata la sentenza d'appello, ma non erano ancora scaduti i termini per il ricorso per Cassazione. Gli stessi due ricorrenti eccepiscono pure la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per la mancata notifica a tutti gli altri imputati degli appelli proposti da ciascuno di essi, e poichè il decreto di citazione a giudizio conteneva la sola indicazione dell'impugnazione proposta dal P.M., e non pure quella delle impugnazioni proposte dai coimputati. L'eccezione era stata già tempestivamente formulata dinanzi alla Corte territoriale, e da questa respinta. I ricorsi non sono fondati”
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO
(dove le questioni processuali hanno, peraltro, trovato rapida censura:
“questioni processuali. I ricorsi prospettano due tipi di questioni. Il primo non è più attuale, consistendo in un'interpretazione estensiva della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, che avrebbe dovuto determinare la declaratoria d'inammissibilità dell'appello del P.M., poichè all'epoca dell'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 il processo pendeva ancora dinanzi alla Corte d'Appello, benchè la sentenza di secondo grado fosse stata emessa e depositata. Sul piano costituzionale, tale eccezione non ha alcun fondamento, poichè non viola il principio di ragionevolezza, in relazione all'art. 3 ost., la discriminazione che il legislatore ritenga di instaurare tra situazioni processuali intrinsecamente differenziate dallo stadio in cui si trova il processo, anche quando tale discriminazione coinvolga la retroattività della lex mitior in materia penale (cfr., per un'articolata applicazione del principio, la sentenza Corte Cost. n. 393/2006 in materia di prescrizione). Peraltro si tratta di interrogativo non più utilmente proponibile, poichè l'intervenuta caducazione della L. n. 46 del 2006, artt. 1 e 10, ad opera della sentenza Corte Cost. n. 26/2007 la priva del proprio presupposto. La seconda questione deriva dal fatto che il decreto di citazione a giudizio in appello notificato agli imputati non conteneva cenno degli appelli proposti dagli altri coimputati, ai quali non erano stati mai notificati in precedenza, ma si riferiva al solo appello del P.M.. Il D.R.M. e il D.S.A. eccepiscono su tali basi la nullità del giudizio d'appello, ma l'eccezione non ha fondamento. In un regime processuale che ammette solo le nullità esplicitamente comminate, e che non prevede sanzioni per l'omessa notificazione dell'impugnazione alle altre parti, nessuna nullità può derivare da tale omissione, ma solo la mancata decorrenza del termine per proporre impugnazione incidentale. La giurisprudenza di questa Corte è assolutamente univoca e costante nella reiterata affermazione di questa regola (cfr., da ultima, Cass. Sez. 1^, sent. n. 48900 dep. il 19 dicembre 2003), sia con riferimento all'impugnazione proposta dal P.M. e non notificata all'imputato, sia con riferimento all'impugnazione del coimputato; per quest'ultima fattispecie, è stata addirittura esclusa in radice la necessità della notificazione quando l'impugnazione si fondi su motivi personali al coimputato che la propone, sicchè gli effetti della pronuncia non potrebbero in alcun modo riverberarsi sulla posizione degli altri (cfr. Cass. Sez. 3^, sent. n. 9344 dep. il 31 agosto 1994). Indipendentemente dal quesito se il caso concreto si inscriva in questa ipotesi, resta impregiudicato che l'omessa notifica non genera alcuna nullità, e che essa non potrebbe mai pregiudicare il diritto di difesa degli imputati, poichè nessuna esigenza di difesa può nascere dall'impugnazione del coimputato,mentre l'eventuale effetto estensivo favorevole si verificherebbe a prescindere dalla citazione in giudizio (cfr. Cass. Sez. 2^, sent. n. 9022 dep. il 3 ottobre 1997). E' sostanzialmente per questa stessa ragione che la mancata menzione degli appelli dei coimputati nel decreto di citazione a giudizio non può determinare alcuna menomazione dei diritti di difesa, poichè se rispetto a quegli appelli non poteva sorgere alcuna necessità di difesa, non poteva nemmeno prospettarsi la necessità di una separata vocatio in judicium, se questa non fosse stata imposta dall'appello del P.M. Conseguentemente,la mancata menzione delle impugnazioni delle parti private rimane del tutto irrilevante ai fini della validità della costituzione del rapporto processuale, e non importa alcuna violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c)”) ,
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO
è intervenuta con un'interessante pronuncia.
In particolare, i giudice di legittimità hanno precisato che, in tema di tentativo, ai fini del riconoscimento dell'univocità degli atti, può assumere rilievo, in determinate fattispecie concorsuali (senza per questo assurgere a generale massima di esperienza:
“configurabilità del tentativo. La premessa teorica alla quale si ispirano entrambe le sentenze di merito, consistente nel circoscrivere la "leggibilità" del tentativo al significato oggettivo delle azioni concretamente poste in essere dagli imputati, è del tutto corretta,e i risultati simmetricamente opposti ai quali esse pervengono non derivano da errori di diritto addebitabili all'una o all'altra, ma da differenti apprezzamenti del fatto. La sentenza impugnata ha ritenuto di enucleare una regola aggiuntiva per la riconoscibilità del tentativo in caso di reato concorsuale, sostenendo che dovrebbe sempre verificarsi l'assunzione del rispettivo ruolo da parte di tutti i concorrenti. In realtà un tale metodo d'analisi è vincolato a una serie di fattori non necessariamente ricorrenti nella totalità delle fattispecie plurisoggettive (es. preordinazione del piano con specifico affidamento dei ruoli, contestualità tendenziale delle azioni dei concorrenti), e perciò non suscettibile di essere elevato a criterio universale di giudizio. Inoltre, l'inquadramento degli atti in un piano preordinato contiene il pericolo di un rinvio all'elemento soggettivo che potrebbe contaminare il criterio rigidamente oggettivo al quale la Corte territoriale ha proclamato di volersi attenere, ed al quale effettivamente occorre attenersi”),
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO
l'avvenuta, concreta assunzione, da parte di tutti i concorrenti (cfr., amplius, "Il concorso di reati e il concorso di persone nel reato", Cedam 2011), del ruolo a ciascuno assegnato per la realizzazione del progettato delitto:
“cionondimeno, l'osservazione della Corte d'Appello circa l'avvenuta assunzione di ruolo da parte di tutti i concorrenti è indubbiamente in grado di qualificare talune fattispecie, attribuendo loro una speciale significatività ai fini della configurabilità del tentativo. Il comportamento di una pluralità di persone coerentemente diretto ad un unico fine è infatti altamente sintomatico, sul piano logico, dell'univocità degli atti richiesta dal tentativo, e quindi tale notazione,sebbene non costituisca regola universale di giudizio, conforta senz'altro la struttura argomentativa della sentenza impugnata, sottraendola alle censure d'illogicità cui è fatta segno dai ricorrenti. Va sottolineato peraltro che i motivi di ricorso si riallacciano tutti, più o meno esplicitamente, a una premessa non condivisibile, e cioè che non potrebbe aversi tentativo quando non sia compiuto almeno un frammento della condotta tipica; tale tesi non riscuote più credito da tempo remoto, sia per l'obiettiva difficoltà di individuare la condotta tipica nei reati a forma libera, sia perchè riecheggia la distinzione tra atti preparatori non punibili e atti esecutivi, che la disciplina codicistica si è proposta espressamente di superare. In realtà, la ricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera dell'art. 56 c.p., che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti. Il criterio individuato nella sentenza impugnata, dell'insieme delle azioni coordinate dei concorrenti, è utile nella misura in cui è in grado di sostanziare l'univocità dell'azione verso la consumazione del reato; non diversamente da quanto comunemente si ritiene per altri aspetti sintomatici come la brevità del tempo prevedibilmente intercorrente tra gli atti univoci e la consumazione del reato, ovvero per la contiguità spaziale tra il teatro del tentativo e quello della presumibile consumazione. L'unico criterio di ordine generale che sembra effettivamente contenere una serie notevole di nozioni descrittive, e che perciò può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità”
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO
Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato configurato il tentativo di rapina
“la sentenza impugnata rispetta tutti tali principi di diritto, e le sue conclusioni in ordine all'univocità degli atti costituiscono giudizio di merito che, indipendentemente dalla sua opinabilità, non è censurabile in sede di legittimità se sorretto, come è nella specie, da motivazione congrua e priva di errori logici. La Corte d'Appello valorizza elementi di fatto effettivamente acquisiti al giudizio (soprattutto, la presenza delle armi e di uno strumento da scasso, dei cappellini da baseball idonei al travisamento, la rimozione di una delle auto rubate mediante l'uso di un cilindretto d'avviamento) il cui significato, secondo un criterio di normalità logica, è effettivamente consonante con le conclusioni assunte dal provvedimento. Nè può ravvisarsi un elemento di contraddittorietà nella conversazione tra lo S.M. e la moglie in data (OMISSIS), intercettata all'interno del carcere di (OMISSIS), nella quale il ricorrente negava che il (OMISSIS) fosse in corso la rapina, perchè il complice D.S.A. aveva problemi familiari; in ossequio al più volte citato criterio oggettivo, la conversazione non può essere utile a decrittare l'univocità degli atti, ma rientra invece a pieno titolo nella discussione sull'elemento psicologico. Proprio questo capitolo della sentenza impugnata si vale di un materiale particolarmente ricco e significativo, poichè gli imputati erano da tempo soggetti a intercettazione e controllo, sicchè la lettura della conversazione tra lo S.M. e la moglie si inserisce in una serie coerente di elementi di giudizio, puntualmente indicati dalla Corte territoriale (precedenti sopralluoghi in coppie diversamente composte, furto delle auto, conversazioni tra gli imputati del (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)), che smentiscono la fragilissima protesta d'innocenza dello S.M. verso la moglie (il D.S.A. era effettivamente a (OMISSIS) con gli altri rapinatori, sicchè i suoi problemi familiari non erano dirimenti ai fini del delinquere). La conclusione della Corte territoriale sull'effettività del tentativo è quindi immune da errori di diritto, e affermata con motivazione priva di priva di smagliature logiche, che sfugge a tutte le censure proposte dai ricorrenti. Reati satelliti. I ricorrenti D.R.M., S.M. e D.S.A. contestano di dover rispondere della ricettazione e del porto delle due pistole custodite dal F.G. nel bagagliaio della sua automobile, sostenendo non esservi la prova della loro consapevolezza del fatto, e tantomeno quella di un loro contributo causale. Il motivo è manifestamente infondato, poichè la deduzione logica secondo cui i partecipi ad una rapina sono perfettamente al corrente delle armi portate dai complici non è affatto avventata, ma risponde anzi ad un criterio di assoluta normalità, nella cui contemplazione la giurisprudenza di questa Corte ha da sempre affermato che nell'ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia gli autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti basisti), rispondono anche del reato di porto illegale di armi. L'ideazione dell'impresa criminosa infatti comprende anche il momento rappresentativo dell'impiego delle armi (e quindi del porto abusivo delle stesse) per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato" ( Cass. Sez. 2^ sent., n. 1583 dep. il 17 febbraio 1982). Nel caso di specie la lettura della sentenza impugnata rende evidente che la condanna pronunciata per questi capi contro i ricorrenti può forse costituire applicazione di quel risalente principio rispetto al D.R.M., mentre per quanto riguarda S.M. e D.S.A. si fonda su positivi elementi di fatto (intercettazioni telefoniche) che evidenziano sia la consapevolezza dell'esistenza, delle caratteristiche e della destinazione delle armi, sia il positivo contributo causale alla commissione della condotta tipica da parte del F.G.. Discorso del tutto analogo è a farsi per la ricettazione, che i ricorrenti non contestano con argomenti diversi da quelli utilizzati per censurare la condanna per il porto di armi clandestine. In realtà, questi reati strumentali alla rapina non possono mai ritenersi estranei al compartecipe di essa, poichè costituiscono elementi essenziali del piano criminoso, la cui presenza, anche nel remoto caso in cui non siano stati oggetto di specifica informazione e discussione, rientra nel quadro fattuale che ciascun concorrente si prefigura quando consente alla partecipazione al reato - fine, sicchè matura anche rispetto ad essi il coefficiente psicologico richiesto dalla legge per l'affermazione della responsabilità penale. 4 - Determinazione della pena. Il ricorrente F.G. lamenta che la Corte territoriale abbia irrogato la pena fissandone la base direttamente per il reato tentato, senza determinare la quantità astrattamente irrogabile per il delitto consumato, sulla quale poi operare la diminuzione prevista dall'art. 56. c.p., per il tentativo. Il motivo è manifestamente infondato. Invero, per univoca e costante affermazione della giurisprudenza e della dottrina, nel delitto tentato va ravvisata una figura autonoma di reato, qualificata da una propria oggettività giuridica e una propria struttura, delineata dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e della disposizione contenuta nell'art. 56 c.p., la quale ha reso perseguibili fatti altrimenti non sanzionabili perchè arrestatisi al di qua della soglia della consumazione. Nel far ciò l'art. 56 c.p. ha stabilito una sanzione penale autonoma, ha individuato il bene giuridico protetto (costituito dal pericolo di lesione dell'interesse che giustifica la tutela penale) e, soprattutto, ha definito il comportamento tipico, consistente nel compimento di "atti idonei" diretti in modo non equivoco a realizzare la detta lesione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione discende che, in presenza di un delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, ossia senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", ossia scindendo i due momenti enunciati. Entrambi i sistemi, peraltro, non si sottraggono ai vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi. Solo l'inosservanza in concreto di tali limiti comporta violazione di legge (cfr. Cass., Sez. 2^, 11.3/31/5/1993, Bono ed altro). Nel caso di specie la pena - sinteticamente individuata - per il delitto tentato risulta contenuta nei limiti legali, e la generica censura di eccessività non coglie alcun vizio sanzionabile nel giudizio di Cassazione. Egualmente infondato è il motivo di ricorso col quale il D.S. A. censura la motivazione della Corte territoriale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, poichè il loro riconoscimento è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo; anche il giudice di appello - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante - non è tenuto ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (vedi Cass., Sez. 1^, sent. n. 6200 del 22 maggio 1992); nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva ai precedenti penali dell'imputato deducendone logicamente prevalenti significazioni negative della personalità. Tale argomentazione, pur nella sua sinteticità, è più che sufficiente a dar conto delle ragioni poste a fondamento della decisione, per le quali è stato respinto l'appello proposto dall'imputato sul punto. In conclusione, tutti i motivi proposti sono infondati, da che consegue di diritto, oltre che la reiezione del ricorso, la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali”
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO
in un caso in cui i concorrenti, in numero di quattro, erano giunti, già muniti di pistole, nei pressi di un ufficio postale, dopodiché tre di essi si erano disposti su altrettante autovetture, una delle quali rubata, predisposte per la fuga mentre il quarto si era diretto a piedi verso il predetto ufficio:
“F.G., D.R.M., S.M. e D.S. A. sono stati giudicati con rito abbreviato dal G.U.P. di Perugia per i delitti di tentata rapina, associazione a delinquere, porto di armi, porto di armi clandestine, ricettazione e furto. Con sentenza 20 dicembre 2004 tutti furono assolti dalla tentata rapina e dall'associazione a delinquere, mentre: - il F.G. e lo S.M. furono condannati per le armi, per la ricettazione e per i furti;
- il D.R.M. e il D.S.A. furono condannati per il solo porto di armi. I fatti dai quali il processo originava erano stati ricostruiti in modo sufficientemente puntuale, poichè i Carabinieri avevano seguito nei giorni precedenti al fatto, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti e altre attività d'indagine, l'attività degli imputati che si apprestavano a compiere una rapina. Conseguentemente, gli avvenimenti del (OMISSIS) si erano svolti praticamente sotto gli occhi dei militari, che avevano deciso d'intervenire solo quando avevano raggiunto la certezza soggettiva che la rapina programmata stesse in fase di esecuzione. Gli eventi d'interesse processuale possono così ricapitolarsi in estrema sintesi:
Il (OMISSIS) e il (OMISSIS) il F.G. e lo S.M. rubavano due Fiat Uno, che parcheggiavano in (OMISSIS) in due luoghi diversi della città, uno dei quali vicino a un ufficio postale. La mattina del (OMISSIS) il F.G., lo S.M., il D.R. M. e il D.S.A. partivano da (OMISSIS) con tre macchine diverse (lo S.M. su una Y10, il F.G. su una Ford Fiesta con due pistole nel bagagliaio e il D.R.M. e il D.S.A. su una Opel Astra noleggiata da G.. Giunti tutti a (OMISSIS) alle (OMISSIS), i quattro si dividevano: lo S.M. parcheggiava la Y10 e prendeva la Uno parcheggiata vicino all'ufficio postale, indossando guanti di pelle e recando seco un cilindretto d'avviamento con chiave contraffatta da inserire nella Uno rubata, F.G. e D.R.M. rimanevano alla guida della Ford e della Opel, mentre D.S.A. si allontanava a piedi verso l'ufficio postale. A questo punto dell'azione intervenivano i Carabinieri che procedevano all'arresto di tutti i predetti imputati, vincendo la resistenza di F.G. e il tentativo di fuga di D.R.M. che speronava con la Opel una macchina militare”.
Cassazione penale, sez. II, 20 marzo 2007, n. 18747 D.S. e altro Riv. pen. 2007, 10 9 Cass. pen. 2008, 2 605 (NOTA)nota FERRARO