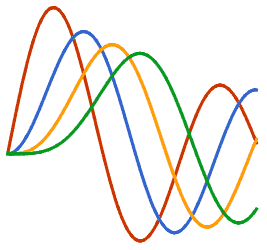- Redazione P&D - 07/02/2008
Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2008, n. 858, pres. Preden, rel. Bisogni – RISARCIMENTO PER INFORTUNIO IN PALESTRA
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e segg., 18, 22 e 38 c.c.. I ricorrenti ritengono legittima e fondata l’eccezione relativa alla incompatibilità della qualità di socio del Follatello con l’azione di risarcimento proposta. Fanno inoltre rilevare che la responsabilità potrebbe semmai farsi valere nei confronti dell’associazione, secondo la disposizione dell’art. 38 c.c., e non degli amministratori che potrebbero essere considerati tenuti nei confronti dell’associazione, secondo le norme del mandato, ma nella specie difetterebbe comunque la prova del conferimento di un mandato a verificare la pericolosità delle attrezzature in uso. Così come difetterebbe la prova della conoscenza da parte degli amministratori della necessità di un intervento sulla cyclette utilizzata dal Follatello il quale a sua volta avrebbe dovuto provare di non averne maldestramente regolato il sellino.
Sul punto la Corte di appello ha rilevato che "la domanda di responsabilità extracontrattuale può essere proposta anche da un socio contro colui che dirige un’associazione non riconosciuta ove il danneggiato ritenga che sia stato violato il principio del neminem laedere". La Corte ha quindi ritenuto il riferimento all’articolo 38 cod. civ. erroneo, riferendosi la norma alla responsabilità fideiussoria di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta rispetto ai terzi e trovando tale articolo applicazione nella responsabilità contrattuale.
Il riferimento all’art. 38 c.c., è sicuramente improprio in quanto tale norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (cfr. Cassazione civile sezione quinta, n. 5746 del 12 marzo 2001, Rv. 596612, secondo cui in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c., in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori, e trascende pertanto la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale) mentre nel caso in esame il Follatello ha agito sulla base di una responsabilità a contenuto extra contrattuale nei confronti dei responsabili dell’associazione e per l’omesso controllo sulla sicurezza degli attrezzi in uso nella palestra.
La pretesa incompatibilità fra la qualità di socio dell’associazione e quella di legittimato a proporre un’azione di responsabilità nei confronti dell’associazione rectius dei suoi amministratori) non trova giustificazione se non in base a una specifica assunzione di responsabilità degli associati per la gestione delle attrezzature che non è mai stata dedotta e tanto meno provata nel corso di questo giudizio. Su tale presupposto deve conseguentemente scindersi il rapporto di partecipazione all’associazione che è distinto e strumentale rispetto all’accesso degli associati all’utilizzazione degli impianti e delle attrezzature. Nel quadro di questo rapporto di utilizzazione (configurabile come un rapporto di prestazione di servizio) correttamente il Follatello è stato considerato pienamente legittimato ad agire per i danni conseguiti a un infortunio dipeso dalla pericolosità delle attrezzature in uso. Per altro verso però deve rilevarsi che la gestione di un’attività suscettibile di cagionare danni agli utilizzatori comporta degli obblighi di vigilanza a carico dei gestori corrispondenti ai principi dettati dal legislatore in materia di responsabilità extracontrattuale e che non possono essere derogati sulla base di un rapporto contrattuale. […]
Per quanto riguarda invece la dedotta erroneità nell’applicazione degli artt. 2051 e 2050 c.c., va rilevato che, come è noto, la responsabilità per le cose in custodia, cui la Corte di appello ha fatto riferimento, presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (cfr. Cassazione civile sezione III n. 15119 del 12 luglio 2006, Rv. 591212). Va inoltre ricordato che l’art. 2051 c.c., non esonera il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cassazione civile sezione III, n. 1602 del 5 aprile 2005, Rv. 583874) mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cassazione civile sezione III n. 2284 del 2 febbraio 2006, Rv. 586557).
Tutti questi elementi che integrano la prova della responsabilità per il danno prodotto da cosa in custodia e l’eventuale esenzione di responsabilità in favore del custode sono stati esaurientemente valutati dalla Corte di appello in relazione agli esiti dell’istruttoria svolta. In particolare la Corte nella motivazione ha dato atto dell’esito della prova testimoniale dalla quale è risultato che l’incidente, che si verificò mentre il Follatello stava usando una cyclette della palestra dell’associazione, fu causato dallo sganciamento del fermo del sellino che avveniva facilmente ed era successo altre volte. Inoltre la Corte di appello ha escluso che possa essere messo in dubbio il nesso causale fra l’incidente e il danno e in particolare ha escluso la rilevanza del fatto che il Follatello si sia allontanato normalmente dalla palestra dopo l’incidente poiché il tipo di danno provocato (versamento ematico) si produce in un lasso di tempo più o meno lungo, cosicché i segni della sua gravità si percepiscono solo a distanza di tempo.
Infine la Corte ha anche discusso nella motivazione la sussistenza della qualità di custodi della cosa in capo ai gestori e ha concluso per affermarla richiamando la giurisprudenza che, ai fini della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, ritiene custode della cosa, che possa presentare pericolo per chi la usa o ne viene in contatto, colui che esercita un potere di fatto su di essa.
Deve pertanto ritenersi che la motivazione della sentenza non sia affetta da contraddittorietà e insufficienza, sia in ordine alla qualificazione della responsabilità come responsabilità da cosa in custodia sia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’affermazione in concreto di tale responsabilità. Deve anche rilevarsi che la motivazione ha riscontrato l’esistenza di una serie di elementi probatori tali da far ritenere comunque integrata la responsabilità per attività pericolosa e quella generale ex art. 2043 c.c..