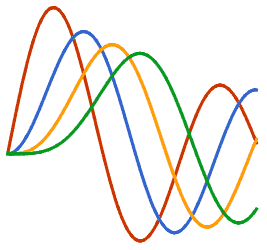Varie - Redazione P&D - 16/03/2017
La neolingua della buona scuola: valutazione, competenze, orientamento- Guido Pesante
Valutazione: ora, che valutare sia importante, che la pratica didattica non possa essere fondata sul genialismo spontaneistico, è ovvio, ma è di tutta evidenza che ormai la cultura della valutazione sta prendendo troppo spazio, sta diventando ipertrofica, sta mettendo fuori gioco l'idea che si debba operare in scienza e coscienza e non sotto il giogo del ricatto di una qualche sanzione.
Perché ciò accade? Perché stiamo scivolando nel regno della meta prassi, di una prassi valutativa della prassi? Perchè la scuola si sta trasformando in un ente certificatore?
Probabilmente per disciplinare un universo che, all'inverso, dovrebbe essere creativo ed eterodosso, come spetta al mondo intellettuale; probabilmente per aver occasione di innescare pratiche concorrenziali entro il corpo docente, nella rudimentale convinzione che ciò che – entro limiti – può andar bene in ambito aziendale, vada bene anche a scuola; ed altrettanto probabilmente per problemi di bilancio, come al solito: le risorse finanziarie mancano ed allora vanno distribuite con il massimo della accortezza; a chi? a chi è valutato positivamente. Si veda il caso dei progetti, ma anche il caso della retribuzione dei docenti che ormai non possono più ambire ad aumenti stipendiali generalizzati (né a generalizzati scatti di anzianità, quelli utili a raggiungere un livello pensionistico leggermente sopra il livello di sussistenza, lasciamo pur perdere la riproduzione). Probabilmente – lo dico con apertura di credito – per produrre "trasparenza", che farebbe rima con democrazia, se non fosse che, per eterogenesi dei fini, si produce, così, un mondo "totalmente amministrato", cioè privo di libertà.
E cosa vuol dire entrare nel regno della metaprassi valutativa?
Intanto che la prassi didattica – oggetto e soggetto del valutare- viene paralizzata: un po' dal timore di valutazioni negative, il cui esito non è la accuratezza del fare, ma la cautela nel fare; un po' dal fastidio di dover impegnare astronomiche quantità di energie nel lavorare prima e dopo il lavorare stesso, quel lavorare cui il lavoratore appassionato attribuisce effettiva importanza e per il quale soltanto è disposto a spendersi: ore e ore a preparare prove, griglie di correzione, misuratori di prodotto e di processo, ore e ore a correggere, a confrontare le correzioni, a calibrare e ricalibrare gli esiti: ore e ore che colonizzano, nel nome della coazione e del controllo, lo spazio dello studio e della produzione, trasmissione, condivisione di cultura.
In secondo luogo, che sparisce dalla attenzione ciò che non è valutabile in termini numerici, mentre acquisisce importanza esorbitante ciò che è mensurabile (è valso per la rivoluzione scientifica che parla di punti materiali, che parla di modellizzazione della realtà, ora, in una prospettiva chiaramente riduzionistica, vale per tutto).
Ma ciò che non è valutabile in termini numerici, è spesso ciò che conta: facciamo alcuni casi? La passione per la ricerca, la sensibilità estetica e filosofica, la finezza critica, la onestà intellettuale, la capacità di liberarsi e di liberare gli altri da pregiudizi...
In terzo luogo, ma sto soltanto articolando l'argomento, vuol dire che la burocratizzazione avanza con il suo portato di spersonalizzazione: è tipico della prassi burocratica uniformare (spersonalizzando) per poter misurare, ed allora l'eccedenza del singolo rispetto al generale, la particolarità del soggetto con la sua storia, le sue idiosincrasie, le sue speranze e delusioni, le sue potenzialità e le sue deficienze specifiche, viene drammaticamente occultata proprio dalla scuola che parla di personalizzazione dei percorsi.
Aggiungo, sul punto, che la pretesa di oggettività certificativa, porta a indulgere nella prova scritta, mentre, direbbe Platone, è nel dialogo orale che si fa crescere l'individuo
E sempre sul punto, aggiungo ancora che tale pretesa porta anche a frammentare la prova in unità minime di conoscenza e/o di competenza (più facilmente certificabili con indici e numerini), facendo smarrire la comprensione globale del discorso di apprendimento.
In quarto luogo, che si vive un'illusione: quella di poter fare a meno, oltrechè di ciò che non è mensurabile, anche della soggettività del giudizio: griglie, indicatori numerici, standardizzazione delle prove ecc. dovrebbero espellere il soggetto giudicante per sostituirlo con una specie di lettore digitale, di macchina computazionale. Poi si scopre, e qui l'illusione va in frantumi, che sarà pur vero che se, per esempio, la quantità di informazione viene giudicata "soddisfacente" allora la traduzione numerica sarà 7 (o 6, non importa) e che andrà sommata per poi dover venir divisa, moltiplicata, elevato al cubo, ecc. con altri valori, ma che l'attribuzione del grado di "soddisfacente" è, dopo tutto, irrimediabilmente, soggettiva.
In quinto luogo, che si sottovaluta che la scuola è un laboratorio a legami deboli (e ad elevata complessità olistica) , ragion per cui non si può pensare che ad un certo input corrisponda meccanicamente, come in fisica, un certo, stabilito , output, che, dunque, ad un certo impegno didattico corrisponda nei termini della mensurabilità percentuale, un certo esito d'apprendimento.
E, infine, che non si considera che la scuola è esperienza umana complessiva, che va vissuta anche con spontaneità come ogni altra esperienza umana significativa ed autentica, senza assoggettarla al giogo ansiogeno della valutazione onnipervasiva, che porta al learn and teach to test e alla ipercertificazione.
Tutto ciò per dire che la scuola non può essere sic et simpliciter assimilata ad un qualsiasi altro ramo della pubblica amministrazione ( e i problemi di valutazione del merito del personale scolastico stanno precisamente a dimostrarlo).
Per dirlo a chi, invece, vorrebbe compiere questa operazione - che è uno dei veri obiettivi della 107/2015 – a chi, cioè, ragioni nei puri termini di efficienza ed economicità.
Veniamo alle competenze: sembra che puntare sulla competenze discenda da obblighi comunitari: discende in realtà da una scelta culturale non neutra, molto in voga in ambiente anglosassone, di tipo pragmatistico: la verità del sapere si trova nella prassi, si misura con l'utilità del sapere stesso. E' appena il caso di rilevare che questa curvatura ragionativa implica un favore molto netto nei confronti delle discipline tecniche (per le quali la proiezione nella prassi appare naturale o comunque più agevole): ed è una curvatura, appunto, non neutra.
Anche in questo, comunque, è ovvio che una scuola di semplice buon senso non chiederà ai suoi studenti di ripetere mnemonicamente quanto detto dall'insegnante o quanto scritto sul libro (quasi che l'unica competenza degna di essere appresa sia quella della memorizzazione e della restituzione passive), ma vorrà che i suoi discenti sappiano fare "cose" e cosa fare con le conoscenze date. L'immagine dell'insegnante che chiede – esclusivamente - date e paradigmi è una banale costruzione polemica, senza riscontri altro che patologici, e la lotta contro il nozionismo è vecchia come il cucco.
Il problema è la piega integralistica presa dalla cultura della competenza: tale cultura, in parte prescrive, come sopra ricordato, l'ovvio (applicare il sapere), in parte ci proietterebbe in una scuola con il triplo del tempo a disposizione onde poter attivare una pratica didattica costantemente laboratoriale, in parte, ancora, è la cultura del generico (le competenze citate dai testi sacri della progettazione sono , inevitabilmente e tanto più inevitabilmente nella scuola non professionalizzante, estremamente vaghe; e del resto, ditemi, se non restassimo nel vago , come collegheremmo conoscenza impartita a competenza derivata? mi chiedo, ad esempio, che competenza verrebbe attivata dalla conoscenza della data di affissione delle 95 tesi alla porta della Cattedrale di Wittenberg, che competenza dalla conoscenza della teoresi parmenidea o della posizione di Marx sul socialismo utopistico, o... ). Ma non basta: la cultura delle competenze è cultura didattica dell'ineffabile giacchè le competenze sono difficilmente valutabili e non solo perché le prove di competenza che possiamo immaginare hanno indicatori di successo/insuccesso poco definiti, ma anche, se non soprattutto, perché le competenze maturano in tempi talora molto dilatati e lungo percorsi imprevedibili e talora estremamente soggettivi. Infine, tale cultura è epistemologicamente fallace e persino politicamente insidiosa: dire e ridire "competenze" rischia, infatti, per contrappasso, di svilire i contenuti, di farli apparire del tutto fungibili; ed è uno sbaglio, non innocente, perché solo i contenuti che siano "buoni in sé" possono promuovere curiosità e motivare la ricerca; e solo contenuti di spessore possono consentire l'esercizio delle capacità (o competenze, che dir si voglia) critiche: solo se possiedi una certa concettualità puoi ragionare, solo se hai termini di paragone, puoi valutare: se non possiedi conoscenze adeguate in materia di finanza, poi ti voglio vedere ad esercitare competenze analitiche, sintetiche, analogiche, cooperative e via dicendo, sugli andamenti economici delle quotazioni borsistiche .
Da ultimo diciamo qualcosa sull'orientamento: sì, d'accordo, la scuola deve essere capace di orientare per evitare che il ragazzo prenda strade sbagliate che gli farebbero perder tempo. Ma se veniamo a dire che ogni materia è orientante, nel dire una verità diciamo una colossale banalità perché prendiamo semplicemente atto del fatto che, nella vita, ogni esperienza è orientante, ovvero: di "tutto si fa tesoro", come sosterrebbe mia nonna; se invece pretendiamo di dire qualcosa di più specifico e cioè che le materie del liceo servono soltanto a prepararti all'università o alla professione, allora diciamo, una volta di più, qualcosa di fallace e di pericoloso al contempo: è infatti fallace il pensare che tutto ciò che studi abbia, o debba avere, finalizzazione fuori di sé, sia una semplice propedeutica a ..., e non possegga invece un suo valore intrinseco; ed è pericoloso perché porta alla emarginazione di materie che, fuori dalla scuola, non offrono sbocchi lavorativi o che tu non interpreti come tali da fornire sbocchi a te: si tratta, non occorrerebbe nemmeno sottolinearlo, di materie come la filosofia, ma, alla fin fine, dell'80% delle materie, a ben pensarci. Vissuta con questa ossessiva proiezione al dopo, del resto, buona parte dell'ultimo anno di corso, già pesantemente colonizzato dai test universitari, perde il suo sapore e diventa, nell'immaginario collettivo di studente e famiglie, come uno scivolo verso un (possibilmente redditizio) impiego; e meno lo scivolo fa attrito, come si sa, meglio è.
E viene a perdere il suo sapore buona parte della nostra formazione culturale assillata dalla domanda "a che serve?" da decodificarsi come "serve o no all'incremento del PIL?", in un appiattimento sull'efficienza produttivistica dell'oggi senza legame con un pensiero creativo di futuro, che fa davvero paura e che promuove un'intelligenza calcolistica nel silenzio di quella critica.
"Valutazione – competenze – orientamento" sono le parole chiave della neolingua della buona scuola e sono le punte d'iceberg (accanto ad altre come "scuola digitale" o "cultura d'impresa") di una burocrazia linguistica funzionale al potere, che crea discriminazioni tra chi le usa e chi no (esperti moderni ed inesperti arcaici), tra l'incentivabile e il non incentivabile, tra il disciplinato e il "contrastivo".
Parole ameba, dotate di forte connotazione, che evocano un sapere tecnico, ma non designano niente di particolare volendo designare tutto nei modi di un generico afflato efficientistico-economicista.
A questo punto, ricordiamo a cosa serve la neolingua nel testo di Orwell: serve a due obiettivi: serve a fornire gli strumenti per dar vita ad una certa visione del mondo molto fortemente caratterizzata, e serve a non pensare: molte parole vengono demonizzate ed espulse – "contenuti" si diceva, per fare un esempio - altre vengono invece promosse a slogan che aggirano ogni esame critico e che sfidano il paradosso: in 1984 troviamo "pace è guerra, ignoranza è forza, libertà è schiavitù"; nella buona scuola: "l'autonomia è controllo"(niente di più ossessivamente sottoposto a misura, e dunque a controllo, che la scuola della autonomia), "il sapere è ignorare" (niente di più inutile, in questa scuola, della riflessione pacata, lenta, profonda su materie dai contenuti "astratti", che infatti devono lasciar spazio a competenze concrete), "il futuro è il presente" (l'obiettivo della formazione è orientare verso l'inserimento piatto nel contesto di mercato): sono le parole e gli slogan che passo dopo passo, smottamento dopo smottamento, si stanno impadronendo della funzione insegnante.
Smottamento dopo smottamento, passo dopo passo: come avverte Chomsky, una delle tecniche più formidabili del controllo sociale è somministrare le soluzioni sgradite in dosi omeopatiche, per via di impercettibili aggiustamenti.
Credo sia compito degli intellettuali – e dunque, tra gli altri, degli insegnanti - produrre uno sguardo di lungo periodo che colga, nelle sue ragioni politiche e nelle sue condizioni storiche, l'albeggiare di tali aggiustamenti, e ne sveli il traguardo.